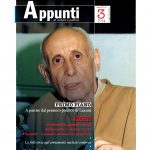Appunti 2_2012
FOCUS: FAMIGLIA OGGI: FRAGILITÀ, RISORSE, PROSPETTIVE
Al di là delle trasformazioni che l’hanno caratterizzata e la caratterizzano, la famiglia, a livello affettivo, relazionale, etico, economico, demografico, di cura, rimane l’unità fondamentale della vita quotidiana delle persone e della società: se, per un verso, sta mostrando sempre più fragilità, isolamento, autoreferenzialità, non ultima conseguenza della spinta alla sua privatizzazione attuata nel sociale, per altro verso mostra ancora una notevole vitalità, capacità di ri-orientarsi e di rispondere al sempre più crescente e profondo bisogno di relazioni autentiche e di legami significativi.
La famiglia e le sfide della società contemporanea
Elena Marta
Difficile oggi parlare di famiglia senza cadere nella retorica o nell’ideologia. Molte sono oggi le piazze, reali o virtuali, in cui, a diverso titolo, con diverse competenze, si discutono la definizione di famiglia e il suo ruolo. La difficoltà del tema e la molteplicità dei punti di vista trae origine dal fatto che stiamo parlando di un oggetto che tutti conosciamo – o pensiamo di conoscere – perché tutti ne facciamo e ne abbiamo fatto esperienza, ne abbiamo vissuto gioie e sofferenze: i desideri, le nostalgie, i rimpianti, i ricordi, positivi o negativi che siano, innegabilmente, senza che ce ne rendiamo conto, impattano su ciò che ci rappresentiamo di famiglia, su ciò che da essa vogliamo, su ciò che riteniamo siano i suoi compiti e le sue funzioni. A questo va aggiunto il fatto che le trasformazioni che la famiglia ha vissuto in questi anni l’hanno resa un oggetto poliedrico: pensiamo alle famiglie allargate, ricomposte, monoparentali, miste, immigrate.
Nella nostra società dei legami liquidi(1), dominata dalla frammentarietà del tessuto sociale, dall’isolamento e solitudine delle persone e delle famiglie, dove molte sono le sfide che rendono difficile la costruzione e la tenuta dei legami sociali e ridotto è lo spazio per l’incontro con l’altro, spesso percepito come qualcosa di minaccioso da cui difendersi o del quale appropriarsi per non esserne a propria volta fagocitato, proprio in questo contesto culturale ove sembra difficile pensare la «relazione», ossia ciò che lega le persone tra loro e dà senso alla vita, la famiglia si riconferma il luogo dove si compiono le prime esperienze sociali, dove s’impara il significato dell’aver cura delle relazioni(2). La famiglia è il primo luogo dove si può fare esperienza di solidarietà attraverso l’essere «l’uno per l’altro»(3) e può essere il contesto principale in cui coltivare la fiducia nei legami e nella comunità di vita.
Per questo, a mio avviso, oltre all’innegabile e importante funzione educativa e di crescita che da sempre la famiglia ha svolto, oggi essa può rappresentare un importante e insostituibile anello di connessione e di mediazione tra persona e comunità. È evidente che ciò accade se la famiglia diviene consapevole di questa sua forza e potenzialità e se intenzionalmente persegue questo obiettivo riuscendo a uscire dai propri confini, a interagire e mettersi in rete con le altre famiglie, non solo per risolvere problemi, ma anche per trovare spazi di senso, per costruire legami reciproci di scambio, fiducia e responsabilità che favoriscono l’aumento della qualità della vita per sé e per l’intera comunità, per le generazioni familiari e per le generazioni sociali, in una conversazione tra generazioni che valorizza e potenzia il proprium di ciascuno.
Il concetto di famiglia. Valori e sfide
Qual è il proprium della famiglia? Detto in altri termini, cos’è famiglia?
Nel rispetto della dignità e ricchezza di ogni persona, di ogni relazione affettiva, di ogni legame di coppia, con Scabini e Cigoli, definiamo famiglia quella specifica e unica organizzazione che lega e tiene insieme le differenze originarie dell’umano, quella tra generi (maschile e femminile), tra generazioni (genitori e figli) e tra stirpi (l’albero genealogico materno e paterno) e che vede nella generatività il suo proprium(4).
E quali sono le principali sfide che le famiglie oggi devono affrontare?
Mi pare che soprattutto due siano essenziali: una riguarda la relazione di coppia ed è la sfida di riuscire a costruire e rinnovare negli anni il patto di reciprocità, «cura del patto e cura della reciprocità»(5); l’altra riguarda la relazione genitori-figli e consiste nella sfida di costruire fiducia e trasmettere appartenenza, «cura responsabile»(6).
Partiamo dalla prima sfida. Nella cultura contemporanea, segnata dallo sfarinamento dei legami, dal paradigma della reversibilità e della sperimentazione, dal prevalere di un’interpretazione soggettivistica della vita e dei legami sociali che assume, a seconda delle circostanze, il volto dell’edonismo o del narcisismo o dell’intimismo, in cui vengono esaltate le prestazioni del singolo, il culto dell’«io» e delle capacità individuali, la difficoltà più evidente è la perdita della capacità – ma anche del desiderio – di mettersi in relazione, di stabilire legami, di tessere reti, in altre parole di andare incontro all’altro. L’alternativa sembra essere la costruzione di legami sociali strumentali, all’insegna dell’interesse, dello scambio di natura mercantile. In questo contesto, il valore fondamentale attribuito alla coppia è quello di vivere il sentimento e consumare emozioni, possibilmente intense. È questo un nuovo modo di far rivivere una visione contrattualistica del legame di coppia che pone, al centro, gli individui con i loro bisogni e diritti e, sullo sfondo, l’impegno verso l’altro e verso il legame.
Riuscire a costruire e rinnovare il patto di reciprocità significa mantenere alta la tensione ideale, sfidare le capacità umane con promesse come quella di vivere insieme nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, capaci di ritagliare uno spazio «sacro» che travalica il transitorio e il presente. Si tratta di vivere il legame «per sempre» in senso dinamico, ossia mirando in avanti, traguardando il dolore del vivere, con la speranza di poter rinnovare il legame nel corso del tempo. Il patto di coppia vive, così, di una continuità di fiducia amorosa nella relazione (aspetto affettivo) che si combina con una continuità d’impegno, di rispetto e adempimento di ciò che si è promesso (aspetto etico).
È nell’esperienza di tutti comprendere e aver sperimentato che l’ideale nasce, non senza fatica, da un processo di idealizzazione di cui l’innamoramento è il segno più evidente. Nella fase di innamoramento, il più delle volte molto passionale e erotica, viene esaltata la somiglianza con l’altro e sottovalutata la diversità con questi: all’altro vengono attribuite enfaticamente caratteristiche tutte positive e, su questo, nasce e si struttura l’incontro tra i due. Nella dinamica del legame, però, la fase di innamoramento è destinata ad affrontare il fenomeno della delusione, cioè della caduta degli aspetti illusori attribuiti all’altro. E in questa dinamica si colloca uno degli aspetti specifici della nostra cultura. La delusione è oggi particolarmente acuta perché, nel mondo attuale, il rapporto di coppia viene investito di alte quanto irrealistiche aspettative: dall’altro ci si aspetta comprensione e sintonia su tutti gli aspetti della vita. La caduta dei tratti illusori è un grande momento di verità della relazione: apre alla possibilità che nasca il legame in senso pieno e maturo, cioè come ciò che lega, tiene insieme, differenze oltre che somiglianze, oppure che il legame vada perduto. In questo passaggio dall’innamoramento all’amore i partner sperimentano colpa e aggressività reciproca, accusandosi l’un l’altro di non essere all’altezza delle proprie immaginate aspettative. La coppia, a questo punto, si trova a un bivio: può «scegliere» il legame e farlo crescere oppure può non riconoscerlo e abbandonarlo.
Come ci ricordano Scabini e Cigoli(7), per ri-scegliere effettivamente e non formalmente il legame occorre avere il coraggio di percorrere un lungo viaggio di conoscenza e di comprensione di sé e dell’altro, di tanti aspetti sconosciuti – propri e altrui – che possono sorprendere e sconcertare. Occorre avere il coraggio di avventurarsi in processi di perdono di sé e dell’altro e potersi così riconciliare. È importante che entrambi i coniugi, o almeno uno dei due, siano disponibili a quel lavoro psichico di comprensione che riesce a far emergere gli aspetti costruttivi e positivi della relazione, pur entro la consapevolezza realistica delle proprie e altrui debolezze, mancanze ed errori.
Ciò è possibile solo se si dà valore al legame, se si riconosce che il legame merita impegno, dedizione, cura e persino sacrificio. In questi casi, gli errori e i difetti altrui non vengono amplificati, ma letti per quel che sono e divengono oggetto di riflessione, accanto ai propri comportamenti, ai propri difetti e alle proprie mancanze. Alla riflessione segue l’impegno per il cambiamento, a cui spesso si accompagna una vena ironica: è buon segno quando nella coppia si colgono difetti e debolezze di sé e dell’altro ma non li si attacca, piuttosto se ne sorride. La riconciliazione e il perdono sono possibili solo attraverso il riconoscimento dell’altro sia a livello cognitivo, ovvero scoprendo nuovi aspetti dell’altro, sia a livello emotivo, ossia impegnandosi in un processo di apertura verso l’altro che può dar luogo alla gratitudine, alla sorpresa, alla riconoscenza. Ri-conoscere, conoscere di nuovo l’altro, significa vederlo nella sua unicità, con i suoi limiti e i suoi pregi, implica rivisitare e comprendere la sua storia, come anche rivisitare la propria e farne una nuova e più matura conoscenza, per costruire una nuova storia condivisa.
L’altro aspetto del rischio che le coppie vivono oggi è dato dalla diffusione del mito auto-generativo, che consiste nel pensare di essere un inizio assoluto, nel non riconoscere le proprie radici, nel sottovalutare i vincoli psichici con le generazioni precedenti. È necessario, invece, ancora oggi ricordare che in ogni nuova coppia si incontrano e scontrano due storie familiari con i saperi delle rispettive comunità di appartenenza. La cura del legame, nelle sue componenti affettive ed etiche, passa necessariamente attraverso sia il riconoscimento della differenza dell’altro che del legame con lui/lei e attraverso la rivisitazione realistica delle proprie storie familiari. La coppia è, infatti, chiamata a costruire uno stile di rapporto coniugale e genitoriale nuovo e originale a partire dalla consapevolezza delle proprie e altrui radici familiari.
La forza o la debolezza della coppia dipende, in gran parte, dall’impegno etico-affettivo nel prendersi cura del legame con l’altro, nel costruirlo pazientemente e nel saperlo rilanciare dopo ogni prova. Se c’è la cura del legame coniugale può esserci generatività, può trovare spazio il figlio, come frutto della coppia e della sua storia. In presenza di un legame di coppia fragile è il figlio che istituisce la coppia e non la coppia che genera.
Aspetti affettivi e aspetti etici, presupposti essenziali nella cura dei figli
Con la comparsa sulla scena della generazione dei figli, ecco proporsi l’altra sfida che ritengo cruciale nelle famiglie, oggi. Nella nostra cultura, ancora fortemente puero-centrica, l’asse della relazione genitori-figli si è pericolosamente spostato sugli aspetti di sentimento, sugli aspetti affettivi, a discapito di quelli etici. Il figlio non viene riconosciuto come frutto della relazione di coppia e, nel contempo, eccedente tale relazione, come presenza nuova che chiede di essere nutrita materialmente e simbolicamente, che chiede di essere iscritta nella storia delle generazioni. Oggi i figli, pochi e scelti, caricati di notevoli aspettative e vissuti come una sorta di concentrato emozionale, corrono il rischio di essere concepiti come un modo di realizzazione dei genitori che tendono a rispecchiarsi in loro. È esemplificativo, a questo riguardo, il gioco di rispecchiamento tra genitori e figli giovani-adulti, con-causa della permanenza di questi ultimi nelle famiglie d’origine ben oltre i trent’anni, anche dopo avere acquisito l’autonomia economica e avere costruito una relazione affettiva stabile.
Come far fronte a questa situazione? Attraverso il prendersi cura responsabile dei figli, ossia in primo luogo garantendo la presenza sia di una funzione materna, legata soprattutto al polo affettivo, sia di una funzione paterna, legata soprattutto al polo etico. Vale la pena di sottolineare che, se è vero che la funzione materna è culturalmente più vicina alle figure femminili e quella paterna a quelle maschili, è anche vero che queste sono funzioni di cui entrambi i genitori, madre e padre, si devono far carico.
La funzione materna consiste nel far nascere, offrire calore, affetto, supporto: il bambino viene alla luce dalla madre e ne riceve il primo nutrimento. Perché si costituisca come «io», con una propria identità, è necessario che, attraverso il nutrimento e l’attenzione ai bisogni che il bambino mostra nella sua crescita, passi la fiducia amorosa. Crescendo, questa speranza di bene nel legame sarà una risorsa fondamentale cui la persona potrà attingere per stringere rapporti, per godere delle relazioni, per contrastare l’angoscia, per superare le esperienze di inganno, di tradimento e le manchevolezze che pure non mancheranno. In questo si colloca il nocciolo del dono-compito materno: far sì che la fiducia possa vincere sulla sfiducia.
La funzione paterna è, invece, quella di fare da mediatore con il sociale, di ergersi quale rappresentante e difensore della Legge, quale dispensatore di giustizia(8), donatore di senso, accompagnatore nel labirinto di crescita dei figli, indicando, assumendosene i rischi, «la via buona» e mettendo in guardia da quella pericolosa o sbagliata(9). A lui è chiesto di conservare e tramandare il patrimonio materiale e morale: egli è simbolicamente il custode del codice etico, di rispetto della giustizia, e della lealtà che si esprime nei valori, nelle norme educative, nelle tradizioni da custodire e alimentare. Fa parte della funzione paterna «traghettare» i figli dalla famiglia alla comunità sociale e trasmettere appartenenza, ove con questo termine si intende sia essere riconosciuti e legittimati, insieme ai propri fratelli, come figli di quei genitori, sia sentirsi parte di una storia che si perde nelle generazioni, poter accedere all’albero genealogico materno e paterno. La famiglia è una comunità di generazioni che collega vivi e morti, generazioni presenti, passate e a venire.
Dalla generatività parentale alla generatività sociale
La responsabilità dei genitori nei confronti dei figli si traduce nel mantenimento di un legame gerarchico: a tale riguardo, si parla di responsabilità nel senso che spetta alle generazioni adulte rispondere, assumendosi i relativi rischi, delle condizioni materiali, morali e psichiche in cui sono messe le generazioni successive, almeno finché queste saranno in grado di rispondere di sé. E qui si colloca una grossa sfida per i genitori odierni. La figura del genitore-amico, oggi così diffusa, è un modo per evitare l’aspetto etico della cura: in questo modo, anche la potenza del prendersi cura viene banalizzata in atteggiamenti a ogni costo protettivi e accondiscendenti. Ne è prova l’incertezza dei genitori ma anche degli educatori in genere quando si tratta di stabilire un confine tra bene e male, quando si tratta di prendere decisioni sul dare limiti e regole. Ciò che è in gioco, al di là della comprensibile difficoltà dei genitori di trovare, in un mondo così confuso, soluzioni e comportamenti appropriati per ogni singolo figlio, è l’idea stessa di una direzione della crescita, della necessità di accompagnare e lanciare in avanti le giovani generazioni, perché possano raccogliere il testimone del senso profondo della famiglia, riscriverlo con propri accenti e ritrasmetterlo alle generazioni a venire. Ritroviamo qui i tre processi della generatività, proprium della famiglia: dare vita, curare e lasciare andare/lasciar spazio(10).
La generatività consiste essenzialmente nella capacità di cura, che a sua volta «consiste nell’interessamento in costante espansione per ciò che è stato generato per amore, per necessità o per caso e che supera l’adesione ambivalente a un obbligo irrevocabile»(11) e che «comporta sempre la possibilità di compiere un energico salto verso la produttività e la creatività al servizio delle generazioni»(12).
In altre parole, la generatività è «l’interesse e l’impegno a promuovere la generazione successiva, attraverso la genitorialità, la guida e l’orientamento e generando prodotti e risultati che hanno lo scopo di beneficiare i giovani e promuovere lo sviluppo e il benessere degli individui e dei sistemi sociali che sopravvivranno a sé»(13). Nella sua essenza, la generatività coincide con «la trasmissione intergenerazionale di ciò che ha valore»(14). La più ovvia e naturale espressione della generatività è la cura dei genitori nei confronti dei propri figli. Ma la generatività può esprimersi in diversi modi, per esempio attraverso forme di insegnamento, mentoring, gestione in maniera adeguata della leadership, assunzione in senso pieno della cittadinanza attiva(15). L’adulto generativo è colui che cerca di restituire alla comunità di appartenenza qualcosa di quanto ha ricevuto nella vita e di «rendere migliore» il mondo non solo per sé o per i propri figli, ma, in generale, per le generazioni future. In altre parole, l’adulto generativo è colui che incanala la generatività parentale in generatività sociale, che si esprime nella presa in carico della generazione dei giovani. Essa contribuisce al rafforzamento e alla continuità delle generazioni, in quanto fornisce guida e direzione, e si prende carico della crescita e del benessere non solo dei propri figli, ma anche degli altri giovani che appartengono alla medesima generazione di questi ultimi.
Dollahite, Slife e Hawkins definiscono la generatività proprio come la «responsabilità morale di legarsi-a e di prendersi cura-di la nuova generazione»(16). Nella loro prospettiva, la generatività è un concetto intrinsecamente familiare, intergenerazionale, relazionale e comunitario: sebbene la generatività includa anche moventi e azioni individuali, rende saliente in particolare l’azione collettiva e cooperativa, perché essa risiede nelle relazioni tra le generazioni. La generatività familiare è un intreccio di legami, convinzioni, impegni, scelte e capacità che devono essere alimentate continuamente e assiduamente. Essa è intrinsecamente spirituale, perché richiede che si trascendano l’egoismo e le esigenze contingenti, le «attrazioni e le distrazioni» della propria generazione.
Mc Adams e de St. Aubin ben illustrano il possibile trasferimento della generatività dall’ambito familiare a quello comunitario. Da un punto di vista psicologico, la generatività è mossa da «un bisogno profondo di immortalità genetica e di nutrimento comunitario»(17), mentre da un punto di vista sociale essa è una risorsa critica «che può motivare i cittadini all’impegno per il bene comune, incentivare gli sforzi per mantenere la continuità e favorire il cambiamento sociale»(18). Cruciale è così l’investimento delle generazioni adulte nel trasmettere il loro patrimonio valoriale alle generazioni giovani.
E, in questo, il ruolo della famiglia è cruciale. Possiamo affermare che per un trasferimento positivo sul sociale della generatività e della responsabilità generazionale occorre averne fatto la prova in famiglia.
Come ben affermano Scabini e Cigoli: «Quando il senso del legame tra le generazioni, che si apprende in famiglia, diventa cura responsabile del futuro della società, il movimento dalla famiglia alla comunità è all’insegna di un processo generativo. Al contrario, esperienze confuse e rapporti distorti tra le generazioni familiari producono facilmente patologia sociale e in questo caso il movimento dalla famiglia alla comunità è all’insegna di un processo degenerativo»(19).
Diventa allora ancora più chiaro perché all’inizio di questo contributo abbiamo affermato che, nel contesto contemporaneo, la famiglia si pone quale medium potente tra la persona e la comunità: essa è luogo primario di apprendimento dei legami, costruzione dell’identità, prodotto emergente dei legami primari.
Tra la famiglia e la comunità si sviluppa un legame bidirezionale, di reciproca influenza, dove il benessere/malessere personale si riconnette alla matrice vuoi familiare vuoi antropologico-comunitaria(20). Pensiamo, ad esempio, ai fenomeni di mafia e alla commistione tra codici familiari e organizzazioni malavitose. Ma possiamo pensare al fenomeno dell’immigrazione e al complesso intreccio nella famiglia immigrata della cultura della comunità ospitante e della cultura delle origini. Ma, ancora, possiamo riflettere sulle molte e più comuni interazioni tra la famiglia e il corpo sociale, che non è affatto un ambiente generico ma un corpo organizzato in senso generazionale e strutturato in «luoghi» (network relazionali, scuola, vicinato, organizzazioni varie…), con i quali è possibile attuare scambi reciproci che possono essere positivi o negativi, frutto di dinamiche generative o degenerative.
Così, quando tra generazioni familiari e generazioni sociali vi saranno scambi virtuosi, il rapporto tra famiglia e comunità sarà di reciproco arricchimento, quando la logica tra famiglia e comunità sarà all’insegna della scissione o della prevaricazione, l’esito sarà l’anonimato e la povertà relazionale(21).
Rapporti virtuosi tra famiglia e comunità
Quello che vogliamo qui proporre è una lettura della famiglia e della comunità cui essa appartiene secondo un’ottica intergenerazionale, ancora piuttosto infrequente, ma assolutamente necessaria, poiché si tratta di due organizzazioni in continua osmosi attraversate dai medesimi processi generativi e degenerativi, che oggi più che mai contribuiscono al benessere e al malessere delle persone e sono strettamente connesse. Ciò risulta molto chiaro se riconsideriamo, per esempio, la condizione del giovane-adulto, frutto di rapporti di eccessiva protezione all’interno della famiglia e di rapporti che sono all’insegna della competizione, dell’ingiustizia e della respinta nel contesto sociale(22). Le generazioni si presentano così contrapposte nel sociale. La transizione dal familiare al sociale per i giovani si pone, oggi, in termini di contrapposizione, scissione, difficoltà, piuttosto che nei termini di un possibile trasferimento di capitale umano e sociale acquisito in famiglia da spendere nella più ampia comunità. Ciò che qui è in gioco non è solo la positività degli atteggiamenti pro sociali dei genitori come fattori di una buona socializzazione dei figli, ma proprio la possibilità/capacità di trasferimento del capitale familiare in capitale sociale(23). Le ricerche che abbiamo condotto in questi anni con giovani-adulti volontari e i loro genitori(24) hanno posto in evidenza come questo trasferimento sia facilitato laddove una porzione di sociale è «bonificata» attraverso una relazione virtuosa tra famiglia e comunità innestata, per esempio, dall’impegno delle famiglie stesse nel volontariato o in atteggiamenti di apertura pro sociale in generale: queste famiglie hanno già in qualche modo «bonificato» una porzione del sociale, quella rappresentata dalle organizzazioni di volontariato. La possibilità del trasferimento passa attraverso la libertà dei soggetti (persone o organizzazioni) di offrire e accettare le reciproche risorse, ma anche attraverso il modo dell’offerta, che non è ultima variabile nel produrre apertura e cooperazione, invece che chiusura e competizione. L’attività volontaria è una grande mossa di apertura, perché il volontario che si rende disponibile con ciò stesso dichiara di vedere non solo il bisogno dell’altro ma soprattutto il proprio abbisognare dell’altro. Da questo punto di vista, la modalità di offerta volontaria può sortire effetti imprevisti, come quelli di risvegliare nell’altro una domanda di senso e di aiuto, domanda così spesso di difficile esplicitazione soprattutto da parte di chi è in stato di sofferenza. La famiglia che pratica una pro socialità eccedente i propri confini, con ciò dichiarando vuoi abbondanza, vuoi povertà, è nella condizione migliore di farsi partner delle domande dell’altro e, con ciò, favorire condizioni di mutuo trasferimento di capitale umano e sociale dal proprio interno alla comunità.
È evidente però che, una volta messo in atto, tale processo deve essere curato, nutrito, sostenuto, in quanto non è affatto remota né la possibilità che la «pro socialità familiare» veda battute di arresto o irrigidimenti al proprio interno tali da rendere difficile lo scambio con la comunità di appartenenza, né la possibilità che il contesto sociale, rispondendo a una logica mercantile e poco generativa, di fatto ostacoli il trasferimento del capitale familiare nel sociale.
Pertanto, la famiglia va aiutata a impegnarsi a mantenere con la comunità di appartenenza scambi continui, volti a evitare una scissione assai pericolosa tra famiglia e società e tra «parti ritenute buone della società» e «parti ritenute meno buone della società» e dal canto suo la comunità, o almeno alcune sue parti intermedie, devono promuovere e favorire processi generativi.
In termini di intervento psico-sociale, questo porta a pensare alla promozione dei legami e della qualità della vita delle famiglie e della prevenzione del disagio, non solo della riparazione di situazioni difficili.
I disagi nella «normalità». Strategie e interventi
Ciò che disorienta molti operatori e lascia i servizi spesso impreparati è che occorre occuparsi non solo delle famiglie multi-problematiche ma anche delle famiglie cosiddette «normali», oggi alle prese con problemi sinora inediti, di difficile decifrazione e sconcertanti. Il disagio che vivono oggi le famiglie sembra non esser più comprensibile alla luce delle vecchie categorie. Come ben illustra Gino Mazzoli, è in forte aumento l’area del disagio «invisibile», che riguarda famiglie o alcuni membri – ma sappiamo che la difficoltà di ciascun membro familiare ha effetti sull’intera organizzazione – ad affrontare adeguatamente le transizioni «normative» e i connessi compiti che nel passato recente erano in certo modo standardizzati e che ora sono più gravati da incertezza e da itinerari meno specifici. «È in costante crescita la fatica delle famiglie, sulle quali la struttura della vita sociale e la precarietà del mercato del lavoro scaricano problemi che rendono complicate operazioni un tempo naturali: educare i figli, conciliare lavoro e affetti, sostenere i carichi familiari […] L’area della “normalità” è oggi quella che con più intensità sembra accusare i contraccolpi delle trasformazioni socio-economiche in atto. Affannata nel presente, disorientata verso il futuro, denuncia un malessere importante, acuito da una sensazione diffusa di isolamento rispetto al contesto sociale. Le famiglie vivono infatti spesso in solitudine questa fatica “non vista” e “non riconosciuta”»(25).
In termini di interventi, occuparsi di questo disagio invisibile significa spostare risorse in quest’area della normalità per favorire la costruzione di reti di solidarietà, le rigenerazioni di legami che, innestando un circolo virtuoso, possono incrementare la quota di risorse presenti nelle famiglie, contribuire a costruire una comunità più «abitabile» e così prevenire situazioni di disagio e di problematicità.
Quest’obiettivo è raggiungibile non solo e non tanto con interventi specialistici, ma soprattutto facendo leva sulle risorse delle famiglie. Esperienze che creano convergenze e aggregazione tra le famiglie hanno un grosso valore, perché in un’epoca di «passioni tristi»(26), di frammentazione, solitudine e autoreferenzialità il bisogno di legami e il loro valore restano, anzi sono ancora più forti e vanno soddisfatti. «Le famiglie continuano a rappresentare, inoltre, un luogo privilegiato di elaborazione e generazione di sociale là dove, spinte da bisogni e attraversate da inquietudini, interagiscono con altre famiglie, uscendo dai propri confini, non solo per affrontare problemi, ma anche per trovare spazi di convivialità e di senso, per costruire legami reciproci che tendano ad aumentare la qualità della vita riappropriandosi di quella cultura della mutualità e della reciprocità informale che già appartiene loro»(27). Per far fronte ai disagi moderni occorre ripartire dai legami familiari e comunitari, rinforzandoli e operando attraverso interventi di rete co-progettati con i protagonisti stessi degli interventi, perché «anche qualora vi fossero i fondi sufficienti per istituire nuovi servizi, costruire nuove forme organizzative non co-progettate con la gente rischia di colludere con quella diffusa spinta alla delega e alla rivendicazione che finisce con il nascondere il fatto che le persone verso la comunità non hanno solo diritti, ma anche doveri, e che l’esercizio della solidarietà, da sostenere con grande discernimento e consapevolezza delle ambivalenze e dei conflitti che vi si annidano, è oggi l’unica via per dare un nome e gestire i nuovi problemi che si stanno presentando»(28).
1 Cfr. Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari 2001.
2 Cfr. R. Iafrate, A. Bertoni, Rilanciare l’identità della famiglia per renderla protagonista nella comunità: i Percorsi di Promozione e Arricchimento dei Legami Familiari, in «Psicologia di comunità», 2007, 1, pp. 95-116.
3 V. Iori, Etica della cura e reti informali nel welfare territoriale, in «Animazione Sociale», 2005, 12, pp. 50-61.
4 Cfr. E. Scabini, V. Cigoli, Il famigliare, Cortina, Milano 2000.
5 Ibid.
6 E. Scabini, R. Iafrate, Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 2003.
7 Cfr. E. Scabini, V. Cigoli, Il famigliare, cit.
8 Cfr. V. Cigoli, Intrecci familiari, Cortina, Milano 1997; E. Scabini, V. Cigoli, Il famigliare, cit.
9 Cfr. G. Pietropolli Charmet, I nuovi adolescenti, Cortina, Milano 2000.
10 Cfr. E. de St. Aubin, D.P. Mc Adams, T.C. Kim (Eds.), The generative society: Caring for future generation, APA Books, Washington 2004, pp. 221-237.
11 H. Erikson, Childhood and society, Norton, New York 1950, trad. it.: Infanzia e società, Armando, Roma 1968, p. 72.
12 Ibid.
13 E. de St. Aubin, D.P. Mc Adams, T.C. Kim (Eds.), The generative society: Caring for future generation, cit., p. 266.
14 Ibid.
15 Cfr. D.P. Mc Adams, The redemptive Self, Oxford University Press, Oxford 2006 .
16 D.C. Dollahite, B.D. Slife, A.J. Hawkins, Family generativity and generative counselling: Helping families keep faith with the next generation, in D.P. Mc Adams, E. de St. Aubin (Eds.), Generativity and adult development, APA Books, Washington 1998, pp. 449-481.
17 D.P. Mc Adams, E. de St. Aubin (Eds.), Generativity and adult development: How and why we care for the next generation, APA Books, Washington 1998.
18 Ibid.
19 E. Scabini, V. Cigoli, Il famigliare, cit., p. 38.
20 Cfr. E. Scabini, E. Marta, M. Lanz, Transition to adulthood and family relations: An intergenerational perspective, Psychology Press, London 2006.
21 Cfr. E. Scabini, V. Cigoli, Il famigliare, cit.
22 Cfr. E. Scabini, E. Marta, M. Lanz, Transition to adulthood and family relations: An intergenerational perspective, cit.
23 Cfr. E. Scabini, E. Marta, Quando e come le famiglie generano comportamenti pro sociali nei figli, in P. Donati, Famiglia e capitale sociale nella società italiana, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2003, pp. 156-194.
24 Cfr. E. Marta, E. Scabini, Giovani volontari, Giunti, Firenze 2003; E. Marta, M. Pozzi, Psicologia del volontariato, Carocci, Roma 2007.
25 G. Mazzoli, N. Spadoni, Attivare la generatività delle famiglie nella comunità, in «Animazione Sociale», 2005, 6/7, pp. 32-65.
26 M. Benasayag, G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2004.
27 L. Bianco, Lo sviluppo locale di reti di famiglie, in «Animazione sociale», 2006, 5, p. 31.
28 G. Mazzoli, N. Spadoni, Attivare la generatività delle famiglie nella comunità, cit., p. 39.
.
Ragioni e regioni della fragilità della famiglia
Carlo Mario Mozzanica
Introduzione
La fragilità della famiglia è oggetto – in molte e variegate occasioni, soprattutto in questa stagione – di analisi, di studi e di approfondimenti. La sua sovraesposizione propizia le forme che esitano, inesorabilmente, in una qualche successiva e conseguente deriva: ideologica, pietistica, riduzionistica, settoriale e dunque, alla fine, con lo scontato esito di diventare retorica. Sono molto differenziati gli studi che rubricano le regioni della fragilità; un poco più scarsi quelli che indagano le ragioni della fragilità, guardando soprattutto alle condizioni strutturali e funzionali dello scenario socioculturale postmoderno e alla crisi entropica, sistemica e non solo dialettica(1) che attraversa il nostro tempo. È a questi indicatori che vorrei fare riferimento, essendo personalmente convinto che, più che la famiglia in quanto tale, sia in crisi il soggetto, visti gli insulti, spesso subdoli e carsici, che la stagione postmoderna assegna e consegna inesorabilmente alla persona: se va bene, essa è considerata cittadino, altrimenti, anche al di là di ogni affermazione retorica, diventa cliente, utente, consumatore, acquirente, turista, elettore, figlio di un pensiero telecomandato. L’accento differenziale – tra ragioni e regioni – vuole significare e tradurre la qualità antropologica della famiglia. Si tratta, dunque, di segnalare e di segnare la differenza, non la distanza, tra il molteplice e variegato articolarsi delle diverse «forme familiari». Forse occorre invertire gli addendi: come la famiglia fragile può essere forza di rinnovamento? Come la famiglia forte può essere esposta ai rischi della fragilità? Si può definire la famiglia come spazio (che dice rapporto di genere e crocevia dei sessi) e come tempo (che dice rapporto di genere agito, gener-azione, appunto)?
La coniugazione del rapporto tempo/spazio segnala profili di possibili e frequenti ambiguità: essere uniti (genere)/essere separati (generazione); vicinanza/distanza; risorsa/vincolo; maschile/femminile; genitore/figlio; dipendenza/autonomia; crisi/equilibrio; dentro/fuori; noi/loro. La famiglia appare oggi esposta al rischio interpretativo dei molteplici e differenziati approcci e paradigmi. Sono molteplici i modi con cui si può parlare della famiglia. Si dà una dimensione orizzontale, come crocevia dei sessi (rapporto di genere), e una dimensione verticale, come crocevia generazionale (rapporto di generazione). La famiglia, secondo uno sguardo descrittivo/interpretativo (o fenomenologico/ermeneutico), è certamente gruppo e insieme istituzione. È gruppo o sistema vivente, che muta e si adatta all’ambiente, rigenerandosi autonomamente; è sistema dotato di un proprio codice simbolico, che gli consente di fornire un minimo d’identità e di sicurezza. Ciò che facilmente è stato rimosso nell’ambito del quadro familiare è la soggettualità e la reciprocità della differenza di genere. Dalla dimensione intenzionale della persona nasce, come corollario, che «il mio rapporto con me stesso è mediato dalla presenza dell’altro, da ciò che egli o ella è per me e da ciò che io sono per lui o per lei». Il «tu» è anche nella sua stessa specificità, nella sua stessa individualità e nel suo dono originario il segno di un altro, il cui amore è riconosciuto – almeno agli albori del rapporto d’innamoramento – come origine di ogni amore e come speranza di poter evitare le trappole mortali della volontà di possesso: quell’altro/a, soprattutto nella relazione tra maschile e femminile, che è al tempo stesso necessario/a, eppure irriducibile; condizione della propria felicità, eppure – o in quanto – rivelatore del proprio limite e della propria fragilità. Secondo tale approccio, la coppia costituisce l’orizzonte della sessualità e non viceversa. Una relazione che appare, dunque, come promessa per l’uomo e per la donna: l’uno mediante l’altra, il luogo di una realizzazione della libertà, della fedeltà e della coniugalità; ma, insieme, anche come rischio per l’uomo e per la donna: l’uno mediante l’altra, il luogo dell’esperienza mortale, dell’insabbiamento, della menzogna e dell’alienazione. L’ermeneutica introduttiva di una coscienza prospettica del maschile e del femminile, nell’ambito della situazione e della trasgressione, richiamata e disaminata, tra gli altri, da Melchiorre(2), ci dice che il rapporto uomo-donna non è mai da intendersi come un rapporto di vicinanza o di vicarianza, ma solo come un rapporto di tensioni emergenti, che, quando si danno, reciprocamente sollecitano e custodiscono il proprio contrario. La reciprocità nella e della differenza è come il mare e il cielo: si toccano, si specchiano, si colorano l’un l’altro, ma non si con-fondono e la reciprocità appare, all’origine, come costitutiva e non aggiuntiva, pur esposta al rischio della separazione e della separatezza; una reciprocità che custodisce l’identità, perché segnata e significata dalla differenza, da quella irriducibilità originaria propria della differenza sessuale. «L’uomo tende a trasgredire la situazione, in cerca di un senso infinito, ma nell’incontro con la donna apprende che questa ricerca va mantenuta saldamente alla concretezza dell’esistente; senza di questo egli cadrebbe nella disperazione dell’infinito, che è quella di mancare del finito. La donna, da parte sua, tende a custodire l’universo della propria concretezza, ma nell’incontro con l’uomo apprende che questa custodia esige una distanza e un’incessante trasgressione: senza di questo precipiterebbe nella disperazione del finito, che è quella di mancare dell’infinito»(3).
Ragioni della fragilità
La breve fenomenologia della famiglia registra, nel tempo della postmodernità, una sorta di progressivo (e irreversibile?) allentamento dei legami familiari e genitoriali. Il cuore della fragilità della famiglia si iscrive nei paradigmi costitutivi e istitutivi dello scenario socioculturale postmoderno(4). Nell’orizzonte della rivoluzione scientifico-tecnologica, nell’onnipotenza dei saperi, negli itinerari della destrutturazione pervasiva della globalizzazione e della strutturazione sempre più invasiva del pensiero unico, corto, freddo, debole e abdicato della prevaricazione mercantile e finanziaria, l’architettura familiare è culturalmente defraudata dei suoi tradizionali riferimenti: la fede che si fa fedeltà, la promessa che si traduce nella speranza di una fedeltà agita – dunque una speranza affidabile – il dono che si (ri)genera nel figlio, luogo della ri-conoscenza grata e gratuita dell’amore di un uomo e di una donna, che hanno consegnato il proprio destino a una vita condivisa. Si tratta di una crescente «disaffiliazione» e di una perdita delle appartenenze, che forgiano, a un tempo, «individui per difetto». L’esposizione della famiglia alla retorica «fondamentalista» depone per un riconoscimento – dentro la cultura contemporanea, talvolta nello stesso linguaggio religioso – che sembra non possedere più la grammatica e la sintassi per narrare la famiglia; e la famiglia, nella fatica del quotidiano, per i compiti che la riguardano, si ritrova a vivere un conflitto e un sovraccarico talvolta inenarrabili, perché i vissuti più profondi che generano e custodiscono legami sono censurati e rimossi: consegnati al relativismo soggettivo e individualista (anche della coppia). Peraltro, la cultura dei legami deboli, dell’incertezza del futuro, della funzionalizzazione efficientistica(5) della vita, atrofizzano la famiglia nella sua costitutiva disposizione relazionale. L’esito si trova iscritto negli itinerari della fragilità, proprio attraverso i nodi e gli snodi critici che contrassegnano il divenire familiare. Le ragioni si connotano tutte e si chiarificano attraverso i molteplici indicatori con i quali si può articolare lo scenario socioculturale postmoderno. Esso si annuncia e si conferma come tempo dell’incredulità nei confronti della meta-narrazione; il cucciolo d’uomo appare, dunque, orfano di luoghi condivisi e da condividere in ordine ai significati del vivere; le caratterizzazioni del pensiero segnano l’irreversibile passaggio dal pensiero forte (della cultura premoderna), dal pensiero debole (della cultura tardo-moderna) al pensiero unico (del postmoderno), che allude al primato dell’economico e del finanziario, dove la de-modernizzazione separa, ormai quasi irreversibilmente, il mondo economico dalle relazioni; successivamente si articola il possibile pensiero freddo(6) o il pensiero abdicato(7) o il pensiero vuoto, ove si consuma la solitudine del cittadino globale(8), il pensiero lento(9). La comunità umana rischia la deriva di una cultura dell’effimero; senza pensarsi nel suo futuro, espone la famiglia alla ricerca compulsiva del proprio piacere o alle forme della pluridimensionale dipendenza per il suo affermarsi, quasi alla disperata ricerca di un’impossibile identità; la sicurezza conosce stagioni esigenti, perché evoca l’inquietudine che l’uomo postmoderno vuol mettere e mette nel volto dell’altro, quasi maschera della propria paura e della propria incertezza del futuro, dimentico del significato originario della «sicurezza»(10); l’altro è misura e non causa della crisi; un rovesciamento mediatico, che fa diventare l’effetto causa, anche quando stigmatizza le stesse forme di globalizzazione delle fragilità; il futuro cambia di segno, passando da promessa a minaccia; prevalgono le passioni tristi, intese non come capacità di lutto e di vivere la tristezza, bensì come disgregazione, impotenza e stagnazione; viene a mancare un senso e un orientamento condiviso nella separazione tra destino dell’individuo e della comunità; vi è un’ineludibile transizione dalla società della produzione alla società dei consumi(11): il consumo suppone e produce individui; cresce la perdita del prossimo e la paura dei rapporti im-mediati e corporei; la globalizzazione favorisce la solidarietà con persone lontane. Questo amore per il distante sembra promosso anche dalle comunicazioni elettroniche e dai viaggi più facili. Ma quello che amiamo così è spesso un’astrazione e chi ne paga il prezzo è l’amore per il prossimo richiesto per millenni dalla morale giudaico-cristiana. Come in un circolo vizioso, questa tendenza si salda con l’indifferenza per il vicino prodotta dalla civiltà di massa e dalla scomparsa dei valori tradizionali. E, come nel momento in cui alla fine dell’Ottocento Nietzsche proclamò la «morte di Dio»(12), passato il Novecento, non è forse giunto il tempo di dire che è morto anche il prossimo? Siamo alla soglia di un territorio radicalmente nuovo. Dove la morale dell’amore non è più possibile per mancanza di oggetto, si tratta della morte del prossimo(13). Cresce la lontananza dal vicino e la vicinanza dal lontano; il bene comune è deflagrato nella rivendicazione di «beni comuni», che funzionano come sostituti, quasi allo stesso modo dei diritti umani: beni comuni e diritti umani rappresentano una sorta di linea a difesa dell’umano minacciato e dovuto, ma faticano a indicare un orizzonte di ricerca e di impegno per l’umano ricercato e voluto. Sta qui l’atrofia di un’autentica e duratura relazione tra uomo e donna, che costituisce l’essere marito e moglie e genera l’essere padre e madre. Si consolidano percorsi e itinerari inediti: la dilatazione dei possibili e l’eccedenza delle opportunità, come offerta e disponibilità di mezzi, di strutture, di beni; la pluralità di appartenenze, propiziata dall’eccedenza policentrica, ma anche dalla composizione plurima del quadro generazionale, con la conseguenza del consolidarsi di «appartenenze con riserva», particolarmente incidenti sulla costruzione e/o decostruzione dell’identità giovanile; la mistica dell’assoggettamento, la suggestione della magia, l’esoterismo delle formule, la distruzione della ragione, il fanatismo dell’emozione, l’ideologia chiusa, il dogmatismo ottuso, il pensiero telecomandato; l’ipertrofia dei mezzi e l’atrofia dei fini, non solo ultimi, ma anche penultimi; la spettacolarizzazione della vita, dentro solitudini affollate e non più abitate; la conseguente banalizzazione di ogni linguaggio; il tempo sempre più segnato dai legami deboli e dalle passioni tristi; anche i legami interpersonali si fanno solo funzionali; il crescente, trasversale e onnivoro utilitarismo, che accompagna ogni evento esistenziale e sociale; la censura, la rimozione ‒e la conseguente messa in clandestinità ‒dei vissuti più profondi: la malattia (evento da cui liberarsi più che evento da liberare), la sofferenza (scomoda compagna di cui l’uomo diventa sempre più silenzioso spettatore impotente), la decadenza non accettata del diventare vecchi (tempo questo considerato dopo la vita e non tempo della vita), la disabilità, vissuta più come ostacolo, che non come provocazione, più come bisogno che non come domanda.
Stanno scritte qui le ragioni della fragilità familiare, che è nostalgia dei legami e delle relazioni (orizzontali e verticali), che chiede di rideclinare i verbi che non si comprano e non si vendono in alcun supermercato. Sono i verbi del vivere familiare, desueti ma non inconsueti, dimenticati ma non cancellati: ascoltare, accogliere, accorgersi, attendere, accompagnare, annunciare, ammirare e ammonire. Sotto tale profilo lo scenario postmoderno sembra avere dimenticato la grammatica e la sintassi per dire «famiglia» e la famiglia, dunque, rischia di non sentirsi più interpretata, capita, rappresentata e riconosciuta; essa appare quasi definita dagli aspetti che la dequalificano, non appartenendo certo al «mercato dei mezzi di produzione» parole come l’ascolto, la fede, la promessa e il dono. Dunque, una famiglia impoverita dalla banalizzazione del linguaggio postmoderno; ma una famiglia che può essere reinterpretata, solo che l’intenzionalità di una pur possibile meta-narrazione familiare possa avere di nuovo diritto di cittadinanza, nel vivere civile, prima ancora che nei luoghi delle differenziate appartenenze identitarie, che spesso si arrogano il diritto – quasi in esclusiva – di farsi custodi di quella narrazione.
Regioni della fragilità
La fenomenologia della famiglia si annuncia, anzitutto, con l’individuazione e la rubricazione dei suoi disagi. Essi abitano e in qualche modo rappresentano le regioni della/e fragilità; esse verranno descritte con la suggestione di qualche aggettivo(14), cercando di com-prendere la fragilità, di ap-prenderne i bisogni – non scontati –, per lasciarci sor-prendere dai desideri più profondi che una vita familiare, seppur ferita, evoca e invoca. Comprendere le fatiche della famiglia significa riferirsi ai paradigmi dello scenario postmoderno, ben sapendo che il peso delle responsabilità è potenzialmente di tutti. Cercherò di offrire, seppur sinteticamente, la gamma differenziata di talune fragilità, aggettivandole per specificarne le dimensioni: com-prendere per accogliere, interpretare per saper accompagnare. Le fragilità segnalate, più con i cenni allusivi che non dimostrativi della qualificazione per aggettivi, evocano e invocano l’area delle conseguenti assunzioni di responsabilità, personali, sociali e istituzionali, e preludono alla volontà, non mai sufficientemente acquisita e consolidata, di apprendere la capacità di rispondere ai bisogni di una famiglia che chiede una grammatica e una sintassi nuove per capire e farsi capire, soprattutto nella distretta della sofferenza e dell’abbandono: sono le prospettive «oltre la/e fragilità», cui si farà cenno successivamente. Il volto differenziato delle fragilità dice un frammento, che chiede di essere ricomposto nell’articolazione complessiva dello scenario socioculturale più sopra sommariamente evocato(15).
La fragilità culturale appare composita: il disagio, la malattia, la fatica esistenziale, sono voci censurate e rimosse dal e nel vivere quotidiano. La vita è «come se» queste dimensioni non esistessero; quando capitano, ci si consegna alla rassegnazione o alla disperazione; la parola si racchiude in un silenzio ostentato e ostinato; appare impossibile la strada della consolazione quando l’evento chiama alla desolazione; è questo un tempo che non ha parole per dirsi, per rappresentarsi e per raccontarsi.
La fragilità personale si traduce spesso nell’enfasi assolutizzata delle identità sociali, professionali, funzionali: e, dunque, la difficoltà di riconciliarsi con sé stessi e con la vita, quando essa ti consegna alla fatica, ma insieme al dono; le categorie dell’efficienza, della produttività, dell’apparire, dell’arrivare primi, segnalano la fragilità educativa e si infrangono, dalla loro presunta e declamata onnipotenza, di fronte all’evento dell’imprevisto, della sconfitta, della fatica inattesa; la famiglia si riscopre povera di linguaggi per affrontare i passaggi anche fisiologici del suo divenire.
La fragilità motivazionale cresce in un contesto sociale di conclamata enfasi del come, di disfasia del dove e di afasia del perché; la famiglia si vive come de-situata, senza orizzonti; lo stesso futuro appare o può apparire minaccioso e incerto.
La fragilità relazionale appare come la valorizzazione di «relazioni brevi», di relazioni senza luogo e senza tempo, di celebrazione delle emozioni, ma di delegittimazione dei sentimenti e degli affetti duraturi; le amicizie si fanno occasionali; gli incontri risultano solo funzionali a una conoscenza estemporanea, dovuta più che voluta.
La fragilità comunicazionale è coltivata all’interno delle relazioni familiari. Solo la crescita di autentiche comunità, ove ci si senta accolti e riconosciuti (in una comu-ne uma-nità), diventa garanzia e barriera per quella deriva annunciata; qualcuno ha addirittura parlato di «famiglia murata», nel senso di una radicale incomunicabilità, che rende stereotipati gli stessi riti familiari.
La fragilità esistenziale è iscritta nell’ipertrofia dei bisogni (con il conseguente accanimento nella ricerca di una risposta, comunque, sempre e immediatamente) e ascritta all’atrofia dei desideri (e nella conseguente attesa, talvolta dissimulata perché non riconosciuta, di relazione, di ascolto, di accoglienza, di comprensione, di valorizzazione). Giova ricordare che la memoria grata del «desiderio» non si dimentica mai completamente e, dunque, spesso fiorisce all’improvviso; anche il disagio più grave può farsi risorsa.
La fragilità generazionale, dovuta all’allentamento progressivo e talvolta stabile dei legami, che si annuncia con la crescita, soprattutto nel nostro paese, della denatalità, consegna solo paure per il futuro; anzi, il figlio più che un dono, un compito, una speranza e una promessa appare un debito, un peso, un onere, una preoccupazione; il disagio generazionale segnala la povertà di credito nel futuro imposto, cui ci si consegna con tutte le forme assicurative, ma al futuro accolto ci si affida solo con forme rassicurative.
Vi è poi la fragilità temporale, che l’imperativo postmoderno riassume nel «tutto e subito» (con istruzioni per l’uso). Ma un figlio dice «attesa», al di là di ogni pretesa, che spesso accompagna la depressione genitoriale della non riuscita; dice la gioia dei piccoli passi, segnala il benessere esistenziale e la possibile felicità di un legame affermato e gioiosamente custodito. Anche la famiglia corre il rischio del presentismo e spesso si annida, tra i suoi percorsi di vita, una sorta di bulimia del presente e di anoressia del futuro.
Cresce la fragilità abitativa, non solo per la fatica di trovare, per i giovani, casa, ma per i crescenti rischi di una convivenza sempre più condominiale; una famiglia senza appartenenza e senza vivibilità. La casa, che si fa precaria dimora (nel senso della condivisione relazionale), anche a causa della grande mobilità lavorativa di uno dei coniugi, appare sempre più luogo transitorio dei passaggi: convivenza condominiale, spazio alberghiero.
Aumenta la fragilità istituzionale, in logiche sempre più neoliberiste, anche nella dinamica dei diritti sociali (affidati ai livelli essenziali che diventano, surrettiziamente, livelli minimi); la famiglia si sente abbandonata quando non trova più, nel disarticolato quadro istituzionale delle competenze, un soggetto referente e garante della propria condizione personale e familiare. Spesso la parola più dimenticata, per la famiglia, in ordine ai propri problemi e ai conseguenti compiti di sviluppo, sia relazionali che organizzativi, è l’assenza di una soggettività istituzionale, che, nella qualità dell’essere referente e garante, assuma come criterio della possibile risposta, anzitutto, la categoria della presa in carico. La fragilità istituzionale, la separatezza delle competenze, vedono la famiglia costretta all’accesso di quella che viene chiamata la porta girevole, che non ricompone, ma frammenta e settorializza le diverse competenze istituzionali. In una parola, per riassumere, le fragilità rubricate – non tutte, certamente – conservano, al di là del bisogno che segnalano, il desiderio di una qualche «prospettiva» di vita buona per la famiglia. La consegno, con la stessa metodologia, al profilo delle prospettive, oltre la/e fragilità.
Oltre la/e fragilità
L’ermeneutica della famiglia chiede, infine, di ri-aggettivare anche il tempo della fatica, oltre gli indicatori della fragilità, in quanto si possono consolidare gli elementi costitutivi del lessico familiare (fidarsi/affidarsi, promettere/sperare, essere dono/donarsi) e quelli istitutivi (guardarsi in volto, tenersi per mano, dono della madre(16), dono del padre(17). I percorsi dunque qualificano, ri-aggettivandola, la famiglia, per questo appaiono itinerari da promuovere e da propiziare.
La famiglia ri-definita: richiede quale nome assegnarle oggi, al di là della nomenclatura sociologica. Si tratta di una famiglia che vuole essere accolta e riconosciuta compiutamente, nei suoi valori intrinsecamente costitutivi e non con aggettivazioni solo descrittive dei fenomeni che l’accompagnano; chiede un riconoscimento, anche al di là del mero profilo giuridico.
La famiglia svelata: dalle lunghe stagioni del silenzio, della censura, della rimozione e della clandestinità; è, dunque, il tempo della verità sulla famiglia (nel suo significato etimologico di «uscire dalla clandestinità e dal nascondimento»(18). Svelare la famiglia significa dare volto, voce e parola alle dimensioni della fiducia, della promessa e del dono.
La famiglia ri-cordata: non più dimenticata e abbandonata, perché luogo dell’insignificanza (come i profeti della «morte della famiglia» avevano preannunciato); dunque, una famiglia ricordata, perché, etimologicamente, riportata al cuore, riconoscendole il suo nome più vero, luogo certo dei sentimenti e degli affetti, ma soprattutto dei legami e dei significati esistenziali, quelli che sostituiscono lo scambio con il dono, il prezzo con la gratuità, la desolazione con la consolazione, la mera conoscenza con la logica promettente e sorprendente della riconoscenza.
La famiglia identificata: non basta dare nome e cognome alla famiglia, occorre riconoscerle volto, voce, parola, gesto e intenzionalità; un’identità che certo viene da una memoria lontana, ma è pur sempre carica di profezia e di futuro. L’identità della famiglia è, dunque, la virtuosa reciprocità, offerta e donata, promessa e garantita; essa richiede nuovamente il racconto generazionale, evoca proprio quelle generazioni che sanno narrare alle generazioni il senso dell’esistenza.
La famiglia ri-scoperta: soprattutto nelle sue funzioni, non mai desuete, e nei suoi luoghi significativi e narrativi; soprattutto in quello che, spazio simbolico unico e irrepetibile, si offre come il luogo ancora migliore per imparare a nascere, a vivere, a gioire e a soffrire e, dunque, a morire. Le funzioni antiche della famiglia non sono, attualmente, per nulla dismesse: la funzione economica – si pensi al risparmio familiare –, quella socioculturale e simbolica.
La famiglia annunciata: la famiglia è sempre, per chi vuole ascoltarla, buona notizia, anche quando esibisce il volto severo della fragilità. C’è un vangelo – una buona notizia – nelle relazioni, nelle aspettative, nel ringraziamento che le famiglie sanno spesso offrire a tutti, sia all’interno che all’esterno.
La famiglia ri-trovata: soprattutto accompagnata nell’affrontare i nodi e gli snodi critici dell’arco esistenziale, quelli che fanno l’intreccio e, dunque, il tessuto della sua narrazione biografica.
La famiglia rin-novata: il dono, capace di rinnovare – di fare sempre nuova – la famiglia sta scritto nella reciprocità relazionale, nella gratuità e nella riconoscenza; spesso sono i momenti difficili, imprevisti e imprevedibili, a dare volto alle energie inedite della famiglia; ne nasce spesso, inaspettatamente, un’alleanza capace di generare «vita buona».
La famiglia ri-visitata: dalle parole che le tengono pur sempre compagnia nella vita. Sono parole che durano e sfidano le intemperie dell’esistenza, non sono mai effimere(19). Sono parole che non si vendono e non si comprano nei supermercati postmoderni; si donano, si accolgono, si scoprono e si riconoscono dentro la mappa e la trama dei legami.
La famiglia ri-conosciuta: appare aggettivazione ultima nella descrizione, ma prima nell’intenzione, per una famiglia che vuole essere custodita, valorizzata e promossa. L’intenzionalità dice che questa «conoscenza», scoperta e riscoperta, visitata e rivisitata, trovata e ritrovata, si fa, nel tempo, «riconoscenza» e il suo ritorno dice gratitudine e meraviglia. L’aggettivazione suggerisce e indica, a un tempo, percorsi possibili – talvolta necessari – di accompagnamento. Lo scavo nelle fragilità si fa spesso annuncio di futuro, evocando quella speranza affidabile che costituisce pur sempre il volto autentico della famiglia.
Conclusione
La sfida culturale, iscritta anche nel logo del VII Incontro Mondiale delle Famiglie(20), chiede di rivisitare la grammatica e la sintassi originaria della famiglia: ad esse consegniamo la conclusione di questa riflessione, forse troppo frammentata. Il lessico, anche etimologico, del divenire familiare si articola negli stadi evolutivi dell’incontro tra un uomo e una donna, che si riconoscono nella reciprocità del loro amarsi.
Agli inizi sta un incontro, che, se si consolida nel riconoscimento della reciprocità accolta, propizia il cammino del «fidarsi» (l’uno/a dell’altra/o) e dell’«affidarsi» (l’uno/a all’altra/o): non si chiama(va) questo il tempo del «fidanzamento»? Potremmo dire la stagione della fede. Del resto il fidanzamento, generando e propiziando fedeltà, porta a scambiare, come segno e simbolo dell’impegno, appunto, la fede (nuziale). La fede ha certamente un futuro, chiama il e al futuro, ma quando la fede è futuro, allora si fa promessa.
Il secondo stadio evolutivo genera, dunque, la «promessa» di coloro che, davanti alla comunità, si consegnano fedeltà: nella promessa, la fedeltà è il futuro della coppia. Per questo giova ricordare come «sposo/a» venga dal verbo latino spondeo, che significa, appunto, «prometto»(21). È questa la stagione della speranza. Il matrimonio, dunque, appare come una vera e propria «speranza affidabile», perché (af)fonda la promessa sul fidarsi e sull’affidarsi.
Vi è, infine, il tempo in cui il rapporto di genere si fa agito (gener-azione) e la famiglia si arricchisce del dono dei figli. La logica dell’essere dono, del donare e del donarsi è espressione conseguente del fidarsi/affidarsi e del prometter-e/si (fedeltà). La promessa affidabile ri-genera il rapporto: dall’essere ri-generati sgorga la possibilità vera di «generare», che è credito nel futuro, è pegno di speranza vera. Se la fede è futuro, i figli ne sono la testimonianza diretta (essi vivranno anche dopo i genitori). È il tempo del compimento. La stagione dell’amore si fa traboccante: nei figli o in coloro cui si fa dono – in ogni forma di paternità e maternità – della propria vita. Potremmo dire: la stagione della carità.
La rivisitazione del divenire familiare, nella riscoperta della grammatica e della sintassi della sua esperienza, anche solo fenomenologicamente rubricata, suggerisce come la visione «familiare» della realtà sappia dare nome all’umano, riconoscendolo e valorizzandolo, in qualche modo dandogli pienezza di compimento.
1 La crisi entropica, a differenza di quella dialettica, non ha in sé i germi di una possibile transizione evolutiva; è crisi che nasce dall’implosione di un sistema e assume, quasi sempre, connotazioni strutturali di natura antropologica.
2 Cfr. in particolare V. Melchiorre, Corpo e persona, Marietti,Torino 1987.
3 Ibid., p. 122.
4 Mi permetto di rinviare a C.M. Mozzanica, Pedagogia della/e fragilità, La Scuola, Brescia 2005.
5 Per un approfondimento di sicuro interesse, rinvio al testo di M. Benasayg – G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2004.
6 Cfr. U. Galimberti, Il segreto della domanda. Intorno alle cose umane e divine, Feltrinelli, Milano 2011.
7 Cfr. R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio ieri e oggi. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica, Laterza, Roma-Bari 2009.
8 Cfr. Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2009.
9 Cfr. D. Kahnemann, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, New York 2011.
10 Dal latino se curare, prendersi cura di sé.
11 Cfr. Z. Bauman, Consumo, dunque sono, Laterza, Roma-Bari 2010.
12 F.W. Nietzsche, La gaia scienza, Newton Compton, Roma 2008.
13 Cfr. L. Zoia, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009.
14 Per aggettivo intendo un termine che, aggiungendosi e congiungendosi (dal latino ad-iungere) alla famiglia, la qualifica e la determina.
15 Per la verità sarebbe necessario, anche se non è possibile farlo in questa sede, analizzare lo scenario istituzionale, le differenziate forme di welfare, per verificare come sia il modello laburista (lab) che quello liberista (lib) abbiano rimosso e censurato il profilo relazionale del welfare, che costituisce il cuore di ogni possibile politica familiare. Si tratta del welfare relazionale, community. Solo la community care è in grado di accogliere, promuovere, sostenere la famiglia. Anche i mancati supporti economici alla famiglia stessa (in particolare l’indifferenziato carico fiscale) sono effetto più che causa delle differenziate fragilità.
16 È la parola del matris munus, matrimonio, con cui si diceva famiglia, un tempo. Il femminile scrive la trama e la storia della vivibilità nel mondo; come spazio per il futuro, in tutto ciò che occorre per la famiglia; oggi il baluardo della vivibilità non è tanto e solo protezione dai pericoli fisici, quanto protezione dalle difficoltà, dal disagio e dalla sofferenza psichica, dalla paura, dall’angoscia, da ciò che toglie il respiro e soffoca l’anima.
17 È la parola del patris munus, patrimonio, con cui si diceva famiglia, un tempo. «Dono del padre»: è offerta e garanzia di una patria, è l’avere patria, come corpo psichico e spirituale; è garanzia di confini, affinché le frontiere non siano minacciose. Senza patria, senza confini, senza limiti, senza regole, siamo tutti senza appartenenza, siamo emarginati, mancanti, difettosi, estranei, esclusi, allontanati, distanti. Il dono del padre, dunque, come dono dell’appartenenza, come consegna del nome e del cognome.
18 Verità, in greco alétheia, dal verbo a-lantháno, uscire dal nascondimento.
19 Etimologicamente: che durano un giorno. Dal greco: epí eméran.
20 Il VII Incontro Mondiale delle Famiglie si terrà dal 30 maggio al 3 giugno 2012 a Milano.
21 In questo senso il romanzo del Manzoni – I promessi sposi – appare una sorta di tautologia o, forse meglio, di un rafforzativo di quella originaria promessa che è il diventare sposi.
Violenza familiare e incontro terapeutico: un appello alla responsabilità
Marco Vannotti
La famiglia
Se mi dispongo a evocare la violenza familiare, lo faccio in quanto vecchio terapeuta della famiglia, con una dose di ammirazione per la ricchezza attuale di tale istituzione, che continua a trasformarsi, che assolve oggi ancora creativamente il compito di dare la vita, di accudirla, di incarnare quei valori di solidarietà, di rispetto, senza i quali la comunità degli uomini non potrebbe crescere. Certo, la famiglia do-vrebbe essere il luogo privilegiato della protezione e dell’amore; non di rado, tuttavia, si rivela essere la fonte d’indicibili sofferenze. Se mi sono interessato, lungo la mia carriera, alla violenza nelle famiglie, è stato perché ho fatto tanti errori di apprezzamento, per lo più minimizzando il fenomeno. Infine, l’esperienza mi ha mostrato che molte delle forme ordinarie della violenza familiare possono attutirsi, anche cessare, se la comunità e i curanti prendono posizione, ricordano che la violenza non è consentita dalla legge, testimoniano che il rispetto dell’umanità di sé e dell’altro costituisce il fondamento etico del vivere insieme.
Violenza familiare
La violenza familiare è molto diffusa, soprattutto – ma non solo – ai danni di donne e bambini. Secondo un’inchiesta della World Health Organization, all’incirca 1,5 milioni di donne e 800.000 uomini, negli Stati Uniti, subiscono ogni anno aggressioni fisiche e/o sessuali da parte di un familiare o di un partner(1).
La violenza familiare riveste molteplici forme. Si deve considerare come pernicioso un clima relazionale di coazione morale basato sul biasimo, il sopruso, la prepotenza e lo sfruttamento. Tali atteggiamenti umilianti e dannosi rimangono spesso occultati agli occhi degli osservatori esterni. La violenza non è l’appannaggio delle situazioni familiari multiproblematiche, ma tocca le famiglie di tutte le classi sociali e può essere presente anche in quelle famiglie che appaiono «normali», ben integrate, irreprensibili.
La violenza è definita dalla WHO come l’uso intenzionale di potere o di forza fisica, minacciata o in atto, contro sé stessi o contro un’altra persona oppure contro un gruppo o la comunità che provoca o che possa molto verosimilmente provocare un danno, la morte, un torto psicologico o trascuratezza. La violenza può essere distinta in tre grandi categorie: la violenza contro sé stessi, la violenza interpersonale e quella collettiva. Considereremo qui la violenza familiare interpersonale. Questa si distingue tra violenza all’interno della stessa generazione (tra i partner o tra i fratelli) o tra due generazioni (genitori e figli). La natura della violenza è ordinariamente suddivisa in fisica, sessuale, psicologica e trascuratezza. Se l’esigenza di sottili distinguo di orrori e ingiustizie può apparire superflua, una certa chiarezza permette di meglio accogliere la sofferenza delle vittime e aiutare gli autori a cambiare.
L’Unicef utilizza il termine di violenza domestica per definire i comportamenti violenti tra i partner e gli altri membri della famiglia e vi aggiunge gli atti d’omissione e la violenza economica. Secondo la WHO nel mondo, nell’anno 2000, sono morte 520.000 persone per atti di violenza interpersonale. Questo non rappresenta che la più tragica punta dell’iceberg, che nulla ci dice del mondo sotterraneo, onnipresente, nascosto e pervasivo della minore ma distruttiva violenza quotidiana nelle famiglie.
In Svizzera, l’Ufficio Federale di Polizia ha constatato che minacce e percosse ai danni delle persone sono raddoppiati tra il 1982 e il 2000(2). I Centri Federali di aiuto alle vittime d’infrazioni hanno registrato circa 21.000 casi nel 2000. La maggior parte riguardava diverse forme di violenza nei confronti di donne (73 %). La violenza familiare tra coniugi o conviventi raggiunge il 68% delle segnalazioni. In Svizzera, il 6.1% delle donne ha subìto abusi fisici o sessuali nei 12 mesi precedenti l’inchiesta dell’UFS; secondo questo studio, il 12.6% delle donne è stato vittima di violenze fisiche e l’11.6% di abusi sessuali almeno una volta nella vita(3).
Tipi di violenze interpersonali che si possono osservare in famiglia
Si possono distinguere vari tipi di violenze.
Sevizie fisiche come: schiaffi, coltellate, strangolamenti, ustioni, soffocamenti, minacce attraverso oggetti o armi, omicidio.
Sevizie sessuali come: rapporti sessuali ottenuti attraverso la minaccia, l’intimidazione o la forza fisica; l’obbligo a rapporti sessuali con terzi, l’esposizione di minori a materiale pornografico.
Sevizie psicologiche come: comportamenti che si propongono di intimidire o perseguitare, sotto forma di minaccia d’abbandono o maltrattamento, di obbligo di restare in casa, di controlli, di aggressioni verbali, di minacce di soppressione della custodia dei figli, di distruzione di oggetti, d’isolamento, di aggressioni verbali e di costanti umiliazioni.
Sevizie economiche come: privazione di denaro, rifiuto di contributi economici, privazione di cibo e di soddisfacimento di altri bisogni primari, controllo e accesso alle cure mediche, al lavoro ecc.
Atti di trascuratezza come: portare le vittime a essere private di cure, di attenzioni, di cibo ecc.; a essere ignorate, abbandonate, tradite, utilizzate o sfruttate.
La violenza familiare deve essere considerata come una violazione dei Diritti dell’Uomo; chi la esercita non riconosce «l’altro» come un essere umano avente dei diritti. Il suo agire compromette l’integrità dell’individuo e la coerenza del suo gruppo di appartenenza. All’interno della coppia, la violenza provoca danni persistenti e durevoli sul piano fisico, psicologico e sociale sia sulla vittima sia sui figli che vi assistono. Questi, in effetti, vengono sempre a essere, direttamente o indirettamente, coinvolti nelle relazioni violente degli adulti. Si può, quindi, affermare che la violenza familiare tra adulti costituisca una forma grave di maltrattamento verso i minori. L’esposizione alla violenza della coppia ha un effetto deleterio sullo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini che ne sono vittime. Esiste una correlazione fra l’esposizione alla violenza dei bambini e l’insorgere di comportamenti violenti durante la crescita e l’adolescenza.
Aggressività e violenza
De Zulueta, in un suo libro magistrale(4), sostiene che la maniera di affrontare sul piano etico e su quello della ricerca scientifica il fenomeno della violenza dipende fortemente dai presupposti teorici e filosofici su cui poggiano le nostre credenze sulla natura dell’uomo. Se si pensa che questi sia fondamentalmente violento – secondo la lettura biblica, marcato dal peccato originale – e che questa tendenza sia intrinseca alla natura dell’individuo, si rischia di assumere un’attitudine rassegnata e cinica di fronte alla violenza. Se invece si adotta il presupposto che, per sua natura, l’uomo sia un essere sociale cooperativo che ha un fondamentale bisogno dell’«altro», si riesce a pensare la violenza come una rottura della solidarietà sociale, che compromette il mutuo rispetto indispensabile alla vita dell’individuo e del gruppo. Questo secondo presupposto ha implicazioni forti sul piano dell’etica, in quanto impegna la responsabilità di ciascuno nei confronti dell’«altro» e della comunità.
Chi esercita un comportamento violento non si limita a danneggiare le persone, ma le oltraggia o le vìola come esseri umani. L’aggressore considera la persona oggetto di violenza come essenzialmente meno umana, inutile, spregevole, pericolosa e la rende, quindi, oggetto dei propri bisogni e del proprio disprezzo.
L’aggressività è caratteristica del mondo animale e diverse discipline come la psicologia sperimentale o l’etologia hanno fornito dati per spiegare la funzione dei comportamenti aggressivi. Questi ultimi sono considerati come una risposta di fronte allo stress e al pericolo e, per questo, giudicati indispensabili alla sopravvivenza stessa dell’individuo e della specie.
Come differenziare allora le varie forme di comportamento aggressivo da quello violento? Possiamo definire come aggressività «semplice» il comportamento comune sia agli animali sia all’uomo e aggressività «trasformata» i comportamenti distruttivi specifici dell’essere umano.
L’antropologa francese F. Héritier chiama violenza «qualunque costrizione fisica o psichica che possa suscitare il terrore, l’allontanamento o l’infelicità, la sofferenza o la morte di un essere animato…»(5) ed evoca che uno dei bisogni fondamentali degli esseri viventi consiste nel poter vivere in pace e, dunque, avere fiducia in modo stabile nel proprio ambiente familiare e sociale. Che cosa provoca allora nella società degli uomini la trasformazione dell’aggressività in violenza distruttrice?
Si può dire, semplificando, che i comportamenti violenti del soggetto sono multi-fattoriali, dipendenti simultaneamente da fattori genetici e ambientali, dalla storia individuale e familiare soprattutto quando è marcata dal trauma e dal dolore.
L’emergere del comportamento violento, pur determinata dall’interazione di questi fattori, comporta comunque un momento di scelta e di responsabilità inalienabile.
La violenza è un processo che si estende nel tempo e che ha tendenza a riprodursi. L’esperienza che il soggetto vive quando è colpito nella propria integrità fisica e psicologica, o quando si sente vittima di ingiustizia, è traumatica e umiliante. La vittima rischia allora di riprodurre il comportamento violento come risposta all’oltraggio fatto all’obbligo etico di rispetto reciproco. La vittima si propone di ristabilire una giustizia, di ritrovare una propria dignità con una violenza tanto più distruttiva se non ha potuto disporre di un bagaglio di esperienze relazionali precoci sufficientemente «buone». Tali esperienze gettano le basi per la stima di sé e il rispetto dell’«altro» e insegnano a contenere la propria aggressività. Le relazioni d’attaccamento si presentano quindi rilevanti per lo sviluppo del soggetto, giacché presiedono alla costruzione delle dimensioni psicobiologiche, emotive, morali, cognitive e sociali dell’essere umano. In effetti, la teoria dell’attaccamento è una teoria cognitiva sullo sviluppo dei modelli mentali nelle relazioni significative e fornisce un modello esplicativo della loro regolazione affettiva. L’attaccamento riuscito permette di crescere, cooperare e amare, mentre l’«attaccamento mancato» può portare all’espressione della violenza. Un tipo particolare di attaccamento (quello disorganizzato) è prevalente fra bambini che hanno subìto o assistito a violenze e fra i figli di adulti traumatizzati. I comportamenti caratteristici dell’attaccamento disorganizzato possono aumentare il rischio per il bambino di trovarsi – da adulto – in situazioni nelle quali egli stesso può comportarsi, a sua volta, in modo « abusivo» verso gli altri.
Il ruolo delle condizioni legate alla cura e alla crescita della prole, in particolare i traumi, le perdite e le deprivazioni affettive, è centrale nello sviluppo della crudeltà dell’uomo. Il significato dato al trauma e la qualità delle relazioni interpersonali stabilite sembrano essere di grande importanza nel determinare l’estensione del danno psicobiologico, cognitivo o psicologico; quanto maggiore è la traumatizzazione, tanto più elevato è il rischio di violenza(6). Una cultura centrata sull’individuo, sulla sua gratificazione materiale e sulla negazione della perdita e della morte ha bisogno di credere alla «pulsione di morte» o a una teoria genetica della violenza. Una tale credenza porta a eludere la parte importantissima che le relazioni patologiche di attaccamento possono avere sulla genesi di quelle forme insicure d’attaccamento adulto che predispongono alla violenza. Tale cultura, nella sua tendenza più determinista, porta ancora a ritrarsi davanti al dovere di solidarietà; credere che colui che è portatore di geni della violenza o che, sopraffatto dalla pulsione di morte, si comporta male per caratteristiche proprie – e non perché la comunità prossima lo ha precedentemente traumatizzato o abbandonato – potrebbe autorizzare a rimandare il violento a sé stesso, a lasciarlo solo senza offrirgli una speranza di cambiamento.
Aspetti della terapia della violenza familiare
La società ha progressivamente costruito delle strategie di controllo sulla violenza: il senso innato del valore dell’integrità del gruppo si è manifestato attraverso la costruzione del senso morale e la costituzione di un codice giuridico. La violenza può essere contenuta nella sua dimensione sociale, ad esempio attraverso i comportamenti rituali apotropaici o attraverso il ricorso a istituzioni di controllo sociale e di assistenza. La terapia può inscriversi in una risposta che la comunità propone per arginare la violenza.
Il fenomeno della violenza produce, tuttavia, nei medici e nei terapeuti dei fenomeni di rigetto e di rimozione che li portano a trascurare i comportamenti violenti nell’universo relazionale delle persone che si rivolgono loro. Tali meccanismi di auto-protezione fanno sì che questi esplorino insufficientemente l’eventuale presenza di tali comportamenti o che si trincerino dietro una malintesa esigenza di neutralità o di tutela dell’alleanza terapeutica.
Tali forme d’indifferenza conducono i terapeuti a divenire, di fatto, complici degli autori senza percepirne la responsabilità, né proteggere le vittime, né alleviare il dolore di chi soffre. L’intervento terapeutico – per essere tale – deve quindi partire dall’assunto che agli esseri umani sia dovuto rispetto e che ogni individuo è strutturalmente capace di riconoscere l’umanità e la dignità dell’«altro».
L’intervento terapeutico può costituire un momento importante di cambiamento. Il primo compito dei terapeuti, naturalmente, è quello di individuare le eventuali forme di violenza che caratterizzano la coppia o la famiglia.
Diversi autori rilevano che i terapeuti hanno difficoltà ad affrontare il problema quando coppie e famiglie chiedono aiuto per un problema apparentemente anodino, mentre in realtà soffrono della violenza che non rivelano esplicitamente per vergogna. Le situazioni di violenza sembrano essere ampiamente sottostimate dai terapeuti, alcuni dei quali non hanno mai, o quasi mai, posto domande, a proposito della violenza familiare, alle coppie e alle famiglie che si presentano spontaneamente al primo colloquio. Tuttavia, la maggior parte delle vittime di violenza familiare spera che il terapeuta chiederà loro se sono state aggredite e, in tal caso, si dicono pronte a parlarne(7).
Uno dei limiti spesso incontrati nella comprensione della violenza familiare consiste nella tendenza a mettere l’accento principalmente sulla dimensione della coppia. Purtroppo l’attenzione che i partner e, a volte, anche il terapeuta portano alla dinamica relazionale della coppia relega in secondo piano quanto i figli possano essere lesi dalla violenza tra i genitori. I comportamenti con cui la violenza familiare si manifesta si possono e si devono cogliere all’interno di una trama trans generazionale, in modo simile alla prospettiva adottata per valutare e aiutare le famiglie maltrattanti(8).
L’attenzione rivolta esclusivamente alla coppia, per la drammaticità della situazione presentata, porta a trascurare, da una parte, la storia individuale dei partner e quella delle loro rispettive famiglie di origine per capirne lo sviluppo e, dall’altra, lo sviluppo dei figli per valutarne le conseguenze su di loro.
Nella società contemporanea i comportamenti violenti sono vietati dalla legge e possono costituire un crimine. Considerare la violenza nel suo aspetto di crimine mette in evidenza una logica di tipo lineare in cui il carnefice colpisce la vittima. In una logica circolare, nel suo aspetto d’interazione, il carnefice determina il comportamento della vittima e quest’ultima il comportamento del carnefice. Queste due logiche non sono mutualmente escludentesi, ma non si situano a uno stesso livello.
Quando si accerta una situazione di violenza familiare, la dimensione etica obbliga comunque il terapeuta a prendere posizione per quanto riguarda la responsabilità dell’individuo. L’idea della responsabilità è di un ordine diverso, perché si situa a livello di etica e di diritto, che vietano la violenza. Nel caso della violenza familiare, il terapeuta deve considerare la vittima in quanto tale e l’autore come responsabile dei propri atti sul piano legale, sociale e umano. Il terapeuta, nella sua consultazione, non può sottrarsi a un lavoro di comprensione di ciò che ha portato l’autore a commettere la violenza. Comprendere la persona non significa, tuttavia, giustificare gli atti che ha commesso.
Il mandato terapeutico che un’autorità giudiziaria attribuisce a un terapeuta permette alle famiglie, incapaci di chiedere aiuto, di avere accesso alle cure e d’iniziare un processo di cambiamento. Tale mandato ha come finalità prioritaria quella di valutare la situazione e, in particolare, il danno subìto dalle vittime e le capacità degli autori di riconoscere la propria responsabilità(9).
Conclusione
La violenza familiare è sottovalutata dai terapeuti e la sua identificazione non fa sempre parte della valutazione iniziale delle famiglie. Numerosi sono ancora i terapeuti che condividono la credenza che essa sia un fenomeno raro, che sia assente nelle famiglie apparentemente normali, che sia un affare privato che si risolve meglio in assenza di interferenze esterne. Altri terapeuti pensano che affrontare il problema potrebbe dissolvere l’eventuale alleanza terapeutica che si è stabilita fra terapeuta e famiglia. Una tale credenza, in particolare, antepone l’alleanza con il terapeuta all’indispensabile impegno di proteggere chi soggiace alla prepotenza. Altri ancora pensano che la vittima sia in parte responsabile di ciò che le accade.
Il terapeuta non può sottrarsi all’esperienza, reale, di uno squilibrio di potere e di forza: i partner aggrediti e i minorenni invischiati sono effettivamente vittime e colui che li maltratta abusa del proprio ruolo di autorità, del proprio ascendente o della propria superiorità fisica. Anche se la persona che patisce la prevaricazione sembra provocare il proprio aggressore, la risposta di quest’ultimo non può essere considerata come legittima. È inaccettabile che la colpa del sopruso ricada su chi lo subisce, come spesso accade. Attribuire, da parte del terapeuta, alla vittima la responsabilità della violenza di cui è l’oggetto costituisce una grave ingiustizia.
Abbiamo rilevato quanto sia necessario mettersi in una prospettiva relazionale per comprendere la violenza familiare. Solo così si potrà coglierne meglio la genesi ed evitare l’abbandono della vittima e la stigmatizzazione deleteria dell’autore. Abbiamo evocato l’importanza che l’approccio sistemico può avere sul piano etico per trattare questo fenomeno. In effetti, i presupposti epistemologici che fondano la pratica terapeutica rifiutano ogni riduzionismo, come quello insito nella credenza che esista una tendenza intrinseca dell’uomo alla violenza. Il presupposto che, per sua natura, l’uomo è un essere sociale cooperativo – che ha un fondamentale bisogno dell’«altro», che può evolvere solo in un clima di solidarietà sociale –, lungi dal costituire un ottimismo ingenuo, dà indicazioni forti a chi lavora con famiglie caratterizzate dal comportamento violento.
La prospettiva etica che è insita nell’approccio terapeutico ha conseguenze importanti sul piano dell’intervento. In effetti, essa implica che il terapeuta, rinunciando a rifugiarsi dietro a una stretta neutralità, agisca in maniera tale da portare i responsabili della violenza a prendere coscienza del danno inflitto alle loro vittime e a offrire a queste ultime l’aiuto necessario per riprendere fiducia in sé e nelle forme del mutuo rispetto che la società deve poter garantire.
1 Cfr. World Health Organization, World report on violence and health, WHO, Ginevra 2002.
2 Cfr. Office Fédéral de la police, Rapport de situation 2000. Statistique policière de la criminalité. Drogue, faux monnayage, pédophilie, crime organisé, Service d’analyse et de prévention, OFP, Berne 2000.
3 Cfr. UFS Office Fédéral de la statistique, Statistique suisse de l’aide aux victimes (OHS), 2001. Conseils, indemnisation et réparation morale, OFS, Neuchâtel 2002.
4 Cfr. F. De Zulueta, Dal Dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell’aggressività, Cortina, Milano 1999, (prima edizione Whurr Pub., Londra 1993).
5 F. Héritier, De la violence II, Odile Jacob, Parigi 1996, trad. it.: Sulla violenza, Meltemi, Roma 1997.
6 Cfr. F. De Zulueta, Dal Dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell’aggressività, cit.
7 Cfr. M. Vannotti, C. Morier-Genoud, P. Bodenmann, B. Favrat, Violence in primary care: identification and training, does it work?, J. Gen. Intern. Med., 2003, 18, suppl. 1, p. 56.
8 Cfr. S. Cirillo, Cattivi genitori, Cortina, Milano 2005.
9 Ibid.
Famiglie migranti. I paradossi di un’integrazione non richiesta
Maurizio Ambrosini
Primo paradosso
Il rapporto tra immigrazione, dimensione familiare e società ricevente presenta alcuni curiosi paradossi.
Il primo può essere definito così: gli immigrati – e soprattutto le donne immigrate – sono una risorsa per le nostre famiglie, ma le loro relazioni familiari sono un intralcio.
L’istituzione sociale che chiamiamo famiglia, nonostante la crescente fragilità e pluralizzazione delle unioni, resta al centro dei sistemi di fornitura delle cure per le persone in condizione di dipendenza (minori, malati, anziani fragili ecc.) e dei servizi necessari alla vita quotidiana per tutti. Questo è particolarmente vero in Italia e nell’Europa meridionale, dove l’intervento pubblico è rimasto per molti aspetti residuale e inadeguato rispetto all’evoluzione dei comportamenti sociali, più orientato all’erogazione di benefici economici verso gli individui, sotto forma principalmente di pensioni (circa 15% del Pil nel nostro paese), che di servizi. Per scelta o per necessità, nonostante la crescente partecipazione delle donne al lavoro extradomestico e l’aumento del numero degli anziani, le famiglie rimangono il perno del sistema di assistenza sociale. Pressate da questa domanda di cura, molte famiglie hanno reagito silenziosamente, dapprima riducendo il numero dei figli, poi intraprendendo una riorganizzazione del proprio ruolo che ne ribadisce la centralità, ma ridefinisce i meccanismi operativi dell’erogazione delle attività di cura. Si sono rivolte al mercato, incorporando entro il proprio perimetro una popolazione sempre più vasta di aiuti salariati, forniti in misura crescente da immigrati/e stranieri/e: collaboratori/trici familiari fissi/e e a ore, baby sitter, assistenti domiciliari degli anziani (le cosiddette badanti). In quest’ultimo caso, il fenomeno ha assunto caratteri socialmente pervasivi, debordando dal tradizionale ambito delle classi medio-superiori per coinvolgere anche ceti popolari, periferie urbane, piccolissimi centri di zone rurali. In Italia erano registrati, nel 2010, oltre 871mila lavoratori domestici regolarmente iscritti all’Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale). Di essi l’81,5% è straniero (710mila unità), e il 71,8% proviene da paesi extracomunitari. Dal 2001 al 2010, a crescere sono stati quasi soltanto i lavoratori immigrati: in dieci anni il loro numero si è quasi quintuplicato (+408,3%), mentre per gli italiani si tratta appena del +23,7%(1).
Naturalmente questa è soltanto la parte ufficiale del sistema dei servizi domiciliari. Più difficile, come sempre, è stimare la componente sommersa del lavoro di cura. Secondo una stima del Censis (Centro studi investimenti sociali) basata sull’elaborazione di dati Istat, gli occupati del settore domestico sono invece passati da 1.084.000 del 2001 a 1.554.000 del 2010 (+ 43%). Nello stesso periodo, le famiglie italiane, nel ruolo di datori di lavoro, sono cresciute del 27%, sebbene la recessione abbia provocato nell’ultimo periodo un rallentamento del fenomeno. In valore assoluto, si tratta di 2,5 milioni di famiglie, pari al 10% del totale. Anche secondo questa fonte, meno del 30% degli occupati nel settore è di nazionalità italiana.
Le ripercussioni di questa ristrutturazione di fatto del sistema di welfare si dispiegano, quindi, attraverso i confini. Soltanto da poco, e in maniera comunque insufficiente, ci si comincia a rendere conto del drenaggio di risorse affettive che viene effettuato nei confronti delle famiglie da parte delle lavoratrici, chiamate a puntellare con il loro lavoro i precari equilibri delle famiglie italiane e occidentali(2). Una questione che riveste, invece, primaria importanza nel dibattito interno ai loro paesi d’origine, benché trattata spesso in una logica di colpevolizzazione delle madri che, partendo, «abbandonano» i propri figli.
Il benessere delle famiglie e degli anziani delle nostre società genera rimesse e trasferimenti di reddito verso i contesti di provenienza, ma provoca pure lacerazioni e sofferenze emotive nelle famiglie che si trovano private della figura materna(3).
È ancora insufficiente la consapevolezza delle ricadute sociali del care drain (il drenaggio di risorse emotive e relazionali, derivante soprattutto dalla partenza delle madri con figli piccoli) per le famiglie e i contesti d’origine(4): un aspetto che non dovrebbe mai essere dimenticato, quando discutiamo dell’indubbio e ingente contributo che gli immigrati forniscono al nostro sistema di welfare.
Le donne migranti sono, dunque, una risorsa imponente e capillare per tenere in piedi i difficili equilibri delle famiglie italiane, ma possono esserlo efficacemente soltanto tenendo a distanza i propri legami, comprimendo le proprie esigenze affettive, delegando le proprie responsabilità genitoriali. Se entrano in contatto le due sfere, la famiglia italiana datrice di lavoro e la famiglia della lavoratrice immigrata, l’equilibrio funzionale rischia di saltare, oppure richiede di essere radicalmente rinegoziato.
Secondo paradosso
Il secondo paradosso suona così: volevamo delle braccia, sono arrivate delle famiglie. I ricongiungimenti familiari hanno sempre accompagnato, come ombre silenziose, le migrazioni dell’età moderna(5). Di solito, partono per primi i lavoratori (uomini, ma anche donne, come hanno ricordato già da alcuni anni i women studies), accettati tra difficoltà sempre ricorrenti come soggiornanti temporanei, senza familiari al seguito. Essi stessi, soprattutto nel passato, immaginavano di poter continuare a mantenere la famiglia nei luoghi di provenienza, effettuando quando era possibile una migrazione pendolare, oppure progettando un soggiorno di pochi anni, finalizzato ad accumulare risparmi da reinvestire in patria. Poi le vicende personali e familiari non sempre ricalcavano le previsioni iniziali. Molti effettivamente rientravano, anche se a volte poi ripartivano ancora, ormai a disagio nei ristretti orizzonti dei villaggi rurali in cui erano nati e cresciuti, come già notava Thomas nell’America degli anni ’20, a proposito degli emigranti siciliani. Altri si formavano una nuova famiglia nei luoghi di immigrazione e facevano perdere le proprie tracce, originando il fenomeno delle «vedove bianche». Molti altri ancora, a fronte del prolungarsi del soggiorno, non reggendo più la solitudine e la lontananza dai propri affetti, decidevano di farsi raggiungere dai familiari. Oppure andavano a scegliersi una sposa nei paesi d’origine e formavano una nuova famiglia nei luoghi d’insediamento.
Le società riceventi, in Europa, ma ancora oggi nell’area del Golfo Persico o in Estremo Oriente, spesso opponevano resistenza verso l’immigrazione di soggetti ritenuti improduttivi, come le donne e i bambini, visti come un carico sociale. Per di più, l’arrivo delle famiglie dissolveva il sogno di un’immigrazione unicamente economica, funzionale alle esigenze delle società riceventi. Rendeva evidente che i lavoratori non erano più ospiti temporanei, ma residenti definitivi, e che la composizione demografica della società stava cambiando. Veniva, dunque, messo in crisi il grande sforzo degli Stati-nazione per far coincidere territorio racchiuso da confini ben definiti, popolazione residente concepita come culturalmente omogenea, appartenenza nazionale collegata ai diritti e ai doveri di cittadinanza(6). Accettare i ricongiungimenti familiari significava doversi aprire a una visibile eterogeneità della popolazione residente e, presto o tardi, del corpo dei cittadini.
La concessione del ricongiungimento familiare ha quindi incontrato, e tuttora incontra, resistenze di vario genere, nonostante il solenne riconoscimento del diritto a vivere con la propria famiglia tra i diritti umani fondamentali. Negli Stati a ordinamento democratico, le corti di giustizia, a partire dagli anni ’60, hanno esercitato un ruolo decisivo nell’attuazione pratica di questo diritto, imponendone il rispetto a poteri politici recalcitranti.
Oggi, in relazione con le restrizioni che incontra l’immigrazione per lavoro, i ricongiungimenti familiari sono diventati la prima motivazione per l’autorizzazione all’ingresso in molti paesi di consolidata tradizione immigratoria. In Francia e negli Stati Uniti, incidono sui nuovi permessi di soggiorno per quote comprese tra il 60% e il 70%.
L’Europa meridionale, entrata più di recente nel gruppo dei paesi riceventi, si colloca su livelli più bassi: grazie soprattutto alle sanatorie, i permessi di soggiorno per lavoro hanno avuto un peso preponderante sull’aumento dei residenti stranieri. Ma la tendenza che si profila muove nella stessa direzione: dopo le braccia, arrivano le famiglie. Anche in Italia, nel 2010, abbiamo registrato 91.218 nuovi ingressi per motivi di famiglia, contro 69.041 visti per lavoro. A questi vanno poi aggiunti 78.082 nuovi nati in Italia da genitori stranieri(7). Nel complesso, tra il 1998 e il 2008, i permessi di soggiorno per lavoro sono cresciuti dell’87%, quelli per ragioni familiari del 216%.
Le migrazioni femminili sono protagoniste, a un tempo, di maggiore coinvolgimento nelle responsabilità di cura, anche a distanza, dei propri figli (e a volte dei genitori o di altri parenti) e di maggiore fragilità nella realizzazione dei complicati processi di ricongiungimento. Riescono a ottenere maggiore sostegno da parte di datori di lavoro, famiglie italiane, servizi sociali, organizzazioni solidaristiche, ma sono più spesso sole a farsi carico del mantenimento e dell’educazione dei figli. Devono lottare contro i vincoli organizzativi dei lavori di cura che in genere svolgono, contro la penuria economica derivante dal disporre di un unico reddito, contro la fatica di conciliare accudimento dei figli e lavoro retribuito, contro le maggiori difficoltà a superare gli ostacoli normativi sulla strada del ricongiungimento. Per queste ragioni, tendono a ricongiungere figli ormai cresciuti e sufficientemente autonomi, ma con maggiori problemi di adattamento al nuovo ambiente sociale.
Sui ricongiungimenti, forse in maniera più evidente che per altri aspetti dei processi migratori, si gioca una complicata e incerta partita, tra la soggettività dei migranti, le loro aspirazioni e volontà, le loro risorse e reti di relazione, da una parte, e, dall’altra, i vincoli strutturali, normativi ed economici, che si frappongono alla realizzazione dei loro propositi.
Oggi il ricongiungimento, invece di essere inteso come una condizione che favorisce l’integrazione sociale dei migranti, viene concesso a quanti hanno già raggiunto con le proprie forze un grado elevato di integrazione e di benessere. Permane, implicito, il fondamento utilitaristico delle politiche migratorie: il migrante più vantaggioso e funzionale per la società ricevente è quello solo, sano e attivo nel mercato del lavoro, quello che non comporta costi sociali per l’educazione, la salute e l’accoglienza abitativa dei familiari. Traspare un atteggiamento avaro, sul piano del rispetto dei diritti umani e della tutela dell’istituzione familiare. Ma è un atteggiamento che non giova neppure agli interessi di lungo periodo della società ricevente, all’obiettivo di costruire integrazione e coesione sociale. Uno sguardo più accorto agli effetti integrativi e normalizzanti della coesione familiare indurrebbe a sviluppare prassi più liberali e lungimiranti, che, oltre a rispondere all’imperativo del riconoscimento del diritto a vivere con la propria famiglia e di occuparsi dei propri figli, avrebbero effetti positivi sul piano del contenimento delle derive anomiche della circolazione sul territorio di persone sole e sradicate, prive di legami, di affetti stabili, di congiunti su cui contare e di cui assumersi responsabilità.
Terzo paradosso
Il terzo paradosso può essere così definito: il ricongiungimento familiare non è un lieto fine di una storia di sofferenza e di tenacia, bensì un nuovo inizio. La vita familiare dei migranti si presenta come un percorso complesso e accidentato, fatto di separazioni e di ritrovamenti, di nostalgie e di legami, di ostacoli imprevisti, di ritorni indietro, di nuove partenze. A volte le famiglie sono già spezzate prima della partenza, altre volte si sfaldano, o si formano nuove unioni, in altri casi recuperano i rapporti e riescono a riassestarsi nel nuovo contesto di vita. Il ricongiungimento è uno sbocco naturale di molti percorsi, ma pure un processo irto di ostacoli, giuridici, economici, psicologici.
Nei casi più frequenti, la migrazione familiare è un processo a più stadi: la famiglia che vive insieme, nel paese di origine, deve affrontare la prova di una separazione, allorquando parte colui (o colei) che ha maggiori possibilità di oltrepassare i confini e trovare un lavoro; poi viene il tempo della lontananza e dei legami affettivi a distanza, rinsaldati ma anche deformati dai ritorni, più o meno frequenti, in occasione delle vacanze; infine, arriva il momento del ricongiungimento e della ricomposizione del nucleo, o mediante il ritorno in patria, o più spesso, oggi, con il trasferimento dei familiari nella società ricevente, se appena il/la primo/a migrante riesce a conseguire un accettabile livello di integrazione a livello economico e abitativo. È la dinamica che può essere descritta nei termini delle «tre famiglie» dell’immigrato: la famiglia che si ricompone nel paese di destinazione, infatti, non solo è diversa da quella che viveva nella nostalgia, nel tempo della separazione forzata, ma anche dalla prima, quella che si era formata nel paese di origine. Nel frattempo, tutti i protagonisti sono cambiati: non solo i figli che sono cresciuti, ma anche i coniugi, che hanno dovuto condurre per anni una vita indipendente, assumere nuovi compiti, sviluppare competenze che non avevano. Per questo il ricongiungimento, anziché rappresentare il lieto fine di una storia di sofferenza e di perseveranza, è spesso un nuovo inizio, con tutte le incognite e i rischi che ne derivano.
Incide, in proposito, anche il fatto che i ricongiungimenti sono percorsi lunghi, avvengono spesso a tappe, non di rado rimangono parziali: nella ricerca da noi svolta in Lombardia, quasi il 30%(8). I tempi sono comunque lunghi, richiedono diversi anni: oltre la metà degli uomini e quasi la metà delle donne hanno impiegato più di sette anni per attuare il ricongiungimento dell’intero nucleo familiare. Come si può intuire, nel rapporto con i figli queste lunghe parentesi di genitorialità a distanza possono pesare parecchio sulla possibilità di ricostruire rapporti di confidenza e intimità.
Alcune varianti possono intervenire a complicare questi processi: quando il ricongiungimento avviene con ruoli rovesciati, ossia con la donna come protagonista attiva, i mariti sperimentano di frequente sentimenti di frustrazione, sotto forma di perdita di ruolo, nonché di autorevolezza e prestigio all’interno della famiglia. Il ricongiungimento a guida femminile altera profondamente i presupposti tradizionali dei rapporti di genere: sono le mogli a procurare le risorse economiche per il sostentamento della famiglia; sono esse a promuovere il ricongiungimento, decidendone tempi e modi; sono sempre le donne a fare da guida nell’inserimento nella nuova società, disponendo di una padronanza almeno basilare della lingua e di una certa dimestichezza con la società ricevente. Non vi è da stupirsi che molti mariti ricongiunti si sentano esautorati e privati di un ruolo socialmente accettabile. Anche per questa ragione, oltre che per le difficoltà economiche e burocratiche dei ricongiungimenti legali, molti ricongiungimenti dei mariti avvengono in modo informale: nella nostra ricerca sul caso lombardo, meno del 15% delle donne ha fatto entrare in Italia il coniuge con un visto familiare, mentre per gli uomini il valore si attesta poco sopra il 50%. Ciò significa che molti mariti sono entrati con un visto turistico e poi sono rimasti in Italia, entrando nel sottobosco dell’economia sommersa, in attesa di potersi regolarizzare, vivendo per anni sotto la spada di Damocle di una possibile espulsione.
Un altro caso emergente è quello delle madri sole che ricongiungono figli ormai adolescenti: prima non è possibile, perché non saprebbero come accudirli. Si formano così compagini familiari segnate dalla fragilità, sia per ragioni economiche, sia per la carenza di tempo da dedicare ai figli, sia per le difficoltà educative legate allo sradicamento e all’inserimento in un nuovo contesto di figli già grandi e che spesso non desideravano partire. A tutto questo si aggiunge non di rado la presenza di nuovi partner e, a volte, di altri figli(9).
Le famiglie migranti si configurano, pertanto, come strutture sociali a geometria variabile. Potremmo paragonarle, per la loro composizione, a vetture che partono per l’estero, in genere con un solo passeggero a bordo. Poi ne salgono altri, in seguito qualcuno scende, a volte sale qualcun altro incontrato per strada. Qualcuno, dopo essere sceso e tornato indietro, risale a bordo. C’è anche chi non s’imbarca mai e continua a rimanere stanziale.
Nello stesso tempo, la vettura-famiglia continua a spostarsi sul territorio, si ferma per qualche periodo, ma poi è spinta dalle circostanze a ripartire e a cercare un nuovo posto di tappa. L’agognata stabilità stenta a realizzarsi, sia sotto il profilo della composizione, sia sotto forma di insediamento sul territorio. Non manca la paura per la possibile irruzione di qualche controllore che potrebbe fermare e far scendere chi non possiede titoli di viaggio idonei.
Conclusioni. Implicazioni per le politiche sociali
Concludendo, già oggi l’apparire nella società italiana di famiglie migranti e seconde generazioni produce nuove domande sociali. Non si può dubitare della prevedibile crescita della domanda di interventi e misure di sostegno. Nella prospettiva di prevenire la genesi di problemi sociali più gravi e difficili da fronteggiare, almeno cinque sono le dimensioni di politica sociale da mettere a fuoco:
– il sostegno al care shortage nei paesi d’origine, che richiederebbe iniziative esemplari di cooperazione internazionale per favorire lo sviluppo di attività educative rivolte ai minori che si trovano privati delle cure materne: interventi certo non risolutivi, ma espressivi di un’assunzione di responsabilità condivisa e di un’accresciuta sensibilità verso le conseguenze dell’importazione di lavoratrici-madri per rispondere alle esigenze di accudimento delle nostre famiglie;
– il sostegno alla genitorialità a distanza, in termini di spazi di ascolto e di mutuo aiuto, di consulenza psicologica ed educativa, di accesso alle tecnologie della comunicazione;
– il sostegno ai processi di ricongiungimento, sotto forma per esempio di consulenza e accompagnamento per la decodifica delle procedure e la predisposizione della documentazione necessaria;
– il sostegno alla famiglia ricostituita, in cui emergono domande di orientamento per i componenti ricongiunti ed esigenze di aiuto a superare gli squilibri derivanti dal tempo di separazione, dal rimescolamento dei ruoli, dal diverso grado di acculturazione nel nuovo ambiente di vita;
– il sostegno all’educazione dei figli, dove entra in gioco la scuola, ma non può essere trascurato il contributo delle istituzioni educative extrascolastiche (centri di aggregazione giovanile, società sportive, oratori e altro ancora), delle iniziative associative e dei servizi territoriali.
I migranti raramente tornano indietro, nonostante recessioni e resistenze sociali. L’esperienza ormai insegna che, di solito, si installano stabilmente e formano o ricongiungono la propria famiglia nel nuovo paese che hanno servito con il loro lavoro. A maggior ragione, i loro figli sono destinati a diventare una componente legittima della società ricevente, a dispetto delle resistenze nei confronti del riconoscimento del loro diritto di cittadinanza. Quanto prima ci adegueremo a questo nuovo scenario, tanto più saremo capaci di prevenire conflitti e chiusure reciproche.
1 Cfr. Fondazione Leone Moressa, La crisi non ferma l’assunzione delle badanti. In 10 anni stranieri quintuplicati, tratto dal sito http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/01/la-crisi-non-ferma-l%E2%80%99assunzione-delle-badanti-in-10-anni-stranieri-quintuplicati/, consultato il 2 febbraio 2012.
2 Cfr. M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna 2011.
3 Cfr. P. Boccagni, Come fare le madri da lontano? Percorsi, aspettative e pratiche della «maternità transnazionale» dall’Italia, in «Mondi migranti», 2009, 1.
4 Cfr. F. Piperno, Dalla catena della cura al welfare globale. L’impatto delle migrazioni sui regimi di cura nei contesti di origine e le nuove sfide per una politica di co-sviluppo sociale, in «Mondi migranti», 2010, 3, pp. 47-61.
5 Cfr. M. Ambrosini (a cura di), Famiglie migranti (inserto monografico), in «Mondi migranti», 2009, 1.
6 Cfr. U. Beck, La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale, trad. it., Il Mulino, Bologna 2003.
7 Cfr. Caritas-Migrantes, Dossier statistico immigrazione, Idos, Roma 2011.
8 Cfr. M. Ambrosini, P. Bonizzoni, E. Caneva, Ritrovarsi altrove. Famiglie ricongiunte e adolescenti di origine immigrata, Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità, Regione Lombardia, Milano 2010.
9 Ibid.