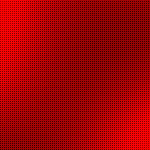Appunti 3_2011
Focus: Mediterraneo tra Primavere e conflitti
Fermenti mediterranei
Paolo Branca
Regimi militari, dispotici, inetti e corrotti, spesso reggendosi sul semplice ricatto, che avrebbero potuto esser sostituiti da governi ancor peggiori di stampo fondamentalista islamico, hanno avuto vita fin troppo lunga. A ben guardare, si tratta di un semplice gioco delle parti, come nella più consumata delle farse, o meglio di due facce della stessa medaglia, eredità dell’epoca della Guerra Fredda. L’Occidente, ossessionato dall’idea che qualche territorio strategico o ricco di materie prime finisse nell’orbita sovietica, ha favorito qualsiasi tipo di regime, purché amico e pertanto definito «moderato» (poco importa quanto effettivamente poliziesco e liberticida fosse) e, all’interno del mondo arabo, ha lasciato che i movimenti islamisti fossero utilizzati per neutralizzare quasi ogni tipo di opposizione laica – potenzialmente più pericolosa per i propri interessi – salvo poi dover fare i conti con le frange oltranziste di queste formazioni.
La democrazia non s’improvvisa
Più che uno «scontro di civiltà», si direbbe un gioco di apprendisti stregoni. Ma la cosa che ha avuto le peggiori conseguenze è la sostanziale strozzatura della classe media che, come sappiamo dalla storia, è sempre stata il motore delle rivoluzioni liberali. Farneticare di incompatibilità tra islam e democrazia serve a limitarsi a parlare di diritti, senza mai toccare il ben più sacro argomento dei profitti. Il desolante panorama dato (offerto) dai pochi e corrotti privilegiati che dominano una massa di diseredati è a lungo sembrato conveniente, ma in una prospettiva di assai corto respiro. Gli egiziani, ad esempio, sono oltre 80 milioni e, dato il tasso d’incremento demografico, tra 20 o 30 anni potrebbero essere il doppio. Non credo che potremo salvaguardare la nostra sicurezza, né quella dello stesso Israele, se i nostri così numerosi vicini non avranno condizioni di vita almeno decenti. Il discorso del presidente Obama al Cairo proponeva «un nuovo inizio» nelle relazioni tra mondo arabo-musulmano e Occidente… ce n’era un gran bisogno dopo la scriteriata campagna militare americana in Iraq. Che l’iniziativa di cominciare a cambiare le cose sia stata presa dai giovani arabi può costituire un elemento estremamente positivo. Esportare la democrazia con la forza si era rivelato non solo impossibile, ma addirittura controproducente. Del resto dovremmo sapere che non si tratta di qualcosa che nasce magicamente dal rito delle elezioni. La divisione dei poteri, il ruolo dei corpi intermedi e della società civile non s’improvvisano, specie laddove hanno dominato sempre autoritarismo e interessi di poche élites. Non si è trattato, come in tanti hanno detto, di mere rivolte del pane, benché siano state accelerate dal rincaro di molti beni di prima necessità, ma piuttosto di una mobilitazione soprattutto giovanile, diffusasi fulmineamente tramite i social network e i telefonini. Ragazzi e ragazze istruiti e senza prospettive, in cerca di dignità e di libertà troppo a lungo negate. Chi non appartiene ai «giri giusti» non ha infatti nessuna opportunità, in questi paesi, e i comuni cittadini sono taglieggiati ogni giorno da chiunque vesta una divisa o occupi un posto burocratico, dovendo pagare sottobanco per ottenere anche il più banale documento o evitare grane. Pensarli come arretrati, destinati dalla loro stessa cultura o religione a vivere per sempre in una gabbia, è stato un errore, per rimediare al quale ora non basterà la tiepida simpatia con cui abbiamo assistito al loro tentativo di riscatto. Le diplomazie internazionali appaiono assai imbarazzate e soprattutto inerti, spaventate dall’incertezza del «dopo». Ci siamo fin troppo abituati ad avere come orizzonte massimo quello delle prossime scadenze elettorali. Così non si fa politica, si vivacchia… oltretutto in un’Europa che sta invecchiando in fretta e male, infastidita dalla presenza di pur indispensabili immigrati e aggrappata al proprio vacillante benessere, incapace di fornire speranze ai suoi stessi figli e tendente a restringere le già scarse garanzie a favore delle donne e delle altre categorie svantaggiate.
Uno Jan Palach tunisino
La lezione che ci arriva dalle piazze di Tunisi, del Cairo e di Tripoli è paradossalmente quella di saper guardare al futuro. Chi non ha ormai più nulla da perdere fornisce una salutare scossa a chi invece sembra paralizzato dalla paura di qualsiasi rischio e ha perduto persino la capacità di immaginare un mondo migliore. Una sorta di nemesi vede la realtà farsi beffe di ogni meschina realpolitik, sorpassata da un festoso autocarro come una vecchia berlina ingolfata. Il giovane ambulante che si è dato fuoco in Tunisia, accendendo così la miccia della rivolta, ha più a vedere con i suoi predecessori dell’Europa orientale o dell’Indocina che con i kamikaze jihadisti. Eppure qualcuno si ostina ad agitare lo spauracchio dei fondamentalisti musulmani. Certo, tra quanti tenteranno di cavalcare l’onda ci saranno anche loro, così come altri cercheranno, gattopardescamente, di fare in modo che tutto cambi affinché tutto rimanga come prima. Sarà anche responsabilità della comunità internazionale prevenire queste possibili involuzioni.
Intanto è evidente che nessuna ideologia ha saputo far presa sui dimostranti che hanno già avviato un modo nuovo di fare politica, basato sul libero scambio di opinioni e sulla condivisione di obiettivi comuni, il che non è certo poco, soprattutto da quelle parti.
Il fermento delle masse arabe ci parla di noi, più di quanto sappiamo comprendere. La globalizzazione non può restare un fenomeno finanziario, peraltro bizzarro e persino pericoloso se non adeguatamente gestito, ma deve diventare partecipazione e corresponsabilità per poter avere un senso. Ancora troppi paesi nel mondo vivono situazioni inaccettabili – ad esempio la Sierra Leone, principale produttore al mondo di diamanti e tra i luoghi più poveri sulla faccia della terra – e anche quando sembrano prosperi e moderni, come il Bahrein dove si corre addirittura un Gran Premio automobilistico di Formula Uno, vedono la maggioranza della popolazione locale sostanzialmente esclusa dalla vita pubblica, in quanto appartenente a una diversa confessione islamica. Per non parlare dei numerosissimi immigrati asiatici in pratica senza diritti…
Non possiamo più far finta di non sapere e ormai più nessun luogo è abbastanza lontano da giustificare la nostra indifferenza. Perfino il remoto e arcaico Yemen è stato coinvolto dalle proteste che evidentemente esprimono un fermento più vasto e profondo di quel che si potrebbe sbrigativamente ritenere. Il nuovo millennio deve farci ridefinire i nostri orizzonti, modificare le priorità e ribaltare le agende per portare gradualmente tutti a standard minimi di dignità. In piena crisi economica può sembrare strano dire queste cose, ma se riflettiamo bene non faticheremo ad accorgerci che si tratta di una prospettiva non solo ragionevole, ma possibile e auspicabile: se la Germania devastata del primo dopoguerra ha saputo trovare le risorse per realizzare, fortunatamente solo in parte, la folle megalomania del nazismo, non si vede perché ideali ben più nobili debbano rimanere sogni solo per colpa della nostra pigrizia.
Per una riflessione politica sull’intervento in Libia
Guido Formigoni
La vicenda dell’intervento militare internazionale in Libia è piuttosto contorta e complessa e merita qualche riflessione politica. Nella discussione italiana recente, infatti, i punti più controversi sono ovviamente tutti importanti: la questione della legittimità rispetto all’art. 11 della Costituzione, la questione dei costi, la questione dei tempi, la questione dei profughi e dell’immigrazione connessa. Ma non mi pare che la discussione pubblica sia stata esaustiva. Rischia di rimanere un po’ fuori quadro il problema politico di fondo: che vogliamo fare in Libia, politicamente parlando? La risposta non è scontata: proviamo ad abbozzare qualche riflessione di quadro.
La primavera araba e il risveglio occidentale
Non è banale andare a rivedere il percorso compiuto. La questione libica è esplosa quando la cosiddetta «primavera araba» aveva già fatto molti dei suoi passi, facendo cadere almeno due regimi autoritari come quelli di Ben Alì in Tunisia e di Mubarak in Egitto. Tutti i grandi paesi occidentali (Israele compreso…) erano stati presi di sorpresa dalla situazione e l’avevano gestita in modo piuttosto imbarazzato: inizialmente schierandosi addirittura per la «stabilità», in quanto molti osservatori paventavano manovre estremiste islamiche che condizionassero i moti di piazza e le rivoluzioni. Del resto, da decenni la politica europea, ma anche quella statunitense, aveva impostato un rapporto «realista» con tali dittature, ritenute nel complesso «moderate» e favorevoli agli interessi occidentali (tranne la Siria di Assad), recuperando anche la stessa Jamahiriya libica gheddafista, dopo anni di ostracismo. Quando l’onda si è allargata, molti governi hanno però compreso di non poter continuare a restare indietro. Frettolosi applausi alle transizioni tunisina ed egiziana non bastavano ormai più. Il protagonista indiscusso di tale accelerazione è stato il presidente francese Sarkozy, forse anche convinto a cercare nuove fonti di consenso dalla periclitante sorte interna. La Francia ha quindi tentato di rimettersi in gioco con una rapida svolta politica, per riaffermare un proprio ruolo nel Mediterraneo (la politica del cosiddetto «processo di Barcellona» e dell’Unione per il Mediterraneo infatti languiva da qualche anno), scoprendosi paladina della democratizzazione degli Stati arabi e africani.
Oltre alla sotterranea presenza nelle varie crisi del Sahel e all’intervento militare per mettere fine alla guerra civile in Costa d’Avorio (parallelo e interessante, ma fuori area e di cui qui non parliamo), la politica francese ha centrato il proprio interesse sulla Libia. Anche in Libia si era mossa da qualche settimana l’ondata di proteste, simile per certi aspetti a quella di altri paesi, ma per quello che possiamo capire anche piuttosto specifica. Infatti nell’ex colonia italiana ci sono tre differenze significative: non essendoci una tradizione costituzionale, ancorchè fragile e formale, non c’era una società civile sviluppata e minimamente strutturata come in Egitto o anche in Tunisia; contavano piuttosto situazioni locali molto variegate, proprie di un paese dalla debole unità (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan hanno storie molto divergenti) e condizionato da una struttura clanica e tribale tradizionale ancora piuttosto forte; e c’era infine un leader capace di una certa influenza internazionale, al di là dell’aspetto folcloristico del suo comportamento, per aver utilizzato la rendita petrolifera in una politica panafricanista e in un’estesa rete di investimenti internazionali, ambedue piuttosto accorte. Le rivolte hanno quindi rapidamente conquistato la Cirenaica e hanno fatto fatica a diffondersi altrove, con il regime che ha mostrato risorse di sopravvivenza forse addirittura impensate. La riscossa del colonnello ha quindi creato una minaccia di repressione estesa alla popolazione civile, che ha causato una forte eco internazionale.
Ingerenza umanitaria intermittente
E qui occorre fermarsi un attimo. È certo che il problema dei crimini dei regimi politici contro i propri cittadini è diventato, una questione cruciale nell’attualità internazionale, almeno dai tempi del Ruanda e della Bosnia o del Kosovo. I conflitti più tragici del XXI secolo sono sempre più interni, legati spesso a fallimenti di Stati e a guerre civili. I drammi reali vissuti hanno quindi rimesso in causa il tradizionale principio di sovranità e aperto la strada alla cosiddetta «ingerenza umanitaria» della comunità internazionale. Il problema a questo proposito è però duplice. Da una parte, quello della informazione e del monitoraggio della situazione: ci sono casi conosciuti, enfatizzati e a volte anche un po’ amplificati dai media e per contrappunto esistono altri casi forse più gravi che restano nascosti, taciuti, negletti. Come accettare questa discrasia? Perché la Libia è un dramma umanitario internazionale e la Siria no (per citare due situazioni paragonabili)? Il caso siriano è infatti per ora seguito e trattato in modo assolutamente diverso dai governi occidentali. Dall’altra parte, nasce la questione delle procedure decisionali all’Onu e della legittimazione che esse rivestono: con un consiglio di sicurezza non riformato, con una struttura di controllo delle operazioni militari che l’Onu non può che delegare fuori di sé (per non aver realizzato gli articoli appositi della carta che prevedevano che gli Stati membri mettessero a disposizione truppe controllate da un apposito Stato maggiore internazionale), l’internazionalismo di queste procedure è piuttosto squilibrato e arbitrario. E questo causa decisioni sottoposte a troppi condizionamenti di potere. Del resto, paghiamo qui anni di unilateralismo statunitense e di politiche che hanno scientemente delegittimato l'Onu e l'aspetto democratico della comunità internazionale.
Come si poteva prevedere nel caso libico, così è successo. La pressione francese è stata prioritaria: pare abbia contato molto l’influsso sull’opinione pubblica di quel discusso personaggio della sfera mediatica internazionale che è Bernard-Henri Levy, il quale dopo una missione a Bengasi si è lanciato nell’ennesima crociata in punta di video. Sarkozy ha quindi attivato il processo decisionale in sede Onu. Barack Obama ha dato il via libera senza grande entusiasmo, sembra soprattutto sotto consiglio dell’assistente consigliere per la sicurezza nazionale Samantha Power (la cui biografia comprende una missione giornalistica che le ha fatto conoscere da vicino le tragiche guerre jugoslave). Il governo inglese, il più distaccato rispetto a Gheddafi, si è subito allineato. Le due risoluzioni 1970 e 1973 del consiglio di sicurezza, approvate in febbraio e in marzo, hanno chiesto al regime di fermare gli attacchi ai civili e – se questo non fosse successo – hanno dato l’autorizzazione per creare una missione militare ai fini di imporne la tutela. Missione che è andata subito oltre la mera no-fly zone di cui si parlava all’inizio. Del resto, se i civili da proteggere sono collegati a truppe irregolari di ribelli che si oppongono al potere costituito, è ovvio che proteggerli non può significare solo impedire all’aviazione governativa di bombardare. Il consiglio di sicurezza ha quindi autorizzato «a prendere tutte le misure necessarie» per proteggere la popolazione e di fatto a opporsi alle truppe governative (escludendo esplicitamente solo l’occupazione militare del paese da parte di truppe straniere). La risoluzione ha cioè implicitamente autorizzato a intervenire con bombardamenti per fermare truppe di terra, distruggere depositi e armamenti, disabilitare catene di comando e di comunicazione, colpire centri decisionali e quant’altro. La decisione è stata presa con la significativa astensione di paesi come Brasile, Russia, India e Cina (oltre che della Germania in Europa, cosa piuttosto pesante). La pantomima iniziale sul comando della missione, passato da un coordinamento franco-anglo-americano alla Nato, dopo lo scontro aperto tra la Francia e alcuni altri paesi tra cui l’Italia, non è rimasto l’unico problema.
L’ondivago governo italiano e i problemi dell’opposizione
Il governo italiano ha mostrato tutta la propria inettitudine nella gestione di questo itinerario politico. Non mi pare pesasse a questo proposito soltanto il passato di trattative con il regime al potere in Libia, per certi versi anche comprensibili (sistemazione delle pendenze coloniali, accordi per sviluppare i rispettivi interessi economici, normalizzazione delle relazioni nel Mediterraneo), ma per altri versi oscure, ciniche e criticabilissime (vendite di armi non tutte alla luce del sole, impegno di Tripoli a trattenere i profughi pur di evitarne l’immigrazione in Italia, senza questionare sulle modalità inumane messe in atto, tanto da attirare sul governo italiano le condanne dell’Unhcr). Questi vincoli potevano essere sempre ridiscussi e rivisti politicamente. Conta piuttosto il fatto di non aver mai saputo utilizzare le proprie capacità di pressione per costruire processi di stabilizzazione lungimiranti e non invece precari o ambigui. Conta la subalternità politica spesso dimostrata. Il delirio di onnipotenza del presidente del Consiglio, che tende a identificarsi sempre con il proprio interlocutore, confidando alla fine con il proprio supposto carisma di ottenere quello che vuole, ha peggiorato la situazione sia simbolicamente che concretamente (si ricordino gli imbarazzanti baciamano al leader libico, le tende beduine a Roma e tutto il contorno di amazzoni). Il risultato è stato una politica ondeggiante: il governo italiano ha mollato Gheddafi da buon ultimo in Europa, ma non ha voluto per questo restare fuori dall’operazione militare (ad esempio, sulla linea tedesca). Ha limitato all’inizio il proprio ruolo al sostegno logistico e strategico della missione, ma poi ha ammesso in un secondo tempo che i Tornado italiani avrebbero partecipato ai bombardamenti. Sotto la pressione della Lega, il parlamento ha approvato una risoluzione che chiede pilatescamente di mettere un limite temporale all’impresa, senza però indicarne uno credibile. Insomma, una navigazione a vista, condotta in modo del tutto irresponsabile.
L’opposizione dal canto suo si è distinta nel criticare giustamente le incertezze del governo e la miopia della Lega (che bada solo a lanciare il messaggio propagandistico di essere contro l’arrivo di «clandestini»), ma non è che abbia mostrato una lungimiranza e un progetto molto più articolato. Non pare affatto sufficiente rifugiarsi dietro la veemente difesa della legittimità internazionale dell’intervento compiuta dal presidente Napolitano (che ha applicato alla questione un vigore non sempre per lui consueto). Siamo d’accordo infatti che l’articolo 11 della Costituzione non vada preso in termini così rigidi da escludere il possibile uso della forza per tutelare o ripristinare il diritto e i diritti umani, secondo le previste e positive limitazioni della sovranità nazionale che la carta stessa statuisce. A parte comunque un’indagine più approfondita sul piano propriamente giuridico (e qui rinvio all’articolo parallelo di Vincenzo Satta), resta aperto l’aspetto politico della questione. Non ci si può trincerare soltanto dietro alle procedure. Perché e come l’intervento, pur legittimo che sia? Era l’unica scelta? Si poteva fare qualcos’altro? Ammesso e non concesso che fosse l’opzione migliore, cosa vogliamo ottenere con l’intervento? Come controllarlo, indirizzarlo, monitorarlo? Di ciò si è parlato pochissimo. E l'opposizione ha in questo le sue specifiche responsabilità.
Il peso della violenza e il mutamento surrettizio di obiettivo
Prescindendo comunque dal particolare ruolo italiano, è chiaro che, annunciando Odyssey dawn («alba dell’Odissea», che fantasia…!) e iniziando l’intervento militare, si è aperto il classico dilemma di questo tipo di missioni. Non è formalmente una guerra, ma è un uso della violenza che non può essere così selettivo e mirato come la propaganda sulle «bombe intelligenti» si illude di farci credere. E quindi si mettono nel conto i possibili e direi quasi scontati effetti collaterali tragici dei bombardamenti Nato. L’opinione cattolica italiana non è stata indifferente, soprattutto a tale questione. Pax Christi ha denunciato con parole chiare e forti la «fretta della guerra» che non può che portare altro dolore. Ci sono state altre prese di distanza, molti distinguo, parecchie invocazioni di limiti rigorosi per l’intervento (la linea del sorvegliatissimo «Avvenire» è sembrata a qualche osservatore una linea del «ni»). Allargando lo sguardo, non si può non notare che le bombe hanno cominciato a far smottare il consenso nell’Unione africana e nella Lega araba, che avevano inizialmente approvato la no-fly zone, e forse stanno muovendo qualcosa nella diplomazia cinese e russa (a testimonianza che Gheddafi non è uno sprovveduto isolato).
Oltre a questo importantissimo elemento, però, occorre considerare un altro aspetto: la missione nel suo svolgersi, dopo le prime settimane, bloccata la controffensiva di Gheddafi, è entrata in un certo stallo. Il regime non dà segni di rapida disgregazione. I ribelli non ce la fanno a lanciare l’offensiva finale (anche perché le risoluzioni Onu formalmente vieterebbero rifornimenti di armi, che forse però stanno già avvenendo di nascosto). Le cose sul campo sono ferme in una situazione ambigua e non risolutiva. Ci si può permettere ancora per molto questo stallo? Le condizioni di sicurezza, legalità, normalità economica, controllo dei flussi di persone, ne sarebbero gravemente compromesse, oltre allo stillicidio di vittime che continuerebbe drammaticamente. Per affrontare queste incertezze, la missione rischia oggettivamente di mutare obiettivo in corso d’opera, senza dichiararlo nemmeno. Si è cominciato infatti a parlare della necessità di far cadere il colonnello. Il quale, proprio mentre scriviamo (a metà maggio) è stato opportunamente incriminato dal procuratore del neonato Tribunale penale internazionale, che ne ha richiesto l’arresto per crimini contro l’umanità. Il cerchio quindi si chiude? Il dittatore libico non ha certo le nostre simpatie, ma perché mai dovremmo farlo cadere dall’esterno o addirittura cercare di ucciderlo bombardando i suoi rifugi segreti? Certo, da morto, leverebbe l’imbarazzo di un eventuale processo in cui potrebbe forse dire qualcosa di interessante sul percorso che l’ha portato, dal ruolo di «cane pazzo» bombardato da Reagan e attentatore di Lockerbie, a una posizione di stimato investitore di petrodollari e interlocutore di molti governi. Il caso Osama Bin Laden insegna. Ma poi, quale conseguenza ci attendiamo dall’uscita di scena del tiranno? Basta il riconoscimento del Consiglio nazionale di transizione di Bengasi come legittimo rappresentante del popolo libico (affrettato da alcuni paesi, tra cui l’Italia, non dagli Usa), per giustificare una così evidente mutazione genetica della missione?
Ma infine, è proprio questo il compito della comunità internazionale? In un mondo appena un poco migliore non sarebbe piuttosto quello di far di tutto per mettere in grado il popolo libico di decidere democraticamente da chi vuole essere governato? E magari anche se il popolo della Cirenaica, della Tripolitania e del Fezzan vogliono continuare a far parte dello stesso Stato oppure no? Una pressione determinata e chiara per fermare il conflitto e avviare un processo democratico: questo dovrebbe essere il percorso assolutamente privilegiato di una comunità internazionale pacifica e matura. Che passi eventualmente per una trattativa finalizzata a condurre Gheddafi ad accettare l’esilio, magari senza una vittoria totale dei ribelli sul campo, ma con una mediazione tra le componenti della società libica, che appaia una premessa di un percorso pur difficile di riconciliazione nazionale. Di qui le cose potrebbero mettersi nel verso giusto, affidando ai libici il loro destino. Non mi pare abbia senso che la missione internazionale decida in anticipo, e surrettiziamente rispetto a quello che essa stessa ha dichiarato in pubblico, ciò che nel quadro dei rapporti sociali e umani sul terreno non appare deciso. Naturalmente tutto ciò sarebbe rafforzato se i paesi europei e in genere l’Occidente fossero in grado di offrire ai movimenti democratici che annunciano una primavera nuova per i popoli arabi una sponda reale, una partnership di sicurezza e cooperazione economica e non chiacchiere vuote e retoriche.
Per concludere
In sintesi, una valutazione politica dell’operazione lascia piuttosto sgomenti e con l’amaro in bocca. Non siamo certo di fronte a un internazionalismo democratico maturo, lo dobbiamo ancora una volta osservare con realismo e con preoccupazione. L’improvvisazione, lo scarso senso di progettazione politica, il disprezzo per le coscienze dei cittadini e per la capacità interpretativa dell’opinione pubblica europea, la torsione deliberata del diritto, l’assoluta arbitrarietà e selettività delle scelte, l’incertezza degli obiettivi e l’irresponsabilità sulle conseguenze, mostrano come Odyssey dawn non possa certo essere ritenuta un successo o un modello da seguire. Speriamo solo che se ne esca senza conti troppo drammatici da pagare.
Guerra e Costituzione
Vincenzo Satta
Il disegno costituzionale
Potrebbe sembrare paradossale formulare un titolo che tenga insieme il lemma Costituzione e la parola guerra. Apparirà a molti un ossimoro, forse, pretendere di parlare della guerra nella Costituzione, se è vero che la vocazione intrinseca delle Costituzioni, in particolare della nostra Costituzione, è radicata su valori e principi assolutamente distanti dalla tragedia epocale che negli ordinamenti statuali genera l’esperienza della guerra. Eppure la Costituzione italiana non ignora il fenomeno, ma sceglie di farne oggetto di ben tre disposizioni delle quali una in particolare, l’art. 11, concorre a definire l’approccio e la posizione dell’intera comunità statuale rispetto agli eventi bellici. Come, dunque, si atteggia l’Italia nei confronti della guerra?
In un saggio pubblicato in lingua italiana alla fine degli anni Settanta, lo storico inglese Denis Mack Smith1 denunciava, con dovizia di particolari, l’atrocità delle repressioni perpetrate dalle truppe italiane, impegnate nella guerra coloniale etiopica, a danno della popolazione autoctona. Autentiche forme di rappresaglia, spesso sostenute dall’uso reiterato di armi chimiche, avevano caratterizzato l’intervento militare italiano in quell’area del continente africano.
Anche per segnare definitivamente e irreversibilmente la rottura con quelle scelte di politica bellica, peraltro largamente fallimentari sul piano strategico, i Costituenti stabilirono nella Costituzione della Repubblica, inserito tra i principi normativi, fondativi della comunità statuale in fase di ricostruzione, il ripudio della guerra «come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (art. 11). È perciò senz’altro da escludere che ogni valutazione concernente la fattibilità, in termini giuridici, di interventi militari armati nel territorio di Stati sovrani possa essere sviluppata a prescindere dal quadro costituzionale di riferimento.
Si deve precisare sin da subito che le considerazioni seguenti risulteranno ampiamente ispirate al tentativo di definire, sia pure per sommi capi, il disegno costituzionale concernente la disciplina interna dello stato di guerra, ma la materia è certamente condizionata dal diritto positivo derivante dalle consuetudini, dai trattati e dalle convenzioni internazionali, fonti che, da sempre, anche nella letteratura costituzionalistica, si è ritenuto essere quelle prioritariamente competenti a regolare questo fenomeno. Non a caso anche i commentatori che, nell’ambito della scienza giuscostituzionalistica, si sono occupati di guerra hanno riconosciuto che essa ha costituito per lo più oggetto di attenzione scientifica da parte degli studiosi di diritto internazionale. Nondimeno, la presenza in Costituzione di specifiche disposizioni dedicate allo stato di guerra – il già citato art. 11, ma anche gli artt. 78 e 87 – impone qualche riflessione sull’approccio interno al problema, riconducibile essenzialmente a interrogativi del tipo: come la Repubblica italiana, secondo la Costituzione, e innanzitutto secondo l’art. 11, si pone dinnanzi allo stato di guerra?
Il ripudio della guerra, scelta fondativa dell’ordinamento repubblicano
Appare piuttosto evidente che il primo aspetto sul quale attirare l’attenzione sia definire cosa, sul piano giuridico, possa essere considerata guerra, ovvero quando sia da ritenere sussistente lo stato di guerra. Già questo primo passaggio potrebbe generare non poche complessità, solo a voler riflettere sui cambiamenti che, rispetto a quella che potremmo reputare una definizione tradizionale del concetto, hanno animato i conflitti armati del secolo scorso e di questo primissimo scorcio del nuovo millennio.
Com’è noto, oggi si assiste in misura sempre più pervasiva a interventi militari ai quali si dà il nome di missioni di peace keeping o, talora, di peace enforcing, il cui obiettivo risulta essere quello di offrire soluzione a conflitti interni, originati per lo più dall’opposizione di larghe fasce del popolo dello Stato interessato al regime politico esistente. Il recente caso della Libia, del resto preceduto e seguito da esperienze affini nella stessa area geografica o in zone attigue, sembra potersi inscrivere in questo genere di situazione.
Questi contesti sono difficilmente inquadrabili secondo le categorie tradizionali dello stato di guerra, in base alle quali due o più Stati si contrappongono in un conflitto militare, che comporta l’impiego e il dispiegamento delle forze armate.
Ora, è poco controvertibile che la disposizione costituzionale di cui all’art. 11 imponga un rifiuto assoluto e totale – l’Italia ripudia la guerra! – dei conflitti bellici intesi in senso tradizionale come contrapposizione tra Stati. Il ripudio di tale strumento diviene vieppiù intenso e stringente qualora lo stato di guerra sia finalizzato a perseguire l’offesa alla libertà dei popoli, o come soluzione di vertenze internazionali alla cui definizione non si sia voluto o potuto pervenire con la dialettica politica o con le relazioni diplomatiche.
Differente appare, invece, il caso della guerra difensiva, vale a dire della protezione, attraverso la forza militare, dell’integrità del territorio nazionale: in quest’ipotesi assume rilevanza il dovere, costituzionalmente imposto a ogni cittadino dall’art. 52, co. 1, della Costituzione, di difendere la Patria. La sacralità di tale dovere giustifica il ricorso alla difesa armata. E depongono a favore della conformità a Costituzione della sola guerra di difesa anche le disposizioni costituzionali (artt. 78 e 87 Cost.) che disciplinano la procedura preordinata alla dichiarazione formale dello stato di guerra (deliberazione delle Camere, attribuzione di poteri eccezionali al Governo e dichiarazione del Presidente della Repubblica). Anche la cifra linguistica prescelta dai Costituenti nella formulazione delle disposizioni appena considerate orienta l’interpretazione in questa direzione. Il riferimento allo stato di guerra può essere infatti letto nel senso della comunità che per volontà eteronoma si venga a trovare nella condizione di dover fronteggiare (e proteggersi da) un’aggressione (o un’invasione) militare, armata.
Come è agevole constatare, una visione tradizionale della guerra, dato il quadro costituzionale di riferimento, permette di considerare non conforme a Costituzione l’aggressione armata ad altri Stati, ancorché funzionale a sopire controversie internazionali. Per converso, la difesa del territorio e della comunità nazionale, cui è sottesa la protezione dell’ordinamento giuridico che di quella comunità è espressione normativa, diventano, anche sotto forma di opposizione armata, dovere costituzionale di ciascun cittadino.
La costruzione della pace e della giustizia tra gli Stati
A ben vedere il ripudio della guerra è il risvolto negativo (nel senso del rifiuto categorico e reciso) dell’altra parte della disposizione posta dall’art. 11 della Costituzione. La norma, infatti, mentre da una parte estromette il fatto della guerra da qualsiasi orizzonte di politica estera, contestualmente si apre «in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni», promuovendo la formazione di organizzazioni internazionali – prima tra tutte le Nazioni Unite – orientate a realizzare questo scopo.
In altre parole, l’apertura alla dimensione internazionale imposta all’Italia dalla Costituzione – a ciò concorre anche il primo comma dell’art. 10, a norma del quale «l’ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» – mostra il fondamento che innerva la vocazione della nostra Repubblica nello scenario internazionale: l’impegno permanente e irrevocabile a proporsi come costruttrice e portatrice di pace e di giustizia. Da ciò deriva, anche solo per una elementare esigenza logica, che non può trovar luogo l’idea che le relazioni internazionali, quand’anche di complessa soluzione, ripieghino sulla logica del conflitto armato.
Le norme costituzionali di fronte alle nuove forme dei conflitti
Come si è già accennato sopra, sono attualmente le nuove forme assunte dagli scenari di guerra che pongono lo studioso del diritto costituzionale dinnanzi a problemi interpretativi per certi versi differenti e probabilmente più complessi.
Resta ferma, in ogni caso, la cornice normativa nell’ambito della quale devono essere inquadrate le scelte di indirizzo politico in materia di politica estera: il ripudio della guerra rimane ovviamente l’orizzonte di fondo. Il problema, a fronte dei modelli di intervento armato che si diffondono nella nostra epoca e che vengono largamente praticati soprattutto dagli Stati occidentali, risiede nel fatto che l’impiego della forza viene giustificato dall’esigenza di proteggere le popolazioni di Stati i cui governi attuano, nei confronti dei propri cittadini, forme cruente e inumane di repressione. In altre circostanze, popoli fortemente diversificati dal punto di vista etnico o religioso danno luogo a guerre civili drammatiche e tremende. Tutti questi teatri di conflitto interno chiedono di essere risolti con l’intervento armato della comunità internazionale. L’obiettivo umanitario diventa così la ratio che sostanzia il ricorso all’impiego delle forze armate. Gli insorti contro il regime del colonnello Gheddafi invocano il soccorso della Nato, che pure non è un’organizzazione internazionale ma un’alleanza militare.
Rispetto a queste situazioni, che evidentemente riscrivono la nozione tradizionale di guerra, dal punto di vista dell’Italia è costituzionalmente ammissibile ciò che, in definitiva, si traduce in una invasione militare del territorio di uno Stato sovrano, con annesso uso della forza militare? Tralasciando i discorsi concernenti l’opportunità politica di ricorrere all’uso della forza, è possibile soltanto offrire elementi di riflessione che si mantengano sul livello strettamente giuridico.
Anzitutto, non sembra davvero sostenibile che il ripudio della guerra si esaurisca per effetto o in conseguenza dell’esigenza di partecipazione a nuove e differenti tipologie di conflitto armato che si consuma, in larga parte, all’interno degli Stati. Si è già osservato, ed è utile ribadirlo, che il ripudio della guerra è definitivo e irreversibile.
Nondimeno, l’indirizzo impresso dalla Costituzione alla nascita di organizzazioni internazionali che assicurino la pace autorizza a pensare che, per lo meno in termini giuridici, sia necessario ipotizzare che le strategie di soluzione delle controversie internazionali debbano essere determinate in quelle specifiche sedi, prima tra tutte l’Onu. L’eventuale deliberazione dell’intervento armato, deciso da un’istituzione internazionale e giudicato, in quella sede, funzionale a realizzare il perseguimento della pace, attraverso la protezione delle popolazioni civili, oggetto delle rappresaglie poste in essere da governi autoritari, finisce, dunque, in qualche misura, per collocarsi in linea con la Costituzione.
Alcune considerazioni di sintesi
Non s’intende assolutizzare la portata delle considerazioni appena svolte, ma ci si limita a porre il problema. Da una parte il ripudio della guerra, dall’altra la promozione di organizzazioni internazionali, le cui scelte strategiche potrebbero anche contemplare il ricorso all’intervento militare.
Da qui, è possibile ricavare alcune utili indicazioni che permettono di leggere la storia più recente della nostra Repubblica come soggetto partecipante a conflitti armati.
La prima. Ogni intervento militare non sostenuto e deliberato da organizzazioni internazionali si tradurrebbe in aggressione nuda e cruda per la quale varrebbe certamente il veto contenuto nell’art. 11. Se questo primo risultato è corretto, diverrebbe molto difficile difendere, sotto il profilo giuridico, l’intervento armato italiano in Iraq.
In secondo luogo, è inesorabile che il rapporto tra ripudio della guerra e adesione a organizzazioni internazionali, che in date e specifiche circostanze autorizzino o dispongano l’intervento armato, finisce per risolversi, come spesso accade tra principi costituzionali, con l’operazione di bilanciamento tra interessi diversi che, in certi casi, potrebbero risultare contrapposti. A tale opera di bilanciamento sono anzitutto chiamati gli organi costituzionali, cui è demandato il compito primario di dare attuazione alla Costituzione.
Un’ultima annotazione è però possibile. Continua a emergere l’esigenza che l’eventualità di operazioni militari programmate da organizzazioni come l’Onu debbano risultare decise attraverso procedure giuridiche che, in qualche modo, assicurino che la decisione sia il più possibile obiettiva e spersonalizzata. Si vuole in altri termini affermare che la razionalizzazione delle deliberazioni assunte dalle Nazioni Unite debba risultare garantita dalle norme del diritto internazionale, senza che quelle decisioni siano in qualche misura riconducibili alla volontà particolare di qualche Stato.
È dunque alla luce di queste considerazioni che deve essere interpretata, sul piano costituzionale, la politica estera di ogni governo.
1 D. Mack Smith, Le guerre del Duce, trad. it., Bari 1979, pp. 93 e ss.