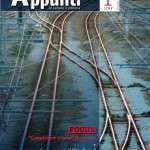Appunti 2_2011
Il passaggio dalle tute blu ai colletti bianchi ha cambiato profondamente sia il senso del lavoro sia la struttura della società. La classe operaia è un ricordo. Gli operai sono ancora centinaia di migliaia ma non sono più rappresentati come tali, non sono più la base di un partito di massa. Questa evoluzione ha comportato un affievolimento di valori un tempo condivisi: la solidarietà operaia, la tensione verso una cittadinanza consapevole. Sandro Antoniazzi ripercorre i passaggi principali di questo processo e indica alcune vie, non per tornare indietro, ma per un recupero di senso e per costruire una nuova socialità.
Sandro Antoniazzi
Quella a cui assistiamo è una crisi storica del lavoro, intendendo il «lavoro» in quell’ampio senso politico-sociale, in cui si è comunemente compresa l’affermazione della classe lavoratrice, la sua rilevanza sociale, il peso che essa ha avuto sul piano economico come su quello politico.
È da tempo in atto un reale declino del lavoro.
Negli ultimi trent’anni il reddito da lavoro sul totale dei redditi ha perso in Italia tredici punti a favore dei profitti e delle rendite; si tratta di un vero e proprio crollo che significa bassi salari, lavoro nero, precario, servile, ma che soprattutto dimostra la debolezza del lavoro; esso non è più in grado di difendersi, di tenere le posizioni, è sempre più emarginato e calpestato.
La globalizzazione e le connesse trasformazioni hanno inciso profondamente in molti modi, ma innanzitutto hanno determinato un’immensa diseguaglianza che rischia di proseguire senza fine.
Ma la crisi sta rivelando un’ulteriore e ancor più grave tendenza: la riduzione, la contrazione del lavoro.
L’incessante sviluppo tecnologico, la delocalizzazione, l’emergere di nuove economie, la dispersione del lavoro in appalti, subappalti, lavoro nero e degradazioni di ogni genere fanno sì che il lavoro si riduca continuamente.
Se e quando la crisi sarà passata, il lavoro non sarà più quello di prima: ce ne sarà molto meno e sarà più povero.
Parlando del lavoro non si può poi trascurare una terza questione.
Due ordini diversi, ma convergenti, di fattori, uno di carattere oggettivo (la segmentazione del lavoro e delle imprese) e l’altro di carattere soggettivo (il diffondersi dell’individualismo) hanno operato concordi per attaccare uno dei valori fondamentali del lavoro, quello costituito dal legame sociale.
Per oltre un secolo e mezzo il lavoro ha significato socialità e solidarietà, mentre il lavoro oggi rimane importante per garantire esistenza e benessere alle persone e alle famiglie e lo è altrettanto per l’identità e il riconoscimento della persona, ma ha largamente perso il suo carattere sociale.
Anche in questo caso si tratta di una strada senza ritorno; non si può più essere quelli di ieri, occorre percorrere strade nuove.
La solidarietà operaia
La solidarietà del lavoro, la storica solidarietà della classe operaia, da cui è nato il sindacato e attorno a cui sono fiorite ideologie di riscatto e di rivoluzione sociale, si è esaurita.
Essa nasceva da una condizione comune di sofferenza, di sfruttamento, di mancanza di diritti ed è stata supportata dalla convinzione profonda, teorizzata dalle ideologie socialiste, ma sia pure in forme del tutto diverse anche dal cattolicesimo sociale e democratico, che il movimento operaio rivestiva un ruolo storico nella trasformazione della società (da questa coscienza comune è nata tra l’altro la convergenza sull’articolo 1 della Costituzione «la Repubblica italiana è fondata sul lavoro»).
Questi presupposti non sono oggi più sostenibili e pertanto non solo è lesa in ampia misura la funzione del lavoro come collante sociale, forma prima e diffusa di socialità, ma nello stesso tempo si perde il ruolo della classe lavoratrice come principale protagonista del cambiamento della società.
Ieri l’operaio era membro di un movimento destinato a cambiare il mondo, oggi è un semplice individuo isolato che fatica a trovare un posto di lavoro e un salario appena appena decente.
È lecito a questo punto chiedersi – dopo questi accenni che nella loro brevità possono apparire severi (ma è bene prendere atto con franchezza della realtà) – se esista una prospettiva di uscita da questa situazione, che riapra un orizzonte positivo per il lavoro e che ridia al sindacato un ruolo e una missione così importanti nel passato e che appaiono al presente per molti versi offuscati.
Il sindacato continua a svolgere nella realtà un lavoro importante di tutela e di servizio ai lavoratori, ma la questione che si pone va ben al di là, riguardando la sua capacità di affrontare questo tornante storico.
Proprio perché ci troviamo di fronte a giganteschi e inediti problemi nuovi, il ruolo del sindacato si presenta quanto mai essenziale, naturalmente se sa rinnovarsi ed essere all’altezza della sfida aperta.
Sinteticamente propongo alcuni degli orientamenti principali su cui mi sembrerebbe importante impegnarsi: innanzitutto occorre contrastare e fermare il meccanismo economico in atto che produce costantemente diseguaglianza. Da una parte i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri. È un problema che riguarda il funzionamento dell’economia odierna, a cui certamente non si può far fronte solo con le rivendicazioni salariali e con i contratti di lavoro, che intervengono a valle di processi strutturali, i quali operano incessantemente e massivamente. Ribaltare questo meccanismo dirompente in atto è problema e compito innanzitutto di politica economica, di visione della società, di controllo delle rendite finanziarie, di regole da introdurre nell’economia mondiale: in una parola, occorre porre fine alla sregolatezza del sistema economico mondiale e occorre ricercare una visione politica condivisa per guidare il mondo.
Il problema politico numero uno, da qualunque parte si guardino le cose, è il mondo. Dobbiamo ormai vedere le cose da questo punto di vista, altrimenti rischiamo di rimanere fuori gioco.
Quando ho occasione di parlare a sindacalisti suggerisco loro di attuare anche nel sindacato l’Erasmus. Un sindacalista oggi non solo dovrebbe conoscere le lingue, ma sapere per esperienza diretta come si lavora in Germania, in Usa, in Cina… Il sindacato oggi è molto arretrato rispetto agli imprenditori, che questo salto l’hanno già fatto nella maggior parte dei casi, altrimenti non sarebbero sopravvissuti. Rimettere al centro l’interesse per l’economia, l’orientamento e le regole che la devono guidare, pensare all’economia in termini nuovi (i beni comuni, il terzo settore, l’economia civile, l’economia sociale, l’economia sostenibile, la solidarietà internazionale reale e non più ideale), sono oggi all’ordine del giorno non come esigenza ideale, ma come condizione prima da affrontare per il futuro della società.
In secondo luogo occorre rivalutare il lavoro. Da quando ha perso il suo valore sociale, esso è quasi scomparso anche dal dibattito. È diventato un problema fra i tanti. Se i lavoratori non costituiscono più il soggetto che cambia la storia, gli intellettuali pensano ad altro. È impressionante da questo punto di vista la parabola degli ex-comunisti. Provenivano da un partito che si richiamava alla classe operaia, ma nelle svariate trasformazioni successive il riferimento al lavoro è andato totalmente perduto, si è evaporato. Nell’attuale Pd il lavoro non è più un riferimento ad una base e a una realtà sociale, ma è considerato come un tema accanto a molti altri, affidato ad alcune persone di riferimento.
Ma il lavoro continua a riguardare miliardi di persone: le loro condizioni di vita, il loro salario, la loro dignità è un tutt’uno con il grado di convivenza e di civiltà della società.
Se il lavoro è degradato, la società sarà invece libera e conviviale?
E se è scomparso il mito della classe operaia di un tempo, la classe lavoratrice, i lavoratori, non possono dare oggi un grande contributo allo sviluppo della società con le loro capacità, la loro conoscenza, il loro sapere, la loro intelligenza?
Per questo occorre che il lavoro ritorni ad essere considerato non solo dai lavoratori, ma anche dalla società.
Tanto più oggi, mentre il lavoro sta diventando così fragile e si manifestano giuste preoccupazioni sull’avvenire dei nostri figli, si dovrebbero dedicare maggior attenzione e cura al lavoro.
E non si tratta solo di una valutazione economico/sociale, ma anche culturale e morale, è la visione di un lavoro degno dell’uomo che deve ritornare al centro della vita collettiva.
Occorre in terzo luogo ricreare un legame sociale del lavoro.
Non può più essere quello di ieri e quello nuovo è tutto da costruire, però è importante mettersi all’opera. Per costruire solidarietà oggi non si può prescindere dalle condizioni che si sono create.
Se siamo nell’epoca dell’individualismo e delle differenze, occorre partire da qui.
Non dobbiamo opporre individualismo e solidarietà, altrimenti la battaglia è già persa in partenza, ma dobbiamo invece sviluppare la soggettività in senso sociale.
La soggettività oggi è vissuta positivamente come acquisizione di libertà; è un fatto ormai imprescindibile e irreversibile. Il compito attuale è come sviluppare relazione e legame sociale a partire da questa situazione.
Inoltre la solidarietà del lavoro ieri era molto forte, ma anche esclusiva e in un certo senso totalitaria, nel senso che ogni altro rapporto era visto come secondario e subordinato: così è stato per il rapporto uomo/donna, per il rapporto con gli immigrati e così via.
Uno dei padri della sociologia, Emile Durk-heim, sosteneva che un giorno si sarebbe passati da una solidarietà «meccanica» ad una solidarietà «organica». Non era una previsione, era un compito.
È il momento di assolvere quel compito.
Oggi la solidarietà vera è una solidarietà complessa: deve essere nello stesso tempo solidarietà del lavoro, solidarietà tra uomo e donna, solidarietà tra diverse culture e religioni.
È molto difficile, ma non c’è altra soluzione.
Formazione sindacale, formazione alla cittadinanza
Il sindacato continua ad avere una forte radicazione tra la gente. Per questo ha una funzione fondamentale.
Nessuno come il sindacato può svolgere un ruolo di formazione sociale primaria, che costituisce la base dell’educazione civile e politica. La formazione di massa non può avvenire soltanto con le parole, ma con una pratica associativa che unisca pratica e proposta culturale.
La solidarietà complessa è sperimentazione di nuovi stili di lavoro, di vita, di rapporti che non devono rimanere casi esemplari, ma diventare pratica diffusa di comportamenti sociali.
Tutte le organizzazioni soffrono oggi di mancanza di militanti, anche perché la figura del militante è diventata desueta. Occorre plasmare una nuova figura che al momento si può definire «persona sociale», per intendere che bisogna partire dalla persona, dalla soggettività e indirizzarla socialmente. Come? Questo è un problema del tutto aperto.
Ma non dimentichiamo un elemento irrinunciabile: la formazione delle persone avviene attraverso l’esperienza ed essa è tanto più autentica e valida, quanto più profonde sono le esperienze che si attraversano.
È di fronte alle grandi contraddizioni del mondo odierno che si formano persone sociali in grado di affrontare i problemi del tempo: il nuovo lavoro, la nuova economia, il rapporto uomo/donna, l’incontro fra le culture, le questioni ambientali, sono i temi su cui cimentarsi, non con visioni separatiste o fondamentaliste, ma con la coscienza che un passo avanti in uno di questi rapporti, su uno di questi fronti, significa un passo avanti anche sugli altri fronti, sulla solidarietà generale dei lavoratori e della società. Con un traguardo comune: quello di una società civile e conviviale, dove nel modo migliore si possa esprimere l’umano comune.
Parlando del lavoro ho più volte chiamato in causa la società.
Se il lavoro deperisce l’intera società è messa in questione: l’avvenire dei giovani, l’equilibrio delle famiglie, i rapporti sociali, la coesione tra classi e ceti, la stessa possibilità di una convivenza civile, sono messi duramente alla prova.
Il problema «lavoro» non è solo un problema di posti che mancano e tanto meno un problema settoriale o particolare: è un fattore basilare, un fondamento della nostra convivenza, che entrando in crisi provoca uno sconvolgimento più ampio che attraversa l’intera società.
Come non avvertire che il problema del lavoro è un tutt’uno col problema della società e che, se non fermeremo il degrado del lavoro, avremo sempre di più davanti a noi una società divisa, frammentata, dominata dalla paura e dal risentimento, destinata a chiudersi su se stessa e incapace di aprirsi con fiducia al mondo che cambia?