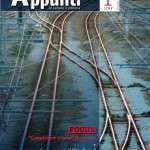Appunti 2_2011
A volte ci si chiede come possa accadere che in Italia un referendum abrogativo non produca effetti duraturi. Ricordate il referendum sul nucleare o quello sul ministero dell’Agricoltura? Il nucleare è di nuovo in agenda (ma è davvero risolto il problema delle scorie?) e il ministero dell’Agricoltura ha solo cambiato denominazione (ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali). Eppure il referendum è uno strumento importante di controllo popolare nei confronti dell’attività legislativa. Il contributo di Vincenzo Satta ne delinea i fondamenti e l’alto ruolo. Che poi gli italiani usino male questo strumento è questione diversa.
Il ruolo del referendum
Vincenzo Satta
Il recente giudizio della Corte costituzionale sull’ammissibilità di quattro delle sei richieste di referendum riguardanti rispettivamente la legge sul cosiddetto «legittimo impedimento», la disciplina concernente le modalità di gestione del servizio idrico e le disposizioni relative alla realizzazione degli impianti nucleari1, offrono lo spunto per svolgere qualche considerazione generale sulla collocazione di questo istituto nell’ordinamento italiano. Nel corso delle osservazioni che seguono, sarà poi utile fornire poche brevi indicazioni in ordine ai quesiti referendari sui quali il corpo elettorale sarà chiamato a esprimersi nei giorni 12 e 13 del giugno prossimo. Il Governo ha ritenuto infatti di non procedere all’accorpamento, in un’unica data (il cosiddetto election day), delle elezioni per il rinnovo delle amministrazioni locali in scadenza e della consultazione referendaria, con il prevedibile aggravio di costi per le non esattamente pingui finanze pubbliche.
Peraltro, la tendenza a depotenziare l’efficacia dello strumento referendario come forma di partecipazione politica è stata, anche in queste colonne2, ripetutamente denunciata e riporta, in generale, alle problematiche che connotano, in questa fase, il sistema democratico italiano, specialmente in relazione alla condizione e al ruolo dei partiti politici.
È del tutto evidente che l’istituto referendario sia invece dotato di precise garanzie che ne permettono di inquadrare la peculiare collocazione, nell’ambito della forma democratica della Repubblica.
La Costituzione della Repubblica, riconoscendo l’appartenenza della sovranità al popolo, ne sottopone contemporaneamente l’esercizio alle forme e ai limiti stabiliti nella Costituzione stessa (art. 1, II comma). Per quanto in questa sede interessa e con l’obiettivo di schematizzare utilmente, si può sinteticamente sostenere che il sistema di governo (in senso lato) chiamato a tradurre in decisione politica la sovranità popolare è quello rappresentativo, incentrato sul ruolo del Parlamento. Non v’è dubbio che la rappresentanza politica sia la forma prevalente, prescelta dalla Costituzione per rendere possibile l’esercizio della sovranità popolare.
In un contesto istituzionale di questo tipo, gli istituti cosiddetti di democrazia diretta, primo tra tutti il referendum, con le sue varie tipologie (abrogativo, oppositivo, confermativo, consultivo), si innestano in maniera – diciamo così, per il momento – particolare, sebbene con propri caratteri tipici, che del resto, come si dirà più avanti, ne rendono decisamente significativa la rilevanza in funzione della piena espressione della sovranità popolare.
Perchè la rappresentanza?
La scelta operata dai Costituenti, di saldare la forma democratica dello Stato al modello del sistema rappresentativo, è sicuramente in linea con l’evoluzione delle istituzioni politiche che ha segnato lo sviluppo dello Stato moderno. L’estensione quantitativa delle società contemporanee, da un lato, e la pluralità degli interessi da governare, dall’altro, cospirano a rendere possibile il governo della cosa pubblica quasi esclusivamente attraverso la rappresentanza politica. D’altra parte, la teoria generale e la dottrina dello Stato, soprattutto di lingua francese, contengono convinti e significativi contributi tesi ad affermare le ragioni della rappresentanza politica come principio di governo preferibile ai sistemi di democrazia diretta. Mi riferisco in particolare alle tesi di Sieyès, Constant e Carré de Malberg3.
Il primo, Emmanuel-Joseph Sieyès, sacerdote, è colui che predispose il testo del giuramento della Pallacorda del 20 giugno 1789, atto che, come è noto, diede la stura alla Rivoluzione francese. Sieyès teorizza il principio della sovranità nazionale, tuttora sancito dalla Costituzione della V Repubblica, da cui fa logicamente discendere l’idea del governo esercitato per procura, capace di manifestare la volontà comune rappresentativa, entità fortemente ideale in quanto parte della volontà della nazione.
Le ragioni che sospingono verso il modello rappresentativo sono chiaramente enunciate dall’autore quando afferma che «gli associati sono troppo numerosi e sparsi su un territorio troppo esteso per potere esprimere agevolmente essi stessi la loro volontà comune. Essi allora determinano quanto è necessario per vegliare e provvedere alle pubbliche cure, affidando l’esercizio di questa parte della volontà nazionale, e quindi del potere, ad alcuni di loro»4. Questi formano dunque il corpo dei rappresentanti della nazione, l’organo rappresentativo cioè, con un nome ancora oggi rimasto intoccato nella Costituzione francese della V Repubblica, l’Assemblea nazionale.
Altrettanto efficace nella difesa del governo rappresentativo è stato il politologo svizzero Benjamin Constant, il quale associa le esigenze di conservazione e protezione della libertà individuale, la libertà dei moderni come egli la definisce, a un’organizzazione di tipo rappresentativo. Osserva Constant che «il sistema rappresentativo non è altro che una organizzazione mediante la quale una nazione si affida ad alcuni individui per ciò che non può o non vuole fare essa stessa»5. Anche l’approccio di Constant si incentra dunque sull’idea della delega, della procura, attraverso la quale la comunità politica attribuisce ai rappresentanti il potere di decidere in nome e per conto della nazione.
Sarà poi Raymond Carré de Malberg a offrire una sistemazione compiuta e organica del concetto di sovranità, alla luce del diritto positivo francese. Egli, partendo dalla contrapposizione tra sovranità nazionale e popolare, dimostra, criticamente nei confronti delle teorie rousseauviane, fondative del governo diretto del popolo, che, tanto nella monarchia assoluta, quanto nella democrazia diretta, personalità dello Stato e potere del soggetto che detiene la sovranità coincidono perfettamente. La differenza è che nel primo caso sovrano è il re, nell’altro è il popolo. Ciò nonostante, in entrambe le forme di Stato, non è possibile separare la sovranità statale dalla personalità del soggetto (monarca o popolo) che ne è titolare, con la conseguenza che lo Stato non può avere una soggettività propria. Viceversa, scrive Carré de Malberg, con il principio della sovranità della nazione, «lo Stato è una persona solo nella misura in cui personifica la collettività nazionale costituita in unità indivisibile e in grado di formare così essa stessa un’entità giuridica»6.
Sovranità della nazione e divieto di mandato
La concezione della sovranità nazionale genera il divieto di mandato imperativo che impedisce ai rappresentati di vincolare, con proprie direttive o istruzioni, i rappresentanti, dovendo essi perseguire unicamente ed esclusivamente l’interesse generale della nazione. L’istituto, disciplinato dall’art. 67 della Costituzione italiana, può essere letto ancora oggi, alla luce dell’esigenza che ciascun membro delle Camere possa svolgere le proprie funzioni al solo scopo di realizzare gli interessi generali della comunità politica. Certamente anche Carré de Malberg, non solo i Costituenti italiani, rabbrividirebbe leggendo nella stampa i resoconti di cronaca giudiziaria dell’ultimo periodo, riguardanti le conversazioni telefoniche intercorse tra una certa persona, consigliere regionale della Lombardia, e l’interlocutrice, dalle quali emerge una concezione piuttosto desolante degli incarichi istituzionali rappresentativi7.
E pensare che l’abate Sieyès ebbe modo di ricordare che «anche in un periodo di decadenza dei pubblici costumi, in cui negli animi regna l’egoismo, l’assemblea di una nazione deve essere sempre costituita in modo da isolare gli interessi particolari e rendere conforme al bene generale le decisioni della maggioranza»8. Verrebbe da dire: «Povero illuso!» Ma tant’è.
Resta fermo che, almeno sul piano ordinamentale, la rappresentanza è il sistema di governo che meglio si attaglia al perseguimento dell’obiettivo di comporre la molteplicità degli interessi promananti dalle complesse strutture sociali contemporanee; si impone così come principale modello di organizzazione dell’amministrazione (in senso lato) della cosa pubblica. Non è casuale, infatti, che anche molti autori di cultura anglosassone si siano da sempre pronunciati a favore del sistema rappresentativo, peraltro largamente praticato in Inghilterra già prima della rivoluzione francese. Tra i tanti mi limito a ricordare Edmund Burke, John Stuart Mill e Walter Bagehot.
A ben vedere, alla stessa logica – diciamo così, un po’ all’ingrosso – «mediativa» tra popolo sovrano e sede della decisione politica (organo rappresentativo, Parlamento), risponde il ruolo costituzionalmente attribuito al partito politico (v. ad es. art. 49, Cost.), autentica cerniera tra società e istituzione, al quale, proprio in ragione di questa specifica e rilevante posizione, sono ormai imposte strategie di democratizzazione interna9.
L’antitesi: il contratto sociale di Rousseau
Rispetto alla rappresentanza, che, come si è detto, discende dal principio della sovranità nazionale, la democrazia diretta ne costituisce l’alternativa opposta. Il pensiero di Jean-Jacques Rousseau è tranchant. Nel Contratto sociale egli afferma recisamente che «la sovranità non può essere rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non è soggetta a rappresentanza: o è essa stessa, o è un’altra, non c’è via di mezzo. I deputati del popolo dunque non sono, né possono essere suoi rappresentanti; essi non sono che suoi commissari; non possono concludere niente definitivamente. Ogni legge che il popolo in persona non abbia ratificata, è nulla; non è assolutamente una legge»10. In questa prospettiva il referendum è lo strumento primario di registrazione e manifestazione della volontà espressa direttamente da ciascun cittadino. Contemporaneamente la democrazia diretta si realizza compiutamente, nell’impianto rousseauviano, tramite il governo d’assemblea popolare. È a questo modello che si ispira, per esempio, la Costituzione giacobina del 1793.
Le esperienze iniziali di governo diretto sono, a dire il vero, lontane dall’istituto referendario introdotto e disciplinato dalle Costituzioni di molti Stati contemporanei. È però ad esse che, in seguito a fasi successive di sviluppo delle istituzioni politiche, lo si può far risalire11.
Una sapiente mediazione: il referendum come istituto di partecipazione e controllo
Dalle osservazioni di Rousseau, specialmente se raffrontate alle tesi formulate dagli altri autori considerati, sembrerebbe potersi evincere un’incolmabile quanto radicale incompatibilità tra democrazia rappresentativa e istituti di democrazia diretta.
In realtà non è così. Per lo meno, non è più così.
Riflettendo sulla evoluzione delle forme di Stato, sino alle esperienze statali contemporanee, si può agevolmente rilevare che gli assestamenti progressivi di ciascun ordinamento hanno prodotto modelli in cui gli istituti derivanti dal principio di sovranità nazionale (democrazia rappresentativa) e quelli originati dall’idea di sovranità popolare (democrazia diretta) si intrecciano tra loro, determinando un’ampia serie di tipologie che rendono la natura degli istituti stessi difficilmente classificabile secondo schemi unilaterali. Questo è certamente il caso del referendum.
Considerato che la Costituzione italiana incardina la decisione politica nel circuito proprio delle forme di governo parlamentari, caratterizzate essenzialmente dalla fiducia del Parlamento al Governo, la posizione del referendum risulta ampiamente condizionata da un disegno istituzionale di questo genere. La stessa scelta del costituente di introdurlo tra le forme di esercizio della sovranità popolare, corredandolo di caratteri, limiti ed effetti del tutto particolari, se non addirittura unici, ove comparato con discipline costituzionali di altri ordinamenti, si candida a rivelarne, nel contesto dell’ordinamento repubblicano, la natura di vero e proprio istituto di partecipazione politica e, ad un tempo, di controllo sull’operato dell’organo rappresentativo. Anzi, proprio questa fisionomia permette di superare la contrapposizione tra sovranità popolare e sovranità nazionale, che, come si è constatato, ha animato la teoria generale dello Stato. In altre parole, l’ordinamento italiano è costruito attorno al principio rappresentativo, ma allo stesso tempo, in funzione della partecipazione del popolo alla determinazione della politica nazionale, offre uno strumento istituzionale prezioso, che può correggere le possibili distonie tra la scelta del corpo rappresentativo e l’orientamento del popolo (sovrano).
In questa prospettiva le norme costituzionali che disciplinano i vari tipi di referendum ne evidenziano il carattere – potrebbe dirsi – extra-ordinario (nel senso di non ordinario, al di fuori della norma) rispetto alle forme decidenti, prima tra tutte la legislazione, che passano per la rappresentanza politica. Rispetto al referendum abrogativo (art. 75, Cost.), al quale in questa sede si è principalmente fatto riferimento, va attirata l’attenzione sull’efficacia limitata al solo effetto abrogativo di norme di legge precedenti. Da questo punto di vista il voto popolare interviene solo ed esclusivamente in negativo, a eliminare, cioè, atti legislativi preesistenti.
Anche i limiti ai quali l’istituto è sottoposto portano a ritenere che esso non possa essere concepito come strumento normale di produzione legislativa. Questo carattere è dimostrato dalla necessità, costituzionalmente imposta, che partecipi al voto la maggioranza degli elettori, in funzione della validità della consultazione referendaria (art. 75, co. IV); e in questo stesso senso depone il suo carattere facoltativo e non obbligatorio (la richiesta deve provenire da parte di un cospicuo numero di elettori o di cinque consigli regionali, per il referendum abrogativo, cui si aggiungono un quinto dei membri di una Camera per il referendum costituzionale: artt. 75 e 138, Cost.). Ulteriori limiti sono poi contenuti nella legge n. 352/1970, che dà attuazione alle disposizioni costituzionali.
La collocazione del referendum abrogativo nel sistema delle fonti del diritto, nei termini descritti, spiega tra l’altro i motivi per i quali l’abrogazione referendaria di leggi ordinarie astrattamente non impedisca al legislatore di reintrodurre, eventualmente (ma non obbligatoriamente) modificandola, la normativa abrogata per via referendaria. Evidentemente, in tal caso, si porrebbe un problema di opportunità politica, rappresentato dal fatto che sarebbe piuttosto singolare che il legislatore ordinario insista pervicacemente ad adottare una certa normativa, la quale sia stata oggetto di abrogazione referendaria: la contrapposizione con la volontà del corpo elettorale sarebbe in tale ipotesi sin troppo spudorata.
Proprio questa sembra essere oggi la situazione di una molteplicità di disposizioni e frammenti di disposizioni, contenute in diversi atti legislativi adottati tra l’anno 2008 e il 2010, recanti la disciplina per la costruzione e l’esercizio di nuove centrali nucleari. Su tali disposizioni è stata inoltrata richiesta di referendum abrogativo e il relativo quesito è stato, dalla Corte costituzionale, giudicato ammissibile, con la sentenza n. 28 dell’anno in corso. Com’è facile rilevare, nonostante un precedente voto referendario – era il 1987 – col quale il corpo elettorale ebbe modo di esprimersi a favore dell’abrogazione della normativa concernente la produzione di energia nucleare12, il legislatore ha ritenuto di disciplinare nuovamente il settore, in particolare prevedendo l’avvio della realizzazione di nuovi impianti elettronucleari. Spetterà poi al corpo elettorale, utilmente informato, di esprimersi a favore o contro questa normativa.
Ciò che rileva ai nostri fini è che tutti i dati sin qui emersi confermano la natura assolutamente peculiare del referendum abrogativo, inserito in un quadro istituzionale essenzialmente costruito, come si è detto, secondo i canoni propri della democrazia rappresentativa. Ma, contemporaneamente, l’essere corredato da limiti così stringenti, implica che tanto la Costituzione, quanto la legislazione ordinaria lo esigono oggetto di specifiche garanzie. Infatti, non a caso, l’ordinamento giuridico affida il controllo sulle richieste di referendum a organi tipici di garanzia, come la Corte di Cassazione (Ufficio centrale per il referendum) e la Corte costituzionale, l’intervento dei quali nel procedimento referendario assicura che, ove le richieste rispondano ai requisiti formali e sostanziali previsti, la loro presentazione debba necessariamente preludere al voto popolare.
Proprio per questo, stridono con la natura partecipativa e di controllo sulle scelte dell’organo rappresentativo tutte le strategie artatamente confezionate per depotenziare la rilevanza e il peso politico del referendum; così come ne riduce fortemente il ruolo di strumento di partecipazione consapevole l’uso scriteriato e pleonastico, talora anche su materie del tutto secondarie.
Il significato del referendum abrogativo, nell’ambito degli istituti partecipativi di cui si sostanzia la forma democratica dello Stato, suggerisce di auspicare un’ampia partecipazione del corpo elettorale alla votazione del giugno prossimo. L’auspicio è dettato tanto dalla rilevanza delle materie oggetto dei quesiti, quanto, in generale, dall’utilità della registrazione del giudizio dell’elettorato, rispetto alle scelte derivanti dall’indirizzo politico di maggioranza. Circa il primo aspetto è utile segnalare che oltre al referendum riguardante la costruzione di centrali per la produzione di energia nucleare, il popolo sarà chiamato a esprimersi sulla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra i quali il servizio idrico. Alla consultazione referendaria sarà inoltre sottoposta la legge n. 51/2010, contenente la disciplina sul cosiddetto legittimo impedimento. Quest’ultimo quesito, a dire il vero, appare in qualche misura derubricato, dopo che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 23/201113, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione più controversa della predetta legge. Viceversa, particolarmente significativi sono i quesiti referendari sulla gestione e sull’erogazione dell’acqua. Attraverso l’abrogazione delle norme, oggetto – è utile precisarlo – di due distinti quesiti referendari (l’elettore riceverà due schede distinte, per esprimere il proprio voto sulla cosiddetta «privatizzazione dell’acqua»), «si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua»14.
Un voto consapevole e maturo permetterà di verificare se l’indirizzo politico di maggioranza, per lo meno su questi delicati settori, trovi riscontro nel (tante volte da taluno acclamato) consenso del popolo sovrano.
2 Sia permesso il rinvio a V. Satta, La «questione democratica» e i partiti politici, in «Appunti», 5, 2009, pp. 9 ss.
3 J.E. Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers État? (1789), trad. it., di cui alcuni brani sono raccolti in La rappresentanza politica, antologia a cura di D. Fisichella, Milano 1983, pp. 77 ss.; B. Constant, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, trad. it. Torino 2001, pp. 3-35; R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris 1920, vol. 2, in part. cap. II, trad. it. a cura di E. di Carpegna Brivio, Della sovranità, Seregno 2009, pp. 45 ss.
4 J.E. Sieyès, op. cit., pp. 78-79.
5 B. Constant, op. cit., p. 31.
6 R. Carré de Malberg, op. cit., p. 66.
7 Cfr . W. Galbiati, E. Randacio, Nicole, Barbara e la politica. A Roma o a Milano facciamo come la Carfagna, in «La Repubblica», 28 gennaio 2011, p. 4.
8 J.E. Sieyès, op. cit., p. 87.
9 Sul problema della democrazia interna ai partiti politici si rinvia senz’altro a AA.VV., Democrazia nei partiti, a cura di «Città dell’uomo», Milano 2010.
10 J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, trad. it., Milano 2001, p. 146 [corsivo nostro].
11 V. sul punto F. Pizzolato – V. Satta, Art. 75, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino-Milano 2006, pp. 1460 ss.
12 Cfr. sul relativo giudizio di ammissibilità, Corte costituzionale, Sent. n. 25/1987, nel sito www.giurcost.org.
13 Sulla quale v. A. E. Basilico, Il giudizio della Corte costituzionale sul legittimo impedimento, in «Appunti», 1, 2011, pp. 10 ss.
14 Così Corte costituzionale, Sent. n. 26/2011, n. 5.2. della motivazione in diritto.