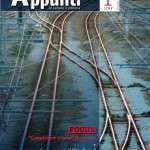Appunti 2_2011
Fulvio De Giorgi
Nella discussione sul rapporto del presidente del Consiglio con la società italiana, nel suo complesso, e con la comunità ecclesiale cattolica in particolare – discussione recentemente arricchita dallo stesso presidente con richiami a Sturzo e De Gasperi –, alcuni giornali hanno riportato presunte dichiarazioni, in un’intervista, di un vescovo cattolico italiano, secondo le quali la moralità personale è importante ma la Chiesa valuta un governante non sulla condotta individuale, sui comportamenti personali e sulle eventuali incoerenze etiche, ma solo in base a quanto si impegna a vantaggio del bene comune1.
Ritengo che sia impossibile che un vescovo cattolico abbia potuto rilasciare simili dichiarazioni e sono dunque sicuro che il suo pensiero sia stato travisato dall’intervistatore. Tuttavia, poiché non sono intercorse successive smentite o precisazioni, non posso escludere del tutto l’ipotesi che tale vescovo voglia proporre un netto e deciso rivoluzionamento dell’insegnamento tradizionale della Chiesa. Intervengo allora per dire che, se così fosse, non sono d’accordo e ritengo l’insegnamento tradizionale – arricchito e approfondito, non cancellato dal Concilio – sempre valido e attuale. Sia chiaro: sul piano della valutazione politica, ritengo deleterio – proprio dal punto di vista cristiano del bene comune – il «periodo berlusconiano», che è stato la faccia italiana del neo-liberalismo imperante sul piano mondiale. Così pure: non giudico la coscienza personale di un individuo, che comunque – come mio prossimo – mi sforzo di amare, pregando per lui. Ma ora, in questa sede, non mi interessano considerazioni politiche o sul bene comune, mi interessa questa ipotesi di radicale innovazione dell’insegnamento morale della Chiesa.
In età moderna, fin dalla discussione sul Principe di Machiavelli, l’insegnamento della Chiesa ha insistito sul fatto che non solo il fine non giustifica i mezzi, ma anche che non si possono stabilire ambiti assolutamente separati nel comportamento morale di chi esercita un’autorità politica, come di chiunque altro. In perfetto equilibrio tra il lassismo di certi casuisti gesuiti e il rigorismo pascaliano delle Provinciali, Alessandro Manzoni – nelle Osservazioni sulla morale cattolica – ricordava: «La Chiesa non suppone che alcun peccato mortale sia compatibile con la conservazione della virtù: quindi se il giusto diventa peccatore, è appunto la virtù, cioè l’avere abbandonata la virtù, che decide della sorte dell’anima sua. La giustizia del giusto non lo libererà, in qualunque giorno pecchi. […] chi ha violato un precetto ha violato tutta la legge»2. E ancora: «No, la Chiesa non ha mai proposti i suoi precetti in sostituzione delle leggi della morale: non si potevano ideare precetti che fossero più conducenti alla vera, all’intera, all’eterna morale: credersi dispensato da essa, osservando esteriormente alcuni di que’ precetti, non può essere nella mente del cristiano che una demenza irreligiosa»3.
Dal punto di vista della persona (sia essa un’autorità o un semplice cittadino, che in democrazia è sempre un sovrano), l’esercizio del bene comune non è limitato ad una «bontà sociale»: sarebbe come ridurre la bontà, la morale, alla politica e fare della politica la misura della morale (una sorta di singolare rovesciamento della teologia politica della liberazione in una teologia politica del liberalismo). Sempre Manzoni osservava acutamente: «bisogna distinguere due gradi o, per dir meglio, due generi di bontà: quella di cui si contenta il mondo, e quella voluta dal Vangelo, e predicata da’ suoi ministri. Il mondo, per il suo interesse e per la sua tranquillità, vuole degli uomini che s’astengano dai delitti (senza rinunziare ad approvar quelli che possono giovare ad alcuni), e esercitino virtù utili temporalmente agli altri; il Vangelo vuol questo e il core»4. Il bene comune mondano è puramente materiale e solo politico: il bene comune evangelico è sia materiale, sociale, politico sia, però, pure spirituale, personale, umano in senso plenario.
E ciò è stato la norma ancora per tutto il Novecento. Affermava don Primo Mazzolari: «Il campo del dovere morale o è totale o non è. Non è fatto a scompartimenti stagni. O si accetta il dovere morale e quindi la lotta in tutti i punti, altrimenti crolla tutto. Il sistema difensivo della coscienza non è un campo trincerato ove vi siano diversi ordini di trincea di diverso valore. Tutto si tiene: morale individuale, pubblica, politica, economica, ecc. “Non si può servire Dio e il Mammona”»5. E il vescovo di Brescia Gaggia, caro a Mazzolari ma anche a Giovan Battista Montini, diceva: «Preferisco una legge cattiva in mano di un onesto, che il Vangelo in mano di un disonesto»6.
Tornacontismo clericale e salamelecchi laici
Naturalmente anche la storia della Chiesa ha avuto, sul piano umano, le sue ombre. Come si sa, nell’Italia del primo dopoguerra, quando nacque il Partito popolare di Sturzo e di De Gasperi, ci fu pure l’ascesa di Benito Mussolini, noto ateo anticristiano, autore di romanzetti pornografici a sfondo anticlericale (L’amante del cardinale), sposato non con rito religioso e notoriamente dedito a relazioni extra-coniugali. Non mancò allora un progressivo appoggio di clerico-fascisti e di ambienti ecclesiastici, che favorì l’ascesa al potere del fascismo. Nell’agosto 1924, dopo il delitto Matteotti, «La Civiltà cattolica» scrisse: «Grazie sopra tutto alla tempra singolare dell’uomo che lo dirige, il nuovo governo vanta benemerenze innegabili, massime per ciò che spetta alla religione. Che tali benemerenze – le quali sono per la più parte una semplice giustizia resa alla Chiesa – siano state ispirate da ragione di Stato o da privati interessi, noi non dobbiamo indagare, dovendosi ora giudicare, non delle intenzioni interne, ma del fatto sociale. […] Si faccia un paragone fra il partito fascista e il partito socialista. […] [Si osservi] per i cattolici poi in particolare, che contro la religione non professa ostilità, anzi in più di un caso professò praticamente il rispetto e della religione, e della famiglia, e del diritto di proprietà»7.
Fu una grave responsabilità e certamente un errore di alcuni settori cattolici ed ecclesiastici (il che non toglie che la Provvidenza potesse scrivere diritto su righe storte, propiziando il superamento della questione romana e il trattato lateranense). Ma vi fu chi si oppose: come Sturzo, come De Gasperi, come Igino Giordani, grande figura di laico cattolico del Novecento (che avrebbe poi aderito al movimento dei Focolari di Chiara Lubich). Proprio Giordani, e anch’egli nel 1924, in un suo libro pubblicato da Gobetti, scriveva: «In attesa ci conviene assistere agli ossequi che dei libertini prodigano alle autorità ecclesiastiche, facendo liquefare in brodo di giuggiole qualche vanità clericale, nel cui tornacontismo s’è sovvertito il senso primo del cristianesimo. Il canone 6° del sinodo apostolico d’Antiochia stabiliva: “I cristiani devono astenersi dalle scurrilità, dal turpiloquio, dalla bestemmia e in genere dai costumi pagani”. Oggi, a sentir certuni, dovrebbe bastare per essere un prototipo di cristiano il fare de’ salamelecchi ai simboli della Chiesa»8.
Certo occorre una contestualizzazione storica, che qui non è possibile sviluppare compiutamente. In ogni caso, mi pare che dalle ricostruzioni storiche disponibili si possa affermare che si trattò di una valutazione politica (anti-socialista) che prevalse su considerazioni di ordine spirituale, pastorale, di evangelizzazione. Certo la valutazione politica (circa il bene comune) si doveva fare: ciò era (ed è) compito immediatamente dei laici (e solo mediatamente dei pastori) o comunque dei politici: come Sturzo e De Gasperi. In ogni caso fu una valutazione politica sbagliata, che – oltretutto – prevalse sull’evangelizzazione e sulle esigenze pastorali. A Sturzo toccò l’esilio, a De Gasperi toccò una vita grama di vessazioni e persecuzioni, agli italiani toccò un ventennio di dittatura.
La Chiesa riguadagnò credibilità sia con l’opposizione di Pio XI ai totalitarismi sia con l’impegno di tanti cattolici nella Resistenza. E proprio durante il periodo della guerra civile e della Resistenza, nel Natale 1944, dopo la liberazione di Roma, Pio XII affermava: «E poiché il centro di gravità di una democrazia normalmente costituita risiede in questa rappresentanza popolare, da cui le correnti politiche s’irradiano in tutti i campi della vita pubblica – così per il bene come per il male –, la questione della elevatezza morale, della idoneità pratica, della capacità intellettuale dei deputati al Parlamento, è per ogni popolo in regime democratico una questione di vita o di morte, di prosperità o di decadenza, di risanamento o di perpetuo malessere»9.
Proprio per questo, nel dopoguerra, i vescovi italiani sentirono il dovere di dare indicazioni morali chiare per orientare i cattolici nella scelta dei candidati da votare nelle elezioni. Oltre alle questioni relative ai programmi, che naturalmente si riferivano alle discussioni del tempo e ai partiti del tempo, davano – in un documento della Cei del 1958 – indicazioni di natura personale, che si possono considerare (a meno di smentite) sempre valide10:
1) La non appartenenza a sette massoniche. Deve essere certa anche l’assenza in loro di simpatia o vincoli con partiti e movimenti anticristiani.
2) La formazione genuinamente cattolica sia per l’indirizzo generale del pensiero sia con particolare riguardo alla soluzione dei problemi sociali e ai rapporti con la gerarchia e la dottrina della Chiesa nella vita privata e pubblica.
3) L’integrità della vita morale e la regolarità di vita familiare con esclusione anche, almeno per i nuovi candidati, di dicerie seppur difficilmente accertabili.
4) L’onestà e il disinteresse, sicché non sia facile né l’avidità né il compromesso e sia eliminato il timore di ricatti.
5) La coscienziosità scrupolosa di amministrazione, contro la quale starebbe anche il fatto di spendere il denaro pubblico sia pure in opere di beneficenza e di culto, ma nel solo distretto dei propri elettori per assicurarsi il voto.
6) La capacità, competenza e valida preparazione alla vita politica e amministrativa.
Questi sei criteri ci stimolano ad un’applicazione a Berlusconi, come politico, e al suo governo:
1) Berlusconi aderì alla massoneria, loggia coperta P2.
2) La soluzione dei «problemi sociali»: il liberismo e il neo-liberalismo del governo Berlusconi sono contrari alla dottrina sociale della Chiesa.
3) Si fa riferimento alla vita morale privata e alla «regolarità di vita familiare»: non si chiedono sentenze di condanna, basta un sospetto, un’ombra, cioè anche solo «dicerie seppur difficilmente accertabili».
4) Significativo il «timore di ricatti».
5) Si condanna il voto di scambio. L’elettorato cattolico non «si compra».
6) La competenza: non si mettono in lista giovinette o giovinetti senza «capacità, competenza e valida preparazione alla vita politica e amministrativa».
Questi orientamenti, svolti in forma meno sintetica e più profonda, sono presenti nel magistero pontificio post-conciliare e nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, nel quale tra l’altro si afferma: «Coloro che hanno responsabilità politiche non devono dimenticare o sottovalutare la dimensione morale della rappresentanza, che consiste nell’impegno di condividere le sorti del popolo e nel cercare la soluzione dei problemi sociali. In questa prospettiva, autorità responsabile significa anche autorità esercitata mediante il ricorso alle virtù che favoriscono la pratica del potere con spirito di servizio (pazienza, modestia, moderazione, carità, sforzo di condivisione); un’autorità esercitata da persone in grado di assumere autenticamente come finalità del proprio operare il bene comune e non il prestigio o l’acquisizione di vantaggi personali»11.
Contestualizziamo… ma fino in fondo!
Pare molto strano, dunque, che qualche vescovo ora proponga un’innovazione forte dell’insegnamento morale della Chiesa. Certo, non molto tempo fa – come si ricorderà – un altro vescovo aveva proposto di «contestualizzare» una bestemmia pronunciata da Berlusconi. Al di là del fatto che proprio contestualizzandolo tale atto appariva più grave (non si trattava di una bestemmia pronunciata nel contesto di un grave dolore personale, una catastrofe, un dramma, un lutto, ma nel contesto di una barzelletta), anche in quel caso si proponeva un’innovazione della tradizione. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Ci sono atti che per se stessi e in se stessi, indipendentemente dalle circostanze e dalle intenzioni, sono sempre gravemente illeciti a motivo del loro oggetto; tali la bestemmia e lo spergiuro, l’omicidio e l’adulterio»12.
Ma allora, contestualizzando storicamente i «contestualizzatori» e i vescovi innovatori, appare che queste proposte derivino, in realtà, da un preminente interesse e obiettivo politico, rispetto a orizzonti spirituali e a priorità pastorali. Si profilerebbero così, ancora una volta, un errore politico e un danno pastorale. Come spesso accade quando la Chiesa fa politica. Perché, evidentemente, sul piano ecclesiale e pastorale appare incomprensibile il filtrare il moscerino e ingoiare il cammello (Mt 23, 24): si è filtrato il moscerino del cattolicesimo democratico (da Prodi alla Bindi) e si ingoia il cammello del cattolicesimo berlusconiano… Non sono, ahimé, ormai pochi che avanzano l’infamante sospetto che la Chiesa chiuda gli occhi per trarne vantaggi materiali: cioè per «tornacontismo» come diceva Giordani. Non è così. Sicuramente non è così. Forse c’è qualche «compagnia» – di ispirazione cattolica – che prospera e fa affari sostenuta dal presidente del Consiglio e dal suo partito. Ma la gran parte della Chiesa e quasi tutti i vescovi (ma mi verrebbe da dire tutti) non propongono di cambiare il peccato per salvare il peccatore. Si può – come ha fatto e cerca di fare il presidente del Consiglio – cambiare una legge ed eliminare un reato, si possono stabilire nuove regole processuali per salvare imputati eccellenti, si può perfino tentare di modificare la Costituzione per un beneficio ad personam. Più difficile, mi pare, è cambiare il Catechismo.
Ora, al di là della politica, molti cattolici pensano che proprio questo sia oggi in gioco: non perché sono oscurantisti e sessuofobi, ma perché avvertono gli effetti devastanti del materialismo pratico (individualista, socialmente egoista, spesso sessuomane). Siamo davanti ad un «disastro antropologico» dovuto al trionfo di tale materialismo pratico e dei suoi «valori» (denaro, potere, sesso, successo, visibilità mediatica) rispetto all’umanesimo plenario che valorizza le beatitudini evangeliche (povertà, mitezza, fame e sete di giustizia, misericordia, purezza, umiltà). Da che parte stanno il presidente del Consiglio, il suo stile di vita, i messaggi che lancia l’impero mediatico che a lui fa capo? E quali sono oggi le «beatitudini» diffuse dal materialismo pratico? A chi tanta gente dice oggi «beato lui»? Un vescovo cattolico, fin dal 1996 (dunque in tempi non sospetti), in una sua lettera pastorale, ha dato un’amara risposta, formulando le beatitudini antievangeliche: «Beati i ricchi, perché di essi sarà la gestione del potere. Beati coloro che affliggono e offendono, perché saranno soddisfatti. Beati i prepotenti, perché comanderanno la terra. Beati coloro che fanno i loro interessi con ingiustizia, perché saranno sempre sazi e sicuri. Beati gli spietati, perché avranno sempre la loro vendetta. Beati gli spregiudicati di cuore, perché proveranno ogni piacere. Beati gli operatori di guerra, perché saranno chiamati vincitori e capi degli uomini. Beato chi perseguita con ingiustizia, perché non perderà il suo potere sulla terra. Beati voi quando vi incenseranno, vi aduleranno e, mentendo, diranno ogni sorta di bene su di voi a causa dei vostri soldi e del vostro potere. Rallegratevi ed esultate, perché questi sono gli onori che dà il mondo. Così infatti hanno onorato tutti i potenti prima di voi»13.
Le parole del Vangelo e la testimonianza dell’amore sono sempre credibili: sono le sole credibili. Su di esse si basa il tradizionale insegnamento della Chiesa, che certo può essere approfondito e accresciuto sotto l’azione dello Spirito.
Ma perché qualche vescovo vuole cambiare in modo significativo questo insegnamento? Per essere più fedeli al Vangelo o, come in realtà esplicitamente si dice, per difendere il presidente del Consiglio? Ma può essere veramente così? No, non voglio crederci.
2 A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, in Scritti filosofici, Rizzoli, Milano 1976, pp. 163-64, 167.
3 Ibid., p. 169.
4 Ibid., p. 172.
5 P. Mazzolari, Diario, III/A. (1927-1933), Dehoniane, Bologna 2000, p. 36.
6 Ibid., p. 267.
7 La parte dei cattolici nelle presenti lotte dei partiti politici in Italia, in «La Civiltà cattolica», 7 agosto 1924, pp. 298-306.
8 I. Giordani, La rivolta cattolica, Gobetti, Torino 1924, p. IV.
9 PIO XII, Radiomessaggio per il Natale 1944, n. 11.
10 Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, 1. 1954-1972, Dehoniane, Bologna 1985, p. 66.
11 Pontificio Consiglio della Giustizia e della pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 224 (n. 410).
12 Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, p. 451 (n. 1756).
13 D. Negro, Beati i “futuri” di cuore. In cammino verso il Giubileo del 200. Lettera Pastorale, Luce e Vita, Molfetta 1996, p. 28.