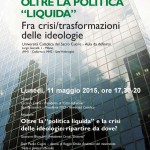Appunti 1_2011
Focus:
LA GENERAZIONE PERDUTA
Da molti anni ogni discorso dei politici e dei sindacalisti italiani termina con la formula “per i giovani, soprattutto del Mezzogiorno”. Ora i giovani, soprattutto nel Mezzogiorno, sono messi molto male e sindacalisti e politici, avendo ormai verificato che la formula non è magica, elencano instancabilmente le tre o quattro cose «da fare subito». Peccato che poi nessuno faccia nulla. Il governo perché troppo impegnato a fare a pezzi la Costituzione, l’opposizione perché, poverina, essendo opposizione non ha alcun potere. Il primo governo Prodi aveva un buon programma per i giovani, rimasto lettera morta perché la priorità era entrare nell’area euro e perché – appena raggiunto questo obiettivo – i partiti che sostenevano il governo si sono affrettati a farlo cadere. E adesso? Il debito pubblico sfiora i 1.870 miliardi di euro (dovranno pagarlo quanti sono giovani oggi); la cultura del “pezzo di carta” ha prodotto più laureati di quanti ne occorrano, specie nelle discipline umanistiche, creando un paradosso: i laureati italiani non accettano i lavori disponibili perché considerati umili e così trovano occupazione da noi centinaia di migliaia di extracomunitari (molti dei quali… laureati). Si capisce che nessuno provi ad affrontare un problema del genere, che tocca alla radice il progetto di società. “Appunti” ha iniziato a raccogliere interventi sul tema del lavoro in generale (n. 6/2010), e si avvicina ora alla questione del lavoro per i giovani.
Il lavoro non è più un diritto e non ci sono più diritti
Eugenia Montagnini
Il 2011 inizia con una notizia che rimbalza sui media e poi scivola, come tante altre, in uno spazio assopito; chi riesce ad afferrarne il senso prima che si avvii verso l’oblio, trascina tali notizie in contesti di dibattito; altrimenti non se ne parla più. E in parte così è avvenuto per la notizia in oggetto: l’Istat afferma che il tasso di disoccupazione a novembre dello scorso anno è rimasto sostanzialmente stabile. Scorporando maggiormente i dati e analizzandoli distintamente, la situazione permane drammatica come nel caso del tasso di disoccupazione giovanile salito al 28,9 per cento. Si tratta del più alto tasso di disoccupazione – riguardante giovani con un’età compresa fra i 15 e i 24 anni – dal gennaio 2004. Un tasso incrementato di 2,4 punti percentuali rispetto a quello rilevato nel novembre del 2009 e di 0,9 rispetto al mese precedente.
Non consola sapere che nello scorso autunno era comunque al 20 per cento anche nell’area euro. Non consolano le parole del Capo dello Stato, che in occasione del messaggio diffuso l’ultimo giorno dell’anno, proprio sui giovani e sulla questione lavoro si è particolarmente soffermato.
Il silenzio dei giovani
Nulla è cambiato negli ultimi sei anni: tutto è già stato detto e scritto ancora prima che la crisi si manifestasse sui mercati e che diventasse reale attraverso ancor più radicali tassi di disoccupazione.
Si avverte, però, un silenzio disarmante e doloroso: quello dei diretti interessati, i giovani, narcotizzati da un sistema sociale nel quale il lavoro rischia di non essere più un diritto, uno spazio (non unico ma importante) di socializzazione e di crescita.
È scorretta una riflessione che generalizzi la condizione giovanile, che uniformi i giovani fra di loro: coloro che vivono a Milano e coloro che vivono a Palermo; coloro che hanno alle spalle una laurea (solo un quinto della popolazione giovanile) e coloro che già a 15 anni cercano disperatamente un lavoro.
Lo stesso dato Istat racconta, se letto in profondità, che la percentuale di disoccupazione giovanile è ancora una volta maggiore nel Mezzogiorno e che dunque l’Italia, anche in questo caso, esprime realtà diverse fra di loro.
Alla sofferenza di faticare nel trovare un lavoro – che sia tale secondo l’accezione più moderna e che non sia una forma di sfruttamento sotto le mentite spoglie dello stage, del contratto di apprendimento e persino del volontariato – si affianca il patimento di non trovare un supporto nel mondo adulto, sovente distante e incapace nel cogliere le trasformazioni del mercato del lavoro avvenute negli ultimi 15 anni.
I genitori, che da un lato risultano fungere da veri e propri ammortizzatori sociali durante i periodi di disoccupazione (anche se le famiglie si dimostrano sempre più fragili nello svolgere questa funzione), caricano di ansia i giovani, frequentemente ritenuti incapaci nella ricerca di un’occupazione o nel mantenimento di essa (attraverso un contratto a tempo indeterminato). Ciò genera incomprensioni e conflitti. La medicina del lavoro segnala questo tipo di tensioni (e dunque non solo quelle create nei luoghi di lavoro dalla relazione con i propri colleghi) fra quelle che stanno alla base di disturbi patologici, talvolta di natura psicosomatica. Dietro al dolore organico si nasconde una forte tensione emotiva legata a un disagio lavorativo, all’ansia di non trovare una giusta collocazione professionale, all’impossibilità di cogliere un senso nell’attuale mercato del lavoro e, infine, al confronto con le storie professionali dei propri genitori.
Spesso le esperienze di questi ultimi non vengono contestualizzate: genitori e figli fanno dei paragoni come se non fossero intervenuti dei cambiamenti radicali nel mercato del lavoro, come se i meccanismi di ingresso e di permanenza fossero invariati fra generazioni. Ciò non fa altro che creare malesseri, incomprensioni, sofferenze dell’anima che talvolta significano fallimento dell’io ideale.
Un’indagine Istud
Altro elemento patologizzante è la discontinuità lavorativa, la mancanza di contratti che possano permettere al giovane di progettare, di investire sul proprio futuro con maggior serenità. In attesa che il contesto sociale, culturale ed economico sia in grado di cogliere e assorbire positivamente i cambiamenti del mercato del lavoro, offrendo quelle garanzie che nell’oggi buona parte dei contratti non offrono, i giovani – con un’età compresa fra i 25 e i 34 anni – sono affetti da stress lavorativo con un’incidenza significativamente maggiore rispetto ai colleghi senior, secondo un’indagine Istud1; inoltre, sempre secondo la medesima rilevazione, fra questi chi ha un contratto a scadenza è percentualmente più fragile rispetto a chi ha una situazione lavorativa stabile e definita nel tempo (sono proporzionalmente il doppio). Una delle possibili motivazioni per i ricercatori Istud è da cercarsi nell’impossibilità di attribuire un significato al lavoro svolto; il lavoro, come già accennato, è svuotato di qualsiasi significato sociale e relazionale: è un dovere per poter pensare alla propria sopravvivenza quotidiana. Non è, e questa distinzione allontana di molto la generazione più giovane da quella più adulta, un’occasione per guadagnare e concretizzare progetti futuri; non è uno spazio di confronto e di scontro finalizzato a una crescita e a un consolidamento professionale, sociale e umano.
Il lavoro, se c’è, ha significato nell’oggi: così viene percepito e così viene vissuto, svuotandosi di ogni senso altro, di ogni valore politico (inteso come di costruzione della pòlis) e di ogni aspettativa. All’interno di questo scenario è difficile per i giovani cogliere l’importanza del rispetto dei diritti dei lavoratori; in molti casi gli stessi diritti sono ignorati o negati. In questi casi il giovane pensa che sia più importante portare a casa un compenso: il contratto, la cura dei diritti, il riconoscimento della persona e delle sue istanze sono collaterali.
L’impressione è che l’osservanza dei diritti sia solo un impedimento e che laddove ci si trovi a lavorare in un contesto strutturato anche come luogo di crescita, di confronto e di rispetto (secondo l’accezione di Sennett2) ci si ritiene privilegiati, si è stupiti di quella che dovrebbe essere l’ordinarietà. Un regolare contratto di lavoro firmato dopo anni di stage e di incertezze viene di continuo visto come la consuetudine: prima lo sfruttamento e poi, in un ipotetico futuro, un contratto. Le organizzazioni danno per scontato tutto ciò – anche quelle meritorie e senza fini di lucro – e i giovani si trovano così a considerare come regolare una situazione che normale non è e che ha solo del paradossale e dell’illegale.
I giovani subiscono ma non ne hanno una consapevolezza così come non l’avevano i loro coetanei parecchie generazioni fa, soggiacendo a un mercato del lavoro nel quale non si parlava di Statuto dei lavoratori e di diritti sindacali; e così come non l’hanno i loro coetanei che vivono in quei paesi che nell’oggi permangono in una condizione di povertà.
Un nuovo fordismo?
Per alcuni versi pare che ci sia una continuità fra l’attuale condizione lavorativa giovanile e quella della fase fordista: anni di lotte sindacali buttati al vento e un lavoro subito.
Che cosa è avvenuto? Perché ci troviamo in questa situazione nella quale manca un moto di indignazione, un urlo di disperazione dei giovani?
I processi culturali richiedono anni per consolidarsi e per poter essere definiti tali; l’impressione però è che in alcuni contesti ancor più che in altri (per esempio più nelle città che nelle aree extraurbane, più al Nord che al Sud, più a Milano che a Palermo, più fra i laureati che fra i giovani che non lo sono) si stia diffondendo e consolidando una rappresentazione di lavoro come autonomo e flessibile3.
Di per sé tale idea non contiene elementi deprecabili. Che un giovane nell’oggi, e con tutta probabilità anche ieri, sia maggiormente attratto da percorsi lavorativi che gli permettano di sperimentarsi in modo autarchico e che siano definibili in modo diretto, per quanto riguarda la gestione del tempo e della mobilità, è ovvio.
Flessibilità e ansia
L’attuale contesto sociale rende tutto illusorio e fragile: mancano i presupposti di un lavoro che pur essendo autonomo e flessibile garantisca tutele previdenziali e salari equi. Il giovane è portato a pensare che alcuni diritti e alcuni meccanismi di protezione possano essere acquisiti nel tempo, procedendo nel proprio iter lavorativo, conseguendo professionalità. L’acquisizione di tali diritti e di tutele spesso si procrastina all’infinito e la sensazione che la flessibilità non sia sempre la strada migliore affiora e si manifesta, talvolta anche attraverso ansia e stress. E le fatiche dei ventenni diventano così le fatiche dei trentenni.
Il lavoro deve nuovamente tornare a essere tematizzato soprattutto all’interno di quei mondi che incontrano i giovani: la scuola, l’università, l’associazionismo (in ogni sua forma). Non sono contesti attraverso i quali incrociare l’universo giovanile nella sua totalità ma attraverso questi iniziare ad accostarne delle parti. I giovani prima ancora di sentirsi dire che il mercato del lavoro li respinge, che è difficile accedervi, che la crisi si abbatte su di loro, devono essere messi nella condizione di comprenderne i meccanismi, le regole e soprattutto di conoscerne le condizioni di regolarità, equità e legalità. Nel nostro paese sono presenti meritorie organizzazioni che si sono occupate e si occupano di lavoratori e di tutela dei loro diritti; le stesse dialogano sempre di meno con i giovani, si dimostrano distanti dal conoscere l’attuale condizione giovanile e dal cogliere le storture del mondo del lavoro giovanile. È anche su queste che vale la pena forzare l’interesse per i giovani, premere per un riavvicinamento a quella generazione che pare aver perduto la consapevolezza dei propri diritti.
Il rischio (in alcuni contesti già realtà conclamata) è che il lavoro sia riconosciuto teoricamente come un diritto senza una prassi che lo faccia vivere: discusso e tematizzato ma spoglio di concretezza, di ricadute propositive, di pratiche che contraddicano il temuto sfruttamento giovanile. E questo è inaccettabile.
I giovani devono essere accompagnati nell’acquisire professionalità e nella ricerca di un lavoro e, parimenti, devono essere supportati anche nel conoscere quelli che sono i loro diritti, che un giorno poi dovranno riconoscere ai loro colleghi. È un processo che deve riattivarsi, tornare a generare riflessioni non solo a partire dalle rilevazioni statistiche, ma anche dalle pratiche lavorative che si sono andate consolidando nelle organizzazioni per tornare a generare una cultura dei diritti e dei contratti rispettosi di essi.
1 D. Boldizzoni, M.E. Sala (a cura di), Generazione Y, Guerini e associati, Milano 2009.
2 R. Sennett, Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali, Il Mulino, Bologna 2004.
3 C. Buzzi, A. Cavalli, A. de Lillo (a cura di), Rapporto giovani. Sesto rapporto dell’istituto Iard sulla condizione giovanile in Italia, il Mulino, Bologna 2007.
Il conflitto intergenerazionale
Alberto Guariso
Ci sono accordi che non necessitano di una sanzione giuridica perché traggono da se stessi la forza per essere rispettati.
Il «patto tra le generazioni» (per usare un termine abusato ma efficace) sembrerebbe a priva vista proprio uno di quelli, essendo un patto che ciascuno stipula con se stesso in vista della propria vecchiaia o con i propri figli (una «controparte» cui normalmente si è piuttosto affezionati) per garantire loro una vita più serena; insomma è un po’ come un’assicurazione sul futuro e dunque rispettarlo sembrerebbe nella natura delle cose. D’altra parte, tra i vari fattori che possono determinare disuguaglianza, l’età è l’unica condizione personale nella quale tutti – prima o poi, e salvo eventi sfortunati – devono passare e dunque sembrerebbe inconcepibile che possa diventare fattore di conflittualità e divisione.
Eppure proprio questo accade, e non da ora.
Si spiega così perché il legislatore – evidentemente poco fiducioso nella naturale capacità dei vari gruppi anagrafici di convivere pacificamente – ha messo nero su bianco alcune regole, dapprima sommarie, poi via via più analitiche.
Il divieto di discriminazione in base all’età
Ha cominciato il legislatore costituzionale che ha bensì trascurato l’età dalla breve elencazione contenuta nella Costituzione all’articolo 3 1, ma si è poi subito premurato di precisare, all’articolo 37, che la minore età non costituisce di per sé un motivo legittimo per una retribuzione inferiore, a parità di lavoro.
Molto di più ha fatto il legislatore comunitario che ha scolpito nell’art. 19 dell’odierno «Trattato sul funzionamento dell’Unione europea» (come dire il patto fondamentale su cui si regge la nuova cittadinanza europea) il divieto di discriminazione per ragioni di età, cioè un deciso no a che l’appartenenza ad un determinato gruppo anagrafico possa per se stessa diventare motivo per «svantaggi sociali». E ha poi proseguito con l’art. 21 della Carta europea dei diritti fondamentali (che, tra le altre, vieta le discriminazioni basate sull’età) e con una direttiva del 2000 (la numero 78, applicabile solo nell’ambito dei rapporti di lavoro) che ribadisce e specifica il medesimo divieto.
A dispetto della sua apparenza più culturale che normativa, appartiene dunque al fondamento stesso della nostra cultura giuridica occidentale, il principio secondo il quale il trascorrere o non trascorrere degli anni non può di per sé stesso diventare motivo per ridurre quel bagaglio di diritti che fa capo alla persona in quanto tale, in qualunque età della vita si trovi; anzi, il divieto di discriminazione (cioè di «trattamenti di svantaggio») correlata all’età costituisce – per usare le parole della direttiva 78 – una condizione ineludibile per conseguire «un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone».
Come era facilmente prevedibile, tanta attenzione da parte del diritto è stata facile motivo per portare il conflitto tra gruppi anagrafici nelle aule giudiziarie, specialmente in quelle comunitarie.
Basta scorrere sommariamente una rassegna delle pronunce della Corte di Giustizia per scoprire che da quando il tema della parità di trattamento ha varcato le soglie della sola parità tra uomini e donne (cioè, più o meno, dalle direttive comunitarie del 2000) la Corte di Giustizia dell’Unione si è occupata una sola volta di discriminazione per ragioni di origine etnica, non si è mai occupata di discriminazione per motivi religiosi (i due temi che cioè tengono il campo nel conflitto sociale) ma si è occupata almeno una quindicina di volte di discriminazioni per ragioni di età; e il calendario delle prossime udienze indica ulteriori occasioni per tornare sulla questione.
L’assalto è avvenuto prevalentemente nel campo del diritto del lavoro (nel quale, come si è detto, il divieto di discriminazione per età è stato ulteriormente specificato dalla direttiva 2000/78) e si è mosso su più fronti: da un lato chi preme per contrastare qualsiasi sottovalutazione del lavoro giovanile; dall’altro chi si oppone alla riduzione di tutele per i lavoratori anziani (prima fra tutti la licenziabilità del lavoratore giunto alla pensione); dall’altro ancora quanti premono per una eliminazione dei limiti massimi di età per accedere a determinate professioni.
Un bilancio della vicenda volto a capire quale può essere il ruolo del diritto nel ripristinare un patto tra le generazioni, sarebbe assolutamente fuori luogo, essendo il percorso ancora completamente aperto: certo è che – questioni squisitamente giuridiche a parte – le pronunce della Corte di Giustizia qualche segnale di buon senso lo danno.
In primo luogo sfatano il preconcetto che, nel mercato del lavoro, qualsiasi «sconto» predisposto per una determinata fascia anagrafica sia di per sé un vantaggio, perché favorisce sempre l’ingresso al lavoro degli appartenenti a quella determinata fascia anagrafica. Non è così: e il postulato secondo il quale il mercato compra sempre ciò che costa meno, si può rilevare un mero e dannoso preconcetto.
La politica italiana ha sul punto una grande tradizione, prevalentemente in danno dei giovani, con ripetuti tentativi di introdurre salari di ingresso, con fittizi contratti di formazione, con contratti di inserimento, tutti allegramente giustificati dal postulato che queste misure si sarebbero rapidamente tradotte in vantaggio per giovani resi più appetibili sul mercato.
L’esperienza ha dimostrato che non è così e l’esito è stato un aumento della disoccupazione e del precariato giovanili, mentre si sta finalmente avvertendo che le politiche di sostegno ai giovani sono assai più complesse e attengono, molto più che al campo degli «sconti», al campo della formazione.
L’orientamento dell’Unione europea
È dunque del tutto logico che la Corte di Giustizia richiami il legislatore a una forte, per quanto difficile, verifica fattuale: qualunque misura connessa all’età è soggetta a una «elevata soglia probatoria» (sentenza Age Concerne England, 2009, in una causa che, come si vede dal nome del ricorrente, era promossa da una associazione di tutela degli anziani) nel senso che deve poter essere rigorosamente accertato che quella misura ha davvero, sul piano pratico, effetti benefici, e non svantaggiosi, sul gruppo anagrafico; questa verifica può avvenire solo se l’età non è presa in considerazione «in quanto tale», ma connessa ad ulteriori caratteristiche personali, come un lungo periodo di disoccupazione o una carenza di formazione professionale o simili. Quest’ultima è la prima e più nota delle sentenza (Mangold 2005) relativa a una legge tedesca che consentiva di assumere a termine, senza bisogno di specifiche motivazioni per l’apposizione del termine, tutti i cittadini di età superiore a 52 anni: secondo la Corte, con misure di questo tipo si finisce per relegare in una condizione di precarietà tutti gli ultracinquantaduenni, ai quali nessun datore di lavoro offrirà più un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per lo stesso motivo, il lavoro giovanile non può essere svalutato in quanto tale e così non sono compatibili con il diritto comunitario norme che, ai fini della carriera, pretendano di non tenere conto della esperienza professionale maturata prima dei 25 anni (sentenza Kukukde-veci, 2010) o prima dei 18 anni (sentenza Hutter 2009).
Ha invece passato il vaglio della Corte il principio per cui l’accesso a determinate professioni possa essere sottoposto a limiti massimi di età (sentenza Colin Wolf, 2010, in materia di accesso al corpo dei vigili del fuoco) ma soprattutto ne è uscita indenne (per ora, ma si prospettano a breve ulteriori contenziosi) la madre di tutte le questioni, cioè la libera «licenziabilità» del lavoratore anziano, titolare di un trattamento pensionistico, recepita nel nostro ordinamento nella normativa generale sui licenziamenti e rafforzata, per il pubblico impiego, dalle recenti norme sulla cosiddetta «rottamazione» dei pubblici dipendenti (che consentono il licenziamento del dipendente che abbia raggiunto i 40 anni di contributi).
Secondo la Corte europea la finalità di ripartire le opportunità occupazionali tra le generazioni è legittima e giustifica anche l’adozione di misure di svantaggio per gli anziani (sentenza Petersen 2010 o ancora Age Concerne England 2010) ma anche questa prospettiva deve essere sottoposta a un vaglio rigoroso, per accertare se davvero la misura ha l’effetto di favorire questa ripartizione, o ha mere finalità di risparmio, che di per sé non giustificherebbero l’adozione di norme correlate all’età.
Quest’ultimo punto è indubbiamente quello più delicato ove anche l’ordinamento italiano si è mosso in perenne schizofrenia tra norme volte ad anticipare l’età pensionabile per favorire il ricambio generazionale (chiunque viaggi sui treni avrà notato il clamoroso ringiovanimento del personale di controllo, ma non può non pensare all’altrettanto clamoroso rinfoltimento della schiera di pensionati giovani o semi-giovani) e norme volte a favorire il prolungamento della vita lavorativa a fini di risparmio pensionistico.
Su tutto ciò dunque il diritto comunitario, nonostante la solennità con la quale ha sancito il principio di parità, lascia poi ampio spazio per soluzioni ragionevoli volte a contemperare le varie esigenze in gioco.
Resta tuttavia, a fianco della ambizione – forse eccessiva – che il conflitto intergenerazionale possa essere risolto per via normativa, un sollecitazione decisiva offerta alla riflessione collettiva: quello secondo cui il principio di uguaglianza (con tutti i limiti e i difetti che può avere) non si modula a seconda del trascorrere degli anni e resta immutato nel corso della vita, a garanzia della dignità personale di ciascuno; e ciò costituisce addirittura uno dei principi fondamentali sui quali si regge l’Unione Europea (così espressamente la sentenza Mangold).
Non è molto e forse l’affermazione risente di una certa astrattezza di tanti principi giuridici. Ma è comunque qualcosa, in periodi in cui i gruppi sociali anagrafici (talvolta i giovani, talvolta gli anziani, talvolta i quarantenni) avvertono attorno a loro una sproporzionata e ingiustificata riduzione di opportunità, determinata proprio e esclusivamente dalla data di nascita.
1 «…senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali». Art. 3, comma 1.
Cosa può fare l’università
Giorgio Ferri
Tre vecchi, in copertina1, in faticoso movimento e aiutati da un malfermo bastone.
Questa, si intuisce, è la generazione che ha tradito i giovani italiani, malcapitati nel terzo millennio.
L’immagine è di Beppe del Greco ma l’idea, anzi la convinzione, è di Pier Luigi Celli.
Il direttore generale della Luiss (Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli, Roma), già direttore generale della Rai, qualche tempo fa ha pubblicato nella prima pagina di un quotidiano una lettera aperta al figlio2, scatenando un vero putiferio. Lo invita ad andare all’estero, perché «questo paese, il tuo paese non è più un posto dove si possa stare con orgoglio […] è un paese in cui, se ti va bene, comincerai guadagnando un decimo di un portaborse qualunque; un centesimo di una velina o di un tronista; forse poco più di un millesimo di un grande manager che ha all’attivo disavventure e fallimenti che non pagherà mai. […] Scegli di andare dove ha ancora un valore la lealtà, il rispetto, il riconoscimento del merito e dei risultati». La cosa curiosa, ma non insolita in Italia, è che quel messaggio accorato non ha incentivato le riflessioni sul destino professionale dei neolaureati, ma ha provocato insulti alla persona dell’autore (la colpa è anche tua, dimettiti etc.).
Tuttavia, il tema del futuro dei giovani italiani ha occupato l’intero 2010. Verso la fine dell’anno anche i giovani, prima silenziosi, hanno cominciato ad occuparsi di se stessi avendo ben capito che i tagli al finanziamento dell’istruzione sono tagli al loro futuro. Per avviare questo dibattito l’artificio retorico utizzato da Celli (una lettera al figlio) è stato utile. Lui stesso è intervenuto, questa volta con un libro, per chiarire il senso della sua denuncia e per fornire elementi oggettivi (dati statistici) e elementi tratti dalla sua esperienza di manager che dal 2005 opera sul confine tra università e lavoro.
Alcuni dati
«… quasi il 60 per cento dei circa due milioni e mezzo di disoccupati italiani ha oggi, secondo i dati Ocse, meno di 34 anni»3. Se si incrocia questo dato con la situazione economica dell’Italia, a tutti nota e che Celli richiama, si deduce che è stata innescata una bomba sociale che, quando esploderà, provocherà danni non misurabili. Le centinaia di migliaia di giovani che oggi hanno un lavoro precario o in nero o non lavorano non avranno, da anziani, un trattamento previdenziale che consenta la sopravvivenza. Cosa faranno? Vivranno a spese del bilancio pubblico? Di carità privata? Celli non si spinge fino a porre queste domande, ma è inevitabile formularle partendo da tutte le premesse che lui elenca. A mio parere non se le pongono nemmeno gli adulti che questa bomba hanno costruito, dato che quando esploderà… loro non ci saranno più.
«… per quanto riguarda la fascia di età tra i 15 e i 29 anni […] circa un terzo è senza lavoro […] con percentuali, al Sud, intorno al 40 per cento e con fenomeni drammatici di ripresa dell’emigrazione, soprattutto nelle fasce di istruzione elevata: studenti, laureati, personale qualificato»4. Quale paese ha in mente chi lascia che tutto questo accada senza fare nulla? Celli parla apertamente di fallimento della politica e poi attinge alla sua esperienza di operatore culturale e di manager per indicare alcuni nodi critici da affrontare: in particolare l’università e l’impresa.
L’università per gli studenti
Non sono molte le voci che si levano in questo paese per sostenere che non bisogna «lasciare l’università solo ai professori». Celli dedica un intero capitolo per dimostrare come «l’università vada sottratta, almeno in parte, al potere pervasivo, autoreferenziale e sostanzialmente irresponsabile degli accademici […] proprio nel tentativo di salvare il loro vero mestiere e la loro reputazione»5.
Il ragionamento è semplice: l’università è organizzata intorno alla didattica e alla ricerca (possibilmente di qualità) e questo è il primo dovere dell’istituzione; ma ve n’è un secondo, che legittima il primo: «la preparazione degli studenti al loro futuro occupazionale […] Proprio perché il mondo che li aspetta […] è molto più complesso di un tempo, si presenta con caratteristiche di provvisorietà e frammentazione che richiedono competenze ben più estese delle conoscenze curricolari trasmesse, diventa necessario ripensare a cosa serve all’università per non fallire il suo scopo principale, che è quello di preparare per la società le sue componenti pregiate»6.
Partire da questo punto di vista, il futuro degli studenti, comporta una minore attenzione allo status dei docenti e ai meccanismi concorsuali e la consapevolezza che «bisogna rassegnarsi al fatto che il mondo dell’impresa, delle professioni, delle istituzioni, la stessa società civile hanno titolo per intervenire ed esprimere pareri, esigenze, proposte»7. Una collaborazione che potrebbe «dare una diversa dignità e un senso più condivisibile al biennio magistrale, anticipando agli anni di università alcune di quelle variabili formative che un tempo venivano assicurate dalle imprese nella prima fase di assunzione del laureato, e che l’attuale precarietà dei rapporti, con tutta la frammentazione degli inserimenti multipli, non consente più di fare compiutamente»8.
L’anima delle imprese
E va bene: quello delle università non è un mondo perfetto; per migliorare dovrebbe aprirsi, tra l’altro, al mondo delle imprese. Ma quest’ultimo quale contributo è in grado di dare? Celli non si illude e non ci illude: «Cresce un’ideologia gestionale – che è diversa e più infida della semplice adozione di strumenti corretti di gestione – la quale affida alla performance, al numero, la certificazione della propria salute, indipendentemente dalle motivazioni e dalla soddisfazione di chi quelle prestazioni è chiamato a realizzare […] l’impresa è diventata oggi un mondo in guerra, teso alla conquista e all’eliminazione dei concorrenti; e all’interno propone la stessa logica: adesione o emarginazione»9.
Se ripenso alla mia esperienza personale trovo la piena conferma di questa analisi di Celli, ma con una precisazione: è un’analisi che riguarda soprattutto le organizzazioni di grande dimensione, dove tutto è espresso in dati quantitativi (i più facili da rilevare) e le persone sono numeri, sia i collaboratori che i clienti. Questo disumanizza anche i dirigenti che vivono in continua tensione, perché devono «fare i numeri» sui quali vengono giudicati, col risultato che a volte «danno i numeri», come mi testimonia un amico psicologo che, tra i suoi pazienti, vede aumentare di anno in anno il numero (appunto) di manager stralunati.
Molte organizzazioni di media dimensione (non tutte, purtroppo) hanno una logica diversa: le persone hanno un nome, un cognome, una storia personale e professionale conosciuta e compresa; le relazioni non sono asettiche, sono più calde, magari conflittuali ma tra esseri viventi. Si lavora moltissimo ma questo produce stanchezza non alienazione. I proprietari e gli azionisti sono del mestiere: conoscono e amano il prodotto o il servizio frutto dell’impegno dei loro collaboratori. Non sono gruppi finanziari o fondi pensione che non hanno idea di quello che stanno finanziando e che si interessano solo alla quotazione della azioni e alla distribuzione di dividendi.
Le piccole imprese non le conosco, ma suppongo che abbiano un’anima se l’imprenditore è una persona onesta.
Ma torniamo a Celli: cosa propone perché l’università collabori con l’impresa, nell’interesse degli studenti e dei giovani occupati? Che la prima esca dall’autoreferenzialità e che la seconda non si limiti alla sola logica quantitativa.
Alcuni esempi di collaborazione
«Con il nome di “Italia-Camp” ha preso il via un progetto che aggregando una decina di università, molte imprese e personaggi di rilievo del mondo economico e istituzionale, prevede la realizzazione, secondo un’agenda precisa, di quattro luoghi di confronto-discussione nei quali studenti e membri della classe dirigente si misurano intorno a temi socialmente rilevanti e a progetti da realizzare»10. Uno di questi luoghi è al Sud, uno al Centro, uno al Nord e uno a Bruxelles. L’obiettivo è di raccogliere un certo numero di idee imprenditoriali da tradurre in pratica in occasione dei centocinquant’anni dello Stato italiano.
Un secondo esempio riguarda la Calabria, il cui presidente ha contattato la Luiss e la Bocconi (insieme per la prima volta) «per un progetto ambizioso: aprire un corso annuale, da ripetere per più anni, destinato alla formazione mirata di laureati della regione, ovunque sparsi, da preparare per assumere responsabilità via via rilevanti nel pubblico impiego e nella sanità, così da rinnovare una classe dirigente particolarmente bisognosa di professionalità adeguate»11. Il progetto è già stato formalizzato e ufficializzato.
Celli conclude così: «Si tratta, com’è ovvio, di esempi, tentativi ragionati che comportano difficoltà e rischi. Ma a noi sembra importante dimostrare che ci si può provare e che esistono nel Paese risorse e uomini in grado di assumersi queste responsabilità, indicando anche alla classe politica una strada, nella speranza che poi le decisioni e i supporti operativi possano emergere e venire applicati»12.
1 P.L. Celli, La generazione tradita. Gli adulti contro i giovani, Mondadori, Milano 2010.
2 P.L. Celli, Figlio mio lascia questo paese, La Repubblica, 30 novembre 2009.
3 P.L. Celli, La generazione tradita, op. cit., p. 81.
4 ibidem, p. 80.
5 ibidem, p. 59.
6 ibidem, p. 61.
7 ibidem, p. 63.
8 ibidem, p. 65.
9 ibidem, p. 98 e p. 102.
10 ibidem, p. 127.
11 ibidem, p. 129.
12 ibidem, p. 130.