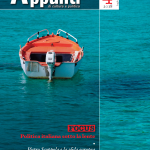Appunti 5_2010
FOCUS: Il federalismo all'italiana
Da vent’anni ormai in Italia il tema del federalismo è entrato nell’agenda politica e delle riforme istituzionali. Da allora, alcuni passi in questa direzione sono stati compiuti. Nel 1999 e nel 2001 sono state approvate riforme costituzionali che hanno introdotto, tra l’altro: il rafforzamento dell’autonomia regionale nell’approvazione degli statuti e della propria forma di governo; la redistribuzione delle funzioni legislative, con l’ampliamento delle materie di competenza delle regioni; il ridisegno della pubblica amministrazione con al centro il comune (anziché i ministeri statali), in quanto ente più vicino al cittadino ecc. Il dibattito si è ora riacceso, perché il governo sta cercando di dare attuazione al profilo fiscale del federalismo che tocca i confini dell’autonomia finanziaria degli enti locali e delle regioni e dunque incide sulle risorse economiche a disposizione delle collettività per perseguire i fini dell’azione politica, erogare i servizi pubblici e amministrare il proprio territorio.
Il federalismo tra speranze e ambiguità
Filippo Pizzolato
Il federalismo non può che essere anche fiscale
Oltre tutto, in un tempo segnato da una gravissima crisi di credibilità delle istituzioni politiche, la responsabilizzazione, anche e soprattutto sul versante finanziario, della classe politica rispetto alle scelte che compie rappresenta uno strumento potenzialmente utile a riattivare un rapporto sensato tra gli elettori e gli eletti. La grande (e crescente) distanza che si è creata tra governanti (non a caso etichettati come la «casta») e i governati costituisce in democrazia un problema acuto ed esige, oltre ad un’operazione culturale di lungo respiro, anche una strategia istituzionale efficace.
L’ottica cui mirare in questo processo riformatore deve però essere quella della ricostruzione di un quadro istituzionale sensato e cioè della riappropriazione da parte dei cittadini della sfera pubblica, di cui non si può fare a meno. In questo arduo cammino, il federalismo fiscale (purché non disgiunto da meccanismi perequativi di redistribuzione) sembra un passaggio difficilmente eludibile.
Nel processo di responsabilizzazione degli amministratori locali va ad esempio inserito il complesso e importante lavoro in atto di definizione dei «costi standard» con cui possono e debbono essere rese le prestazioni pubbliche (in ambito sanitario, di assistenza e di istruzione). A questo «costo standard» devono tendere le pubbliche amministrazioni, con il conseguente superamento del criterio di finanziamento basato sulla spesa storica (che fotografa le cose come – da sempre – sono andate, inefficienze comprese…).
La nobile idea del federalismo
Il federalismo, similmente al principio di sussidiarietà, aiuta a riconoscere e a valorizzare questa idea di un’unità politica di tipo relazionale e plurale e respinge invece l’obiettivo, che spesso degenera in ossessione, di un’unità intesa come «sintesi» in cui le parti affogano e restano indistinguibili. Il livello di aggregazione politica non deve essere un «poi» in cui muoiono – inghiottiti – gli stadi e le forme «precedenti» della relazione umana. L’unità politica può piuttosto essere pensata come un processo cooperativo che esprima la tensione e la partecipazione al bene comune delle differenti ed autonome articolazioni sociali e politiche. Come ha scritto un grande federalista (non a caso, europeista), di impostazione personalistica1, «l’unità non ha per telos quello di annullare le differenze, ma di esaltare la vivacità degli scambi comunicazionali». Si deve cioè mirare, per usare ancora una categoria di de Rougemont, a una «unità-diversità», ad un’unità che porti «dentro» le diversità, facendole convivere, permettendo che coesistano, curando che co-operino. La «soluzione federalista» consiste nel rispetto dei «termini antinomici in conflitto», rinunciando alla «riduzione dei termini ad uno» o alla «subordinazione dell’uno all’altro» (de Rougemont).
In questo modo, il federalismo si appoggia sull’idea di persona, e cioè su un’immagine dell’uomo che, quand’anche sia considerato come individuo («uno»), appare «già relazionato» (perché la sua identità si forma solo nella relazione). Se perfino l’identità personale si conquista grazie a sistemi di relazioni di cui reca tracce visibili, ciò a maggior ragione deve valere per identità complesse come quelle politiche. Addirittura, tale concezione del federalismo assume, come «stampo» originale di questa unità-diversità, il Dio cristiano, uno e trino, Dio ed uomo.
Non v’è dunque motivo, dal punto di vista del personalismo cattolico (e della Costituzione!) di temere il federalismo, che anzi rappresenta una soluzione potenzialmente virtuosa. Esso dà risposta originale anche alla preoccupazione liberale della divisione del potere, aggiungendone una versione di tipo territoriale, in quanto uno Stato accentratore rischierebbe di accumulare su di sé un potere di cui potrebbe abusare. Il federalismo è una prospettiva cui guardare con interesse e alla cui costruzione partecipare con coraggio.
Le ambiguità del federalismo «nostrano»
L’elemento più preoccupante è la persistenza di condizioni politiche che si pongono in frontale contraddizione con l’ispirazione federale verso cui si dichiara di voler procedere. E non si tratta di «sacche» minoritarie di resistenza di partiti rimasti legati a un modello centralistico di Stato, ma di vischiosità e contraddizioni interne a protagonisti centrali della scena politica.
Possiamo esprimere questa contraddizione con l’idea, riassuntiva, che la politica nazionale manifesta, nelle sue dinamiche e nei suoi attori, una tendenza centripeta, volta cioè all’accentramento del potere, in aperto conflitto con un’ispirazione genuinamente federale. Un primo importante profilo di questa vocazione accentratrice è la natura tutt’altro che federale dei partiti politici, anche di quelli che più si ispirano al federalismo. Il modello organizzativo e di funzionamento dei partiti mostra evidenti tratti di un rigido centralismo, dominato dalla presenza ingombrante di una leadership fortemente personalizzata e mal disposta verso un modello di articolazione plurale delle decisioni. Viene spontaneo chiedersi come potranno soggetti che poco o nulla hanno di federale, come i partiti, costruire un genuino sistema istituzionale che valorizzi l’espressione delle autonomie.
Legata a questa obiezione sulla struttura centralistica dei partiti è una seconda ambiguità che riguarda, questa volta, specificamente la maggioranza di centro-destra al governo del paese che si è posta l’obiettivo (incalzato soprattutto dalla Lega) dell’attuazione del federalismo. In questa maggioranza, la presunta vocazione federalistica convive con disinvoltura assai sospetta con la continua richiesta, da parte del presidente del Consiglio Berlusconi, di un rafforzamento del potere monocratico del «capo» del governo. È davvero difficile immaginare come possano conciliarsi un’idea federale della repubblica, da intendersi come garanzia di pluralismo sociale e istituzionale, con questa dichiarata volontà di imporre una drastica semplificazione al quadro politico e ai processi decisionali. In tutti gli studi che abbiano una qualche dignità scientifica si sostiene la tesi di una inconciliabilità – peraltro del tutto logica – tra il federalismo e il governo dell’uomo forte. Berlusconi ha più volte esternato la sua concezione della democrazia, in cui il pluralismo sociale, lasciando spazio all’investitura maggioritaria di un capo, perde ogni rilevanza politica. Niente di più lontano da una prospettiva federale…
Questa schizofrenia tra velleità dichiarate di federalismo e pratiche di gestione accentrata del potere è puntualmente esplosa nelle scelte finanziarie adottate dal governo attuale che, come prima mossa di insediamento, ha scelto di tagliare proprio le risorse più vitali per i comuni, quelle derivanti dall’Ici, anziché «dimagrire» le imposte e gli apparati amministrativi dello Stato centrale. Il taglio autoritario di una importante fonte di finanziamento dei governi locali non è certo un provvedimento in linea con il federalismo e infatti i sindaci di tutte le casacche (anche quelle verdi) non hanno mancato di protestare contro queste scelte che affamano i conti pubblici dei comuni. L’eliminazione parziale dell’Ici e il blocco delle addizionali, deciso dal governo in attesa del federalismo fiscale, hanno messo in ginocchio gli enti locali, già in difficoltà a causa delle rigidità imposte dal patto di stabilità interno. I comuni sono così costretti a cercare risorse in modo, per così dire, più fantasioso, facendo frequente ricorso ai cosiddetti oneri di urbanizzazione che sono una contropartita della svendita del territorio, sempre più densamente costruito.
La carenza di un contesto politico capace di incarnare una dinamica autenticamente federale si riscontra in ulteriori elementi che appesantiscono il quadro già quasi compromesso: la valorizzazione delle autonomie, ad esempio, esigerebbe come logico corollario che si procedesse a riequilibrare anche il circuito della responsabilità politica. Occorrerebbe cioè che i cittadini smettessero di identificare nel governo tout court il soggetto responsabile – nel bene e nel male – di tutte le decisioni politiche e acquisissero una capacità di discernimento dei reali centri di responsabilità (ad esempio, per la sanità, le regioni). E tuttavia l’acquisizione di questa consapevolezza è resa difficile dal modo in cui è organizzata la comunicazione politica (soprattutto quella televisiva, sin troppo influente) che passa attraverso un sistema, ancora una volta, fortemente concentrato sulle dinamiche – anche se poco significative – nazionali.
L’assenza dell’orizzonte europeo e la sindrome di Adro
Se ci si muovesse nell’alveo dell’idea personalistica di federalismo, che si è descritta come costruzione di un’unità che abbia dentro la diversità, l’operazione di redistribuzione dei poteri e delle risorse all’interno dello Stato non potrebbe andare disgiunta da una riflessione sull’apertura necessaria a un orizzonte sovranazionale, ed europeo in particolare. Non a caso, il movimento federalista europeo è stato storicamente un motore dell’integrazione europea e insieme ha offerto una testimonianza credibile di una cultura politica federale.
L’assenza (o almeno la forte marginalizzazione) di questa prospettiva di apertura desta preoccupazioni, perché può essere l’indicatore di un processo che lavora per indebolire (dividere) i legami sociali, anziché per allargare il raggio delle relazioni di solidarietà umana. In effetti, gli Stati federali di più lunga storia e di più sicura ispirazione (Stati Uniti, Germania ecc.) sono sorti grazie a un movimento storico di apertura e ad un’alleanza (il foedus) tra entità politiche che un tempo erano indipendenti e che hanno scelto di unirsi per affrontare sfide comuni. La sfida del cambiamento climatico e quella della costruzione di un governo dell’economia e della finanza rappresentano problematiche imponenti e comuni, in grado di giustificare pienamente e anzi di invocare il perseguimento di una coraggiosa strategia di integrazione politica sovranazionale da parte degli Stati europei.
In Italia, il dibattito sul federalismo appare invece viziato da velleità isolazionistiche e da nostalgie localistiche, e non a caso è nato e si è sviluppato attorno ad una versione assai aggressiva di quel modello, comprensiva della minaccia secessionistica. È come se si pretendesse di «isolare» non più solo un’identità nazionale, etnicamente omogenea, ma, entro questa, delle identità di tipo regionale o locale che si immagina siano originarie (quasi fossero dei fatti di natura). È sin troppo facile mostrare come un’idea di federalismo che si votasse a isolare presunte identità «pure» finirebbe con l’innescare un meccanismo di divisione distruttivo e senza fine (entro l’unità nazionale si può isolare l’identità lombarda; ma entro la Lombardia è possibile isolare identità diverse: i bergamaschi non sono certo «uguali» ai milanesi e ai bresciani…; ma anche dentro i bergamaschi è possibile individuare diversità – ci sono i valligiani, i cittadini e gli uomini di pianura – ; ma anche tra i valligiani, ad esempio, esistono diversità notevoli; e così via…).
La vicenda, davvero triste e penosa, della scuola di Adro nel bresciano (ma già si affacciano emuli locali in cerca di visibilità a poco prezzo…) è emblematica dei guasti che possono venire da un’interpretazione localistica del federalismo che riduce l’idea di pubblico (e di scuola pubblica) a spazio di occupazione della comunità locale e che, immettendo nei luoghi dell’educazione (e dunque dell’apertura) i simboli, maldestramente camuffati, di un’identità partitica, inevitabilmente si traduce in esercizio di sopraffazione che una parte sola della comunità esercita sulle altre.
Per un federalismo cooperativo
Quando il federalismo ripiega (come ad Adro) nel più opprimente dei localismi, esplode una contraddizione pesante perché le comunità, anziché essere ambiti di sviluppo (e di educazione) dell’autonomia e della libertà della persona, diventano luoghi di una relazione chiusa, egoista e diffidente. In queste comunità è la libertà a rimanere soffocata, racchiusa in un orizzonte troppo stretto.
Se si interpretano le identità locali come definitive e immutabili si compie un doppio e grave errore: si confonde con un dato di natura quello che è invece il frutto di una storia di incontri e di relazioni tra diversi; al contempo si pretende di fermare il moto incessante e mai concluso della costruzione dell’identità della persona. In natura non esiste l’italiano, come non esiste il bergamasco… Esiste solo l’uomo con il suo insopprimibile bisogno di libertà e di apertura.
1 D. de Rougemont, L’uno e il diverso. Per una nuova definizione del federalismo, Lavoro, Roma 1995.
Brevi note sul federalismo «nostrano»
Vincenzo Satta
Il paradosso italiano
Tale situazione, allo stato, non si è avverata, tant’è vero che, non più tardi dello scorso 7 ottobre, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo schema di un maxi-decreto delegato, attuativo in parte della l. n. 42/2009, contenente appunto la delega al governo in materia di federalismo fiscale. Proprio in questa singolare condizione di precarietà della disciplina legislativa del federalismo fiscale risiede il paradosso italiano. Infatti, la realizzazione di un processo, altrimenti governato dalla spinta degli enti sub-statuali (Stati membri, a federalismo compiuto), dipende dagli umori del legislatore statale. In altre parole, senza voler banalizzare, quando il legislatore decide, il federalismo si fa. Davvero un federalismo serio, non c’è che dire…
In verità, lo scenario che si sta dischiudendo nel panorama politico italiano conferma un dato incontrovertibile: il federalismo è un processo di costruzione progressiva dell’ordine statuale, alimentato dall’evoluzione storica delle comunità politiche che danno vita allo Stato federale. L’indiscutibile genesi storica di questi modelli di Stato aiuta a coglierne i caratteri del tutto particolari e a tenerli distinti dagli Stati unitari, come l’Italia, la Francia, o la Spagna che, al limite, si possono differenziare tra loro per i maggiori o minori spazi di autonomia politica e amministrativa che riconoscono agli enti territoriali di governo.
È sufficiente pensare al più antico, tra quelli contemporanei, degli Stati federali: gli Stati Uniti d’America. Dopo la dichiarazione d’indipendenza dalla corona inglese – è il 4 luglio del 1776 – le tredici colonie britanniche formatesi lungo la costa orientale del nord America diventano altrettanti Stati indipendenti e sovrani nei propri, rispettivi territori. Nel 1787, dandosi la Costituzione, essi si trasformano in un unico Stato, accordandosi sulla attribuzione al governo centrale di una serie di specificate competenze, quali la politica estera, quella economica, la difesa comune e altre. Contemporaneamente gli Stati federati continuano a mantenere il potere di fare le leggi sui rimanenti settori di intervento pubblico non espressamente devoluti al centro.
Il potere di decidere come distribuire le competenze e le funzioni tra i vari livelli di governo appartiene, all’origine degli Stati federali, agli enti che andranno a comporre l’unione. Per questo lo Stato federale è costituito da Federazione (centro) e Stati federati (periferia). Il fatto che questi ultimi scelgano di «consegnare» alcuni poteri propri, a un soggetto sovraordinato che su certi interessi generali decida al loro posto, lascia intendere il senso del federalismo storico: è la logica del patto, dell’associazione che dà sostanza a questo fenomeno. Sarà pure un’osservazione scontata, ma è opportuno ricordare che la parola federalismo deriva dal vocabolo latino foedus, che significa patto, associazione. Ogni logica tesa a imporre strategie di disgregazione dell’ordine vigente è pertanto intrinsecamente incongruente rispetto alla filosofia che innerva il processo di federalizzazione, cioè l’aggregazione, l’unione, appunto.
Il funzionamento delle unioni federali
Può essere utile un paragone, sicuramente ardito (se non addirittura improprio) sul piano tecnico-giuridico, ma utile per dare l’idea. Quando più persone decidono di formare un’associazione (ad esempio un partito) o una società commerciale (per esempio una società per azioni), accettano, mediante l’adesione all’atto costitutivo, che le decisioni riguardanti le attività e gli scopi sociali siano assunte dagli organi di governo (un comitato direttivo, un’assemblea dei soci, un consiglio d’amministrazione etc.). Ogni socio, su tutto quanto non attenga all’amministrazione o alla gestione dell’associazione, rimane totalmente libero di comportarsi come ritiene. Per converso, la governance dell’associazione o della società spetta agli organi sociali.
Questo schema, fatte salve le dovute, consistenti distinzioni, può aiutare a comprendere l’origine e il funzionamento delle unioni federali. In questa forma di Stato gli Stati membri continuano a esercitare funzioni o competenze di cui erano originariamente titolari; non esiste alcuna decisione del governo centrale che attribuisca loro funzioni o competenze. La genesi dello Stato federale scaturisce, semmai, dalla scelta degli Stati federati di darsi un governo comune, conferendo al centro un certo novero di competenze. In questo non si possono non riuscire a scorgere i segni dell’evoluzione storica che conduce una data comunità politica a originare un certo modello di statualità. Una volta formatasi questa nuova entità statuale, è conseguente che la Costituzione preveda che i processi di redistribuzione delle funzioni pubbliche siano co-gestiti dal governo dell’unione (central government) e dagli Stati membri. Essi infatti partecipano della sovranità dello Stato federale esattamente al pari dell’unione (federazione).
Il problema è l’attuazione della Costituzione
Il nostro sistema costituzionale è invece strutturato e organizzato, per ragioni storiche, a norma della Costituzione del 1948, secondo il modello – del tutto differente – dello Stato unitario regionale. In questo tipo di Stato l’attribuzione delle competenze non è co-decisa dal governo centrale e dagli enti autonomi: è il legislatore statale (parlamento) che stabilisce quale «livello» di governo debba svolgere certe funzioni. Ovviamente, quando allo Stato è costituzionalmente imposto di riconoscere e promuovere le autonomie locali (art. 5 Cost.), il legislatore è autorizzato a rivedere l’assetto delle competenze tramite l’applicazione di criteri di distribuzione (chi fa cosa, per intendersi!) simili a quelli dei modelli di Stato federale. È vero anche che l’obbligo, ormai certamente dotato di rilevanza costituzionale, come tale, dunque, particolarmente garantito, non trasforma «magicamente» lo Stato unitario in Stato federale. Tutt’al più favorisce l’incremento, anche significativo, dei margini di autonomia degli enti locali. Questo processo, interamente governato dallo Stato centrale e non co-deciso con gli enti autonomi, viene, con un elevato livello di approssimazione, assimilato al federalismo. È, in fondo, una questione nominale, poiché, a voler guardare attentamente alla sostanza del federalismo (storico, cioè quello vero), si parla d’altro.
In Italia, al massimo, si assistebbe al tentativo di far pesare un po’ di più le autonomie territoriali nelle decisioni che riguardano le comunità, residenti nei rispettivi ambiti territoriali. Detto in altri termini, è il tentativo di costruire uno Stato (unitario) un po’ più autonomistico. O almeno più di quanto non sia ora, sebbene ciò che è ora non sia poco, per lo meno secondo la Costituzione. Ed è questa una questione su cui le discussioni sul ruolo delle autonomie nel nostro ordinamento si soffermano poco e malvolentieri. Riprendendo la passione costituente di Calamandrei, a proposito dell’attuazione della Costituzione, ci si dovrebbe chiedere se il legislatore sia mai riuscito a dare pieno compimento ed effettiva attuazione al principio autonomistico inscritto nella Costituzione del 1948, dotato di potenzialità davvero dirompenti. Non essendo questa la sede per rammentare quanto ci sia stato di incompiuto nella realizzazione del disegno autonomistico prefigurato dall’Assemblea costituente, ci si limita a riproporre il problema dell’attuazione costituzionale, come il vero problema di una seria politica delle istituzioni.
Anche perché, dinnanzi a un’eventuale crisi di governo (il pericolo non parrebbe del tutto tramontato), al possibile riemergere di maggioranze variabili, questo tentativo di federalismo «nostrano» rischia di estinguersi senza neanche essere venuto al mondo, se non in minima parte col provvedimento sul cosiddetto «federalismo demaniale», l’unico attualmente vigente.
Un federalismo ipotetico, virtuale, dunque. Anzi, un «non federalismo», appunto, perché altro non potrebbe essere… in ogni senso.