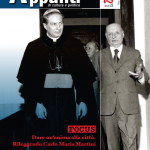Appunti 5_2009
Focus: Ricerca di consenso e risposta penale:
le contraddizioni dell'ideologia della sicurezza
È dunque ancora una volta confermato, dagli avvenimenti di questi mesi, che il nostro legislatore non è in grado di dire nessuna parola, sul tema immigrazione, che non sia di stampo lavoristico-utilitaristico (la sanatoria per le «utili» badanti) o di stampo securitario (con la legge 94, siamo già a due norme di modifica del TU immigrazione entrambe poste sotto il titolo e il segno della sicurezza).
Un diverso punto di vista dal quale leggere il fenomeno davvero pare non riuscire a fare ingresso nell’arena politica, salvo poi farlo invece nella realtà sociale dove fortunatamente le interazioni, le solidarietà, gli intrecci utilitaristici con gli «stranieri» sono molto più forti e numerosi di quanto il legislatore riesca a immaginare.
Ma questo non può bastare: il diabolico intreccio mediatico tra immigrazione e insicurezza si appresta a lasciare alle future generazioni un’eredità negativa che va ben al di là di qualche norma sballata: un diritto penale «pauroso» in senso letterale (ad un tempo produttore di paura e lui stesso privo di coraggio); una «legalità di immagine» che prescinde dall’efficienza della norma e pertanto produce essa stessa illegalità, un sistema giuridico incapace di essere luogo di riconoscimento e di premura verso il debole e di leggere l’«apertura» come fattore di sicurezza; una nozione esasperata e iper-identitaria di cittadinanza utilizzata per dividere (anche nell’accesso al Welfare) quanti vivono su un medesimo territorio, anziché per farne un gruppo di liberi e uguali.
Padroni di casa e ospiti nella corsa al Welfare
› Alberto Guariso
Atti amministrativi discriminatori e illegali
Se ne sono accorti probabilmente solo i cultori della stampa specializzata, ma gli ultimi dodici mesi hanno segnato anche il picco del contenzioso giudiziario sulla «ripartizione della torta»: su quali siano cioè i criteri che — in epoca di immigrazione a 6 zeri — possono essere utilizzati per ripartire l’accesso al Welfare tra padroni di casa e ospiti; o, prima ancora, se una ripartizione di questo genere debba davvero essere fatta.
Il via al contenzioso è giunto ovviamente da amministratori locali troppo zelanti nel tracciare solchi tra residenti «cittadini» e residenti stranieri. Ha cominciato il comune di Brescia con l’attribuzione di un «bonus bebè» di 1.000 euro per tutti i nati nel 2008, anche se in famiglie agiate (fino a 80.000 euro di reddito!) purchè figli di genitori italiani, sulla base della sconcertante motivazione che in un momento di calo della fertilità, solo i cittadini italiani «considerano l’agio economico quale elemento rilevante per l’accrescimento del nucleo familiare»1; mentre notoriamente svizzeri, americani o cingalesi partoriscono anche se poveri, sicchè è inutile dar loro una mano.
Il seguito l’hanno fatto grandi e piccoli comuni, con le iniziative più svariate (contributi contro la disoccupazione per soli italiani, contributi per gli affitti per soli italiani e così via) fino a stravaganti trovate di vera e propria crudeltà, come quella del comune di Brignano Gera d’Adda, provincia di Bergamo, che ha deliberato un sussidio per le cure dentistiche dei bimbi, purchè… cittadini italiani: e che i bimbi neri o gialli, magari nati a Brignano, si tengano il mal di denti!
Per parte sua il legislatore, pur muovendosi ovviamente con una dose di fanatismo di gran lunga minore, ci ha messo del suo introducendo la social card (la tessera alimentare per i super-poveri) per soli cittadini2, il bonus pannolini per soli cittadini3 e persino (la fantasia non manca neppure qui) il collegamento telematico per l’accesso ai certificati anagrafici, per soli cittadini italiani4.
Curiosamente, laddove un singolo o una associazione hanno reagito e hanno portato la situazione davanti a un giudice, l’esito è stato assolutamente univoco nel senso di ritenere la illegalità di tali decisioni, specie quando introdotte con un mero atto amministrativo, in violazione delle numerosissime previsioni di legge che stabiliscono invece un principio di parità di trattamento tra cittadini e stranieri: la stampa specializzata non riporta una sola pronuncia «assolutoria» dei vari comuni chiamati in giudizio, ma cionondimeno non sembra che i sostenitori della linea «prima gli italiani» (che, scherzi del destino, sono sempre anche i sostenitori della «legalità», salvo quando la legge viene affermata da un giudice sgradito) abbiano intenzione di demordere e mietono anzi sempre nuove adesioni tra gli amministratori locali, convinti, non a torto, di poter trarre da queste iniziative consistenti vantaggi elettorali: a Brescia per esempio, dopo che il giudice aveva ordinato di estendere il beneficio agli stranieri, il comune continua tuttora (a spese dei contribuenti) la sua battaglia giudiziaria, pur avendo già collezionato cinque pronunce negative nei vari gradi di giudizio.
Nel processo mediatico che ha condotto alla costruzione del binomio straniero/insicurezza (di cui parliamo negli altri articoli di questo focus) l’immagine dello straniero-competitore nella corsa al Welfare gioca dunque un ruolo fondamentale, anche perché è quella che più facilmente affonda le radici in un sentire diffuso: se per quanto riguarda la corsa al posto di lavoro il fattore competizione sembra ormai attenuato a causa della forte segmentazione del mercato del lavoro (ma è facile prevedere che non sarà sempre così, man mano che crescerà la qualificazione professionale degli stranieri o che la morsa della crisi occupazionale si farà più stringente) una analoga attenuazione non c’è nel campo dell’accesso al Welfare: dove invece l’idea che lo straniero, normalmente più povero e con più figli, faccia man bassa di prestazioni sociali senza meritarle, resta ben radicata in larga parte dell’opinione pubblica.
Ovviamente la cultura e la politica marchiate dal fanatismo del tipo «il dentista agli italiani!» radicalizzano il tema e rendono impossibile la discussione. Ma è un vero peccato perché, come ben si comprende, il tema è decisivo e meriterebbe davvero una pacata riflessione.
Uso ambivalente della nozione di cittadinanza
Il tema coinvolge innanzitutto la nozione di cittadinanza e il futuro di questa antica idea segnata da un percorso tortuoso e contraddittorio: nata come fattore di uguaglianza, per transitare gli individui dalla condizione di sudditi a quella di liberi e uguali, era tuttavia già claudicante alla nascita, perché strettamente ancorata al presupposto che libertà e uguaglianza si acquisiscono solo all’interno dei confini dello Stato nazionale; al di fuori, nell’incerto mondo del diritto internazionale, l’individuo è completamente nudo, anzi inesistente e i diritti si acquisiscono solo per gentile concessione derivante dagli accordi tra Stati, unici attori della scena internazionale.
Quando si apre la stagione dei diritti umani universali, che stanno nel bagaglio di ogni individuo a prescindere dalla sua appartenenza a uno Stato e che lo seguono ovunque egli si sposti attraverso i confini, si apre subito, per la nozione di cittadinanza, il rischio di smarrire la funzione egualitaria e divenire piuttosto il nuovo piccolo muro di Berlino che divide appunto, su ogni territorio, padroni di casa e ospiti, titolari pieni dei diritti civili, politici e sociali e titolari di un bagaglio più ridotto, anzi via via più ridotto man mano che aumenta il timore di ondate migratorie, fino a ridursi a un nonnulla per coloro che hanno osato entrare senza chiedere permesso.
Ovviamente, come ogni muro serve anche a creare una casa accogliente, così anche la cittadinanza non serve solo a dividere, ma anche a creare identità, a riconoscersi in una storia e in una collettività: un ragionevole e condiviso equilibrio tra queste due funzioni è ciò che ancora totalmente manca nel dibattito attuale.
Tralasciando qui le due questioni più spinose in questo ambito (sulle quali la rivista è altre volte intervenuta5) ritorniamo appunto al Welfare, rispetto al quale la situazione appare particolarmente confusa.
Un groviglio di norme
Il TU immigrazione del 1998 (ancora vigente per queste parti) aveva immaginato uno schema tutto sommato razionale e apprezzabile: aveva garantito a tutti — anche ai non regolarmente soggiornanti — l’accesso alla scuola dell’obbligo e alle cure urgenti per la salute (art.2. comma 1, art.35, art.38); aveva vietato qualsiasi discriminazione dello straniero regolarmente soggiornante nell’accesso ai servizi sociali, ai servizi pubblici, alla casa e all’istruzione (art. 43); e aveva richiesto come requisito di accesso dello straniero alle prestazioni economiche di assistenza un permesso di soggiorno di durata di almeno un anno (art.41).
Nel 2000 il legislatore aveva poi operato una prima stretta prevedendo che le prestazioni economiche fossero riservate ai soli stranieri titolari della cosiddetta «carta di soggiorno», cioè il permesso di soggiorno a tempo indeterminato che si acquisisce (o meglio si dovrebbe acquisire, burocrazia permettendo) dopo 5 anni di ininterrotto soggiorno.
Ma nel 2008 la Corte Costituzionale6 interviene su tale disposizione facendo un ragionamento di estrema semplicità: poiché per acquisire la carta di soggiorno occorre un reddito minimo e una casa in regola con le norme, è del tutto irrazionale (e dunque incostituzionale) che il legislatore riservi gli aiuti a chi ha già qualcosa e li neghi al povero assoluto. Dunque, via quella norma e largo all’idea che lo straniero deve essere aiutato sempre, anche quando non ha proprio nulla.
Si torna così all’ipotesi di fare riferimento a un permesso di soggiorno che abbia una certa «stabilità», ma interviene il Tar Lombardia a sollevare una nuova questione di costituzionalità: anche chiedere un permesso di soggiorno di una certa durata ha una sua irrazionalità, perché può accadere che il soggetto sia magari presente sul territorio nazionale da 10 anni ma, nel momento in cui richiede la prestazione, abbia un permesso «corto» per ragioni contingenti (ad es. se è disoccupato, avrà un permesso di soli 6 mesi): ed è assurdo che perda la prestazione per tale casuale coincidenza.
Ad aumentare la confusione ci si è messo poi anche il diritto comunitario che da un lato sancisce solennemente il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità tra i cittadini europei (art. 12 trattato); dall’altro consente l’allontanamento del cittadino comunitario qualora sia divenuto un «onere eccessivo» per lo stato ospitante7: dal che taluni amministratori locali hanno tratto spunto per instaurare un corto circuito diabolico, secondo il quale qualunque straniero per il solo fatto di rivolgersi ai servizi sociali, diventerebbe un «onere eccessivo» e dovrebbe pertanto essere allontanato8.
Trattasi ovviamente di forzature «alla bergamasca». Ma i vari passaggi qui sommariamente descritti dimostrano certamente che l’individuazione di un criterio selettivo che, in un modo o nell’altro, si basi sull’essere il destinatario italiano o straniero è impresa praticamente impossibile e rischia a ogni passo di sfociare in esiti irrazionali.
Al momento l’escamotage che gode di maggiore successo è dunque quello di fare riferimento a una certa durata della residenza9: criterio che, ove applicato dagli enti locali, gode sicuramente di una forte ragionevolezza, ma si presta a contraccolpi illogici sui cittadini italiani (si pensi all’anziano che finisce in fondo alla graduatoria per l’accesso alla casa di riposo solo perché residente in un comune vicino); ove applicato dallo Stato, rischia di risultare indirettamente discriminatorio perché colpisce comunque e prevalentemente ancora gli stranieri, se pure senza dichiararlo apertamente, tanto è vero che proprio per questo è già stato censurato almeno una volta dalla Corte di giustizia europea10.
Insomma il rompicapo c’è e le soluzioni vengono solo abbozzate in ordine sparso, gravate dal peso dell’ideologia dominante.
Resta sullo sfondo il grande tema dell’uguaglianza, che — così come declinato dall’ordinamento comunitario e nazionale — è, in prima battuta, soprattutto il divieto di utilizzare alcuni criteri (genere, razza, etnia, età, orientamento sessuale, opinioni personali e entro certi limiti anche cittadinanza) per instaurare trattamenti differenziati tra le persone. L’elenco dei criteri vietati è totalmente rimesso nelle mani della politica ed è dunque mutevole11 ma si basa sul presupposto che quei criteri, ove utilizzati, aprono la strada a discriminazioni intollerabili e dunque a conflitti sociali inaccettabili.
Al di fuori di quei criteri certamente molto può e deve essere fatto, in materia di Welfare, per individuare quel criterio minimo di radicamento sul territorio che giustifica l’intervento sociale e per modulare la distribuzione delle risorse e la selezione dei bisogni tenendo conto delle diverse caratteristiche (talvolta confliggenti) dei vari gruppi sociali (famiglie numerose e anziani soli; giovani mai occupati e dipendenti espulsi dal lavoro e così via).
Arrivare senza traumi a questa individuazione, specie in epoca di Welfare ridotto all’osso, non è certo agevole, ma è almeno una direzione di lavoro per ridurre al minimo gli inevitabili conflitti nella corsa al Welfare. L’altra ipotesi è quella perseguita da questo anomalo «partito dei sindaci»: giocare con spregiudicatezza la funzione identitaria della cittadinanza, magari chiudendo in faccia persino la porta del dentista. Ma chissà se qualcuno di loro si chiede seriamente quale potrà essere il punto di arrivo di questa strada.
1 Così la delibera di giunta n.1062 del 21.11.08 che ha istituito il bonus.
2 Vedi l’art. 81, comma 32, L. 133/08.
3 Vedi l’art.19, comma 18, L. 2/09.
4 Vedi l’art.16 bis, L. 2/09 e decreto del Ministero della Funzione pubblica del 9 maggio 2009.
5 Ci riferiamo innanzitutto al voto agli immigrati nelle elezioni amministrative, che già sembrava a portata di mano nel 1998, in occasione del varo del TU immigrazione, ma che poi si è arenato nelle secche della nuova stagione politica; e alla nuova legge sulla cittadinanza, anch’essa impantanata da anni in parlamento, con il risultato di lasciare in vita l’attuale normativa basata sullo ius sanguinis che impedisce ai figli di immigrati nati in Italia di acquisire la cittadinanza per nascita.
6 Sentenze 306/08 e 11/09.
7 Cfr. l’art. 14 direttiva 2004/38 e art. 7 D.lgs. 30/07.
8 La diabolica invenzione non tiene conto che il diritto comunitario, per cercare di far quadrare il cerchio, prevede che «il ricorso da parte di un cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non da luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento» (art.14, comma 3, direttiva 2004/38): il che significa, in parole povere, che non basta richiedere un aiuto per essere qualificati come «onere eccessivo».
9 Così le nuove norme in materia di assegno sociale lo limitano a coloro che abbiano almeno 10 anni di residenza sul territorio nazionale (art. 20, comma 10, L. 133/08); o ancora la L 6.8.08 n.133 in materia di piano casa e fondo di sostegno per l’abitazione riserva i benefici a coloro che abbiano almeno dieci anni di residenza in Italia o cinque nella regione.
10 La sentenza era stata emessa proprio nei confronti dell’Italia e censurava il fatto che gli sconti nei musei venissero concessi solo ai residenti con ciò indirettamente discriminando gli altri cittadini europei che ovviamente, nella loro grande maggioranza, non risiedono in Italia e che invece, in forza del Trattato, godono della parità di trattamento.
11 Tanto mutevole che l’art. 21 della Carta dei diritti dell’Unione europea elenca anche tra i criteri vietati, con un po’ di ottimismo, «le opinioni di qualsiasi natura» e «il patrimonio».
Il diritto che protegge e il diritto che controlla…
› Claudia Mazzucato
C’è qualcosa che non torna nell’immaginare la sicurezza come un sigillarsi all’interno di uno spazio invalicabile. Quand’anche funzionino, ed è raro, le chiusure ermetiche innescano spirali di indebolimento per superare il quale sono in genere necessarie le maniere forti. È esperienza comune, in ogni ambito: l’igienismo indebolisce proprio le difese immunitarie; le culture e le società che si chiudono, di solito, non sopravvivono.
La vita ha singolarmente bisogno della diversità e dello scambio, resi possibili da tessuti, membrane e organi penetrabili e porosi.
È poi sorprendente osservare come non di rado la sicurezza e il sentirsi «al sicuro» dipendano, più che da scudi protettivi, da apprendimenti e competenze acquisiti grazie all’«esposizione» all’ignoto, al rischio, all’errore, al pericolo, i quali stimolano nell’essere umano la sapiente ricerca di risorse che lo rendano poi più capace di padroneggiare le situazioni, dunque più forte e sicuro.
Il lettore potrà proseguire da sé la riflessione, guardandosi attorno e interrogandosi se una società «sigillata», refrattaria all’esposizione culturale ed esistenziale derivante dall’incontro con gli altri, possa davvero dirsi una società sicura e attrezzata a fronteggiare il futuro.
Qui interessa, con un «salto», indagare un altro profilo, forse meno dibattuto.
Trasferendo queste generiche riflessioni nell’ambito della politica del diritto, si può decifrare un lungo e articolato macro-cammino di apertura dei sistemi giuridici degli Stati democratici e della comunità internazionale, frutto per l’appunto della permeabilità degli ordinamenti agli errori e alle tristi e drammatiche vicende di ingiustizia che costellano la storia dell’umanità.
Tagliando corto rispetto alle sterminate teorie sulla loro origine, vi è chi intuisce quanto i diritti vengan fuori dalla tragica (e mai benefica in sé) esperienza dei torti1; altre intriganti riflessioni mostrano poi il ruolo decisivo delle ingiustizie — da tutti fin troppo conosciute — per avvicinarsi a cogliere il misterioso (e mai pienamente attinto) concetto di giustizia2.
I sistemi giuridici più evoluti e recenti si caratterizzano per una serie di «aperture»: l’apertura all’apporto internazionale nell’elaborazione di principi fondamentali e nell’individuazione di nuove declinazioni dei diritti soggettivi, l’apertura a una regolazione sempre meno connessa alle dinamiche in crisi dell’idea di sovranità nazionale, l’apertura all’approccio interculturale ecc. Qui interessa notare, soprattutto, il dischiudersi del diritto all’esperienza del dolore che ha segnato il XX secolo, da cui sono scaturiti l’affinarsi dei diritti umani e la loro universalità, da un lato, e dall’altro, l’assegnazione agli ordinamenti giuridici di compiti «promozionali» di spinta al miglioramento della società (compiti a loro volta, per definizione, aperti).
Un diritto che fa cultura
I sistemi giuridici «ad elevata cultura civica», pur con tutti gli inciampi delle cose umane, ambiscono idealmente a regolare la vita dei consociati non tanto (o non solo) per mezzo di modalità deontiche arcaiche — divieto, obbligo, sanzione — bensì disegnando, propiziando e, ove possibile, costruendo orizzonti culturali significativi e vasti, strutture sociali, mondi e contesti aperti nei quali ogni persona (cittadino o no) possa rinvenire ciò che le è necessario per vivere una vita buona e trovare il proprio posto nella società.
Le norme decisive per la cultura giuridica universale, che tanta sicurezza effettiva hanno contribuito a realizzare nel mondo — quelle, cioé, contenute nelle convenzioni internazionali, nelle costituzioni e nelle leggi più importanti degli Stati democratici — sono per lo più norme programmatiche e di principio, norme cioè dal contenuto «aperto» e per certi aspetti «mobile», norme che delineano un ethos nel quale tutti possiamo (dobbiamo potere) riconoscerci e rispetto al cui orizzonte tutti siamo chiamati in causa. Norme che fanno cultura e riescono, se non sono lasciate alla retorica dei discorsi ufficiali ma permeano l’agire delle istituzioni, ad arginare in modo mite e propositivo le derive che producono insicurezza e paura.
La postazione più avanzata e positiva del «giuridico» conduce al cospetto di leggi niente affatto aride e anzi aperte a una sensibilità verso i bisogni (non certo solo primari) dei destinatari delle norme, leggi capaci di ascoltare le necessità e raccogliere l’appello di un mondo complesso in continuo cambiamento, fornendo risposte — almeno programmatiche — che superano i particolarismi e gli egoismi per dischiudere scenari ampi e inclusivi.
Si pensi all’enunciazione — fra gli altri — del principio di uguaglianza sostanziale in una moltitudine di fonti giuridiche internazionali, oppure al nascere in tanti ordinamenti del diritto minorile, frutto maturo di ordinamenti «avanzati», strutturalmente votato a realizzare «il superiore interesse» del bambino beneficiario dell’intervento normativo.
Si pensi, per tutti, all’esempio straordinario di «apertura», nel nome della sicurezza e della tutela della vita concreta di migliaia di persone da una violenza altrimenti dilagante, rappresentato dalle scelte normative «costituenti» del Sud Africa post apartheid, nella cui Costituzione democratica compare l’idea di privilegiare l’unità del corpo politico (bianchi e neri «united in our diversity») lacerato dalla mostruosità delle divisioni (e delle leggi) razziali, anche mediante forme di giustizia di transizione votate all’incontro diretto con la sofferenza delle vittime, alla rinuncia alla retribuzione punitiva, in vista di una indispensabile riconciliazione nazionale3.
Il diritto come premura e «luogo del riconoscimento»
Il vettore lungo cui si muove la civiltà giuridica è quello di un sistema dedicato idealmente a costruire forme di «premura», attraverso i diritti inviolabili e la predisposizione di un sistema solidaristico di protezione rafforzata degli individui (a vario titolo) deboli. Un sistema normativo che si prende cura della sussistenza stessa del «vivere civico» proponendosi come forma tangibile di un vero e proprio legame o «patto» di fiducia inter-soggettiva, nel quale riconoscersi in una comunanza basilare e irrinunciabile, al di là della ricchezza, in un mondo plurale, di differenti idee, convinzioni, appartenenze ecc. Il diritto che scaturisce dalla consapevolezza delle offese e dei torti, affinché non abbiano a ripetersi, è uno dei «luoghi del riconoscimento» in cui si svela «la parentela ontologica tra persone e culture», luogo indispensabile «per ogni democrazia che voglia far fronte al duplice compito cui oggi è chiamata: accogliere i “diversi” e stabilire le regole della convivenza»4.
Lungi dall’essere un insieme di imperativi a cui ubbidire, muniti di sanzioni negative per i casi di inosservanza, il diritto di una «elevata cultura civica» è dunque aperto a doveri di cura, giocati in forma propositivo-promozionale. Laddove ciò non avviene c’è da dubitare del carattere realmente democratico delle istituzioni e c’è da sospettare di trovarsi in una società ben poco «decente», per usare un’efficace espressione di Avishai Margalit5. La capacità di «prendersi cura»finisce per essere il biglietto da visita di un ordinamento democratico-costituzionale.
L’umiliazione è l’opposto del prendersi cura: una indecent society è il contrario di una caring society, di una società «giuridicamente premurosa».
Si noti che le società indisponibili alla solidarietà e a interventi istituzionali di «premura» sono inclini a domandare risposte emarginanti e aggressive nei confronti dei loro membri problematici. Le dinamiche di esclusione sociale, di cui sono in parte responsabili anche le stesse istituzioni si saldano alle istanze di controllo, allontanando in modo sinistro da una società (almeno) «decente».
La giustizia penale e la disciplina migratoria, ormai tristemente divenute un’unica materia, sono ambiti politicamente sensibili e obiettivamente difficili che ben si prestano a rappresentare la cartina di tornasole del grado di apertura e premura di una certa società.
Con due rilevanti interventi legislativi in materia di «sicurezza», approvati a circa un anno di distanza l’uno dall’altro6, si assiste in Italia a una bruciante smentita delle linee programmatiche sopra accennate. Non è certo la prima volta, ma qui si rinvengono spinosità del tutto particolari e inediti tradimenti dei cardini della civiltà giuridica.
Un drammatico presente: esclusione per legge dal diritto che protegge, inclusione per legge nel diritto che controlla
Un dato emerge in modo netto: per la prima volta il destinatario di un precetto normativo è additato come indesiderato e «nemico», non per quel che fa ma per quel che «è» e «rappresenta» nell’immaginario collettivo. Non mi riferisco solo alle norme penali che introducono il reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato7» o l’aggravante della clandestinità8 (per le quali si è parlato giustamente dell’abbandono del diritto penale «del fatto» per un infelice ritorno al diritto penale «d’autore»9), bensì alla moltitudine di previsioni — la cui gravità è meno afferrabile — che riguardano l’esclusione delle persone cosiddette irregolari da forme basilari di vita legale, mediante l’apposizione di continui ostacoli al loro ingresso nei circuiti della normalità e, dunque, della legalità10. Si tratta di una perniciosa «chiusura» dell’ordinamento che provoca, giocoforza, l’erosione dei diritti soggettivi fondamentali i quali restano enunciati sulla carta, senza trovare però alcun collante operativo nelle disposizioni di dettaglio.
Si osservi che in tal modo si viene a generare una situazione, questa sì, alquanto pericolosa: per un verso, infatti, ogni disposizione che ponga eccezioni (esplicite o implicite) alla vigenza delle norme «aperte» di principio ne riduce la portata e ne affievolisce il messaggio, con conseguente indebolimento in generale di quei beni e valori tutelati da parte e nei confronti di tutti. Il degrado complessivo dell’autorevolezza dei precetti e l’inospitalità del contesto sociale così prodotti giocano a sfavore della sicurezza. E dire, infatti, che più l’ordinamento si «apre» per accogliere «nei diritti», più — se vogliamo — propizia legalità e riesce quindi a controllare (senza forza) le eventuali fonti di pericolo.
Per altro verso, la normativa in questione realizza una situazione inconsueta e grave per uno Stato democratico-costituzionale: le persone migranti prive di titolo di soggiorno vengono quasi del tutto escluse dal diritto che protegge per incontrare di fatto solo il diritto che controlla e punisce. I precetti rivolti ai migranti (specialmente «irregolari») sono comandi, divieti, obblighi e punizioni i quali assomigliano, nel metodo e nel merito, più a un diritto arcaico che al prodotto di una civiltà giuridica raffinata e premurosa che si gioca su tutt’altri fronti.
Ma vi è di più: queste norme che parlano i linguaggi hard del controllo e della forza, non trovano alcuna mitigazione in quelle che — di contro — assicurano riconoscimento e protezione effettivi dei diritti fondamentali, giacché i migranti senza permesso di soggiorno finiscono per «non» essere destinatari di queste ultime, riservate ai cittadini e, al massimo, agli stranieri «regolari». Si viene a creare un sistema separato con tre distinti livelli di accesso e/o godimento dei diritti a seconda della cittadinanza, del titolo di soggiorno, della clandestinità. La separazione formale e normativamente esplicita, in molti casi, si va ad aggiungere al sistema separato che scaturisce dalla prassi e vede gli stranieri oggetto di una serie di controlli selettivi (di polizia, dattiloscopici, amministrativi ecc.) che li espongono di fatto a fenomeni di iper-criminalizzazione e a una sostanziale intermittenza del godimento dei diritti.
Se l’«essere irregolari», se il trattenersi sul territorio senza permesso sono di per sé condizioni illecite, sfuma in un sol colpo l’intero ordinamento giuridico che dialoga con il consociato, lo promuove e protegge; se si cessa di essere soggetti di diritto, residua solo lo spicchio di ordinamento che interviene per sanzionare quella condizione, in una spirale di invivibilità formale e sostanziale foriera solo di scorciatoie di cui profitta la criminalità vera. Né pare sussistere una preoccupazione di tutela dello straniero da comportamenti illeciti di terzi, posto che la quasi totalità dei divieti che, per legge, gravano su soggetti diversi, denotano istanze di controllo incrociato per snidare la clandestinità, non finalità di protezione, il che produce un’ ulteriore forma di isolamento sociale.
La situazione di giuridica inimicizia che si viene a creare è, di fatto, senza rimedio: non trattandosi di «comportamenti» illegali, ma di uno status illegale, non vi sono rieducazione, riparazione o ravvedimento possibili. La Corte costituzionale non ha mancato in diverse occasioni di rammentare l’orientamento prioritario alla rieducazione, ex art. 27 comma 3 Cost., orientamento che le nuove fattispecie penali migratorie non contemplano neppure in astratto tra i loro scopi di politica criminale.
Si obietterà che il migrante irregolare può sempre decidere di non emigrare o di rimpatriare.
Può anche darsi. Ma si svela qui un altro punto delicatissimo: la disciplina in materia di immigrazione, contenuta nel pacchetto sicurezza, tradisce una cattiva coscienza presto smascherata. Invito il lettore a prendere visione del sito «viaggiare sicuri» del ministero degli Affari esteri11: vi si passano in rassegna gli Stati del mondo, riportando per ciascuno i vari pericoli in cui ci si può imbattere (dalle calamità naturali alle guerre, dalle discriminazioni ai rischi per la salute). La gran parte dei paesi di provenienza dei migranti che giungono in Italia (persone che oggi sono pure, per definizione, dei criminali) presentano precisamente gravi problemi e rischi riguardo alla sicurezza che inducono il ministero a consigliare di «non» andare e non permanere in quei luoghi.
Senza sminuire la complessità del problema e il suo carattere internazionale, viene da chiedersi che fine ha fatto la regola aurea da cui, insieme alle ingiustizie, prende origine la legge che vuole essere «luogo di riconoscimento» imprescindibile per una democrazia capace di accogliere i diversi e regolare la convivenza: «non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te».
L’auspicio è che presto vi siano le condizioni per una rimeditazione complessiva e serena delle scelte normative di questi mesi, la quale conduca a un cambiamento di rotta verso nuove aperture grazie alle quali individuare soluzioni intelligenti che non sostituiscano alla premura la forza e non violino la regola aurea della comunanza.
1 Di A. Dershowitz, Rights from wrongs. Una teoria laica dell’origine dei diritti, trad. it., Codice, Torino 2005, raccolgo qui la suggestiva idea di fondo della «costruzione di una teoria del diritto sulla storia delle ingiustizie», più che gli argomenti, non sempre a mio avviso condivisibili, con cui tale idea viene sostenuta dall’A.
2 C.M. Martini-G.Zagrebelsky, La domanda di giustizia, Einaudi, Torino 2003; F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, Il Mulino, Bologna 2006.
3 A. Lollini, Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione, Il Mulino, Bologna 2005.
4 P. Gomarasca, Meticciato: convivenza o confusione?, Marcianum Press, Venezia 2009, p. 193.
5 A. Margalit, trad. it. La società decente, a cura di A. Villani, Guerini, Milano 1998 (su cui cfr. i commenti in tema di mediazione dei conflitti di A. Ceretti, Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione, in F. Scaparro (a cura di), Il coraggio di mediare, Guerini, Milano 2001, p. 65 ss.).
6 Legge 24 luglio 2008, n. 125 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92), recante «misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»; Legge 15 luglio 2009, n. 94, «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».
7 Fattispecie introdotta dalla L. 94/2009 che ha aggiunto l’art. 10 bis al Testo Unico in materia di immigrazione (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif.).
8 Art. 61 comma 11bis c.p., introdotto dalla L. 125/2008.
9 Si veda sul punto G. Forti, in questo numero.
10 Ostacoli al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, all’accesso ai pubblici servizi, ecc. Senza contare le preclusioni imposte da disposizioni locali di carattere amministrativo, su cui cfr. A. Guariso, in questo numero.
11 Cfr. www.viaggiaresicuri.it .
Le facili prede di un diritto penale «pauroso»
› Gabrio Forti (*)
L’8 agosto scorso è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94, «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» (Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009). Si tratta del secondo intervento di ampia portata in materia di «sicurezza» approvato in questa legislatura, quasi esattamente a un anno di distanza dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92), recante «misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».
La relazione illustrativa che aveva corredato quel primo provvedimento identificava come suo «fine specifico» «affrontare in via di urgenza taluni problemi di ordine e sicurezza pubblica»: «beni primari», ritenuti «purtroppo [sic] pregiudicati da taluni gravissimi fenomeni in continua espansione». Tra tali fenomeni era collocata in prima fila «la spinta criminogena di una immigrazione irregolare senza controlli adeguati in ordine alla sussistenza dei requisiti per ottenere un soggiorno legale nel territorio dello Stato». La relazione, pur rilevando l’insufficienza dello «strumento del decreto-legge» a «risolvere» tutti i problemi di sicurezza presi in esame, segnalava come il ricorso a tale provvedimento fosse dettato dalla «straordinaria necessità e urgenza di arginare le difficoltà più significative», in attesa di una «più compiuta rivisitazione della normativa» regolante «i fenomeni» in questione.
La cosiddetta «rivisitazione», ora realizzata con la legge n. 94/2009, prosegue nella traiettoria legislativa, avviata con il provvedimento dell’anno scorso, costellata da misure che hanno inciso su norme fondamentali del diritto penale (ad es. l’aggravante della clandestinità di cui all’articolo 61 co. XI-bis c.p.) e sulla natura stessa del rapporto tra questo ramo dell’ordinamento e il diritto amministrativo: misure prevalentemente caratterizzate da un intento di esclusione e allontanamento di specifiche categorie di stranieri migranti.
La dimenticata lezione beccariana
Pur non costituendo conversione di una decretazione d’urgenza, anche quest’ultima legge dell’urgenza porta tutte le stigmate. Basti pensare che, dopo la sua approvazione parlamentare e prima della promulgazione, come ampiamente riferito dai mezzi di comunicazione, il Presidente della Repubblica aveva manifestato serie perplessità sul provvedimento. Tra le norme di «rilevante criticità», meritevoli di «rinnovata riflessione», il Capo dello Stato identificava le «disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione clandestina [art.1 commi 16 e 17]», con la previsione di una sanzione punitiva non solo per l’ingresso, ma anche per «il trattenimento nel territorio dello Stato», come tale «perciò applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge», con «effetti difficilmente prevedibili»1.
Ancor prima del presidente della Repubblica, era stato un gruppo di giuristi (tra i quali ex-giudici costituzionali quali Gustavo Zagrebelsky e Valerio Onida), in un appello pubblico, a esprimere vari motivi di preoccupazione sulla norma destinata a punire a titolo di reato l’ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato: norma che, «oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all’uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale».
Lo «stile» legislativo dispiegato in questa come in varie altre recenti occasioni appariva subito diametralmentre opposto rispetto a quello auspicato già per i diritti penali della sua epoca dal grande illuminista lombardo Cesare Beccaria2, quando osservava che per prevenire i delitti occorre che i lumi, le cognizioni, accompagnino la libertà. Ciò che serve alle istituzioni pubbliche è la capacità di un pensiero e di un linguaggio sensibili e articolati. Prevenire e contrastare la criminalità significa innanzi tutto saperla conoscere e, quindi «dire», in ogni testo normativo, con parole appropriate, ossia in grado di distinguere ciò che in essa va separato (ad esempio la criminalità predatoria dettata dal bisogno e dalla disperazione e quella che mira alla sopraffazione dei più deboli) e di unire ciò che, al di là delle apparenze, ne tiene strettamente i fili (ad esempio la criminalità organizzata di tipo mafioso e certa criminalità politico-economico-finanziaria nazionale e internazionale). Una tale articolazione espressiva implica per il legislatore la capacità di non sottostare al sentimento che, come osservava il filosofo Bacone, «considera soltanto il presente», ma di farsi guidare dalla ragione, che «invece considera il futuro e il tempo nella sua totalità»3.
Sia l’invito a una maggiore ponderazione mosso dal Capo dello Stato, sia l’appello dei giuristi sono però rimasti inascoltati dal legislatore. Si è persa così un’altra opportunità di intervenire in modo sistematico e meditato su una materia nella quale la stessa la Corte Costituzionale, con la sentenza numero n.22/2007, non aveva esitato a rinvenire «squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa della stessa».
Verso un diritto penale dell’autore?
Un primo effetto, tra i tanti, di questa frettolosa corsa alla criminalizzazione dell’immigrato irregolare è che (in base al nuovo articolo 10-bis aggiunto al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) l’ingresso e la permanenza clandestini nel territorio nazionale costituiscono ora reato punibile con un’ammenda compresa tra i 5.000 ed i 10.000 euro, non oblazionabile, cui segue immediatamente l’espulsione. La sanzione viene applicata al termine di un nuovo rapido rito, appositamente congegnato, che si svolge dinnanzi al giudice di pace. Laddove infine l’espulsione non sia immediatamente possibile, lo straniero potrà essere trattenuto nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie) per un periodo massimo di sei mesi.
Tra i molti i rilievi tecnici e generali che potrebbero essere avanzati con riguardo a questa misura, c’è innanzi tutto la criminalizzazione che essa introduce non tanto di condotte pericolose o dannose in sé, quanto della condizione stessa di chi si trovi (anche suo malgrado) privo di un permesso di soggiorno: la previsione sembra così urtare contro il fondamentale principio secondo il quale la pena deve essere imposta al condannato per un suo fatto, e non in conseguenza del suo modo di essere, o del suo stile di vita.
Un tale scivolamento verso il cosiddetto diritto penale dell’autore — tipico di sistemi giuridici autoritari e totalitari — rappresenta un indubbio arretramento rispetto ai grandi princìpi di matrice illuministico-liberale, alla base dei quali si pone l’idea secondo cui i diritti dell’uomo costituiscono la fonte di legittimazione dello Stato come Stato, appunto, di diritto4. Nei confronti degli stranieri il diritto penale sembra infatti dismettere le tutele che per ormai lunga tradizione di civiltà lo avevano configurato soprattutto come magna charta del reo, per assumere le più cupe sembianze di un diritto di polizia. Questo è caratterizzato dallo sfumare della linea di demarcazione tra la sfera propriamente penale e quella amministrativa, come è dato per l’appunto riscontrare nella nuova disciplina e soprattutto nella misura in cui si esprime emblematicamente l’attuale sistema di controllo del fenomeno migratorio: il trattenimento presso i Cie. Si tratta di una misura ibrida, di una limitazione della libertà personale5 attuata in strutture parallele a quelle carcerarie e configurabile, soprattutto dopo la sua estensione fino a sei mesi, come una sorta di pena «aggiuntiva», che il migrante sconta a seguito della commissione del reato contravvenzionale di ingresso o di trattenimento clandestino. Il meccanismo delineato dall’attuale testo di legge, infatti, non lascia adito a dubbi: a seguito del reato e del procedimento disposto per il suo accertamento, lo straniero deve essere espulso; se, tuttavia, tale espulsione non è immediatamente possibile, occorre che egli venga trattenuto, appunto nei Cie, per il tempo necessario. È noto tuttavia come tale misura non sia quasi mai realizzabile nell’immediato, per le difficoltà anche pratiche che l’accompagnamento coattivo alla frontiera generalmente comporta: la limitazione della libertà personale, connettendosi indirettamente al «peccato originale» dell’ingresso o trattenimento illegittimo e sopravanzando in afflittività la sanzione pecuniaria astrattamente prevista dalle nuove disposizioni, diventa in questo modo più che una semplice eventualità per lo straniero e sembra appunto configurarsi come una «pena atipica».
I problemi di effettività politico-criminale
C’è da interrogarsi seriamente su quanto questi strappi profondi arrecati al tessuto della civiltà penale (dai quali non solo lo straniero, ma anche il cittadino italiano farebbe bene a temere potenziali ricadute sulle proprie libertà fondamentali) siano realmente in grado di rendere più effettivo il contrasto realizzato nei confronti di quello che è il fenomeno più temibile e minaccioso per la collettività: la gestione clandestina dei flussi migratori e la tratta di esseri umani da parte della criminalità organizzata.
L’interrogativo circa la efficacia di queste misure non pare peraltro riguardare solo la macrocriminalità che lucrosamente alimenta la (e si alimenta della) immigrazione clandestina. Perfino nei confronti degli ultimi e più deboli anelli della «catena» migratoria l’impatto che esse sembrano poter aver è più simbolico che reale e comunque necessariamente molto concentrato nei confronti dei pochi che avranno (a quel punto tanto più ingiustamente e arbitrariamente) la ventura di finire nelle maglie di controlli e procedure così draconiani. Come messo in evidenza nello stesso appello dei giuristi sopra richiamato, sussistono infatti seri dubbi sulle chances di concreta applicabilità dei nuovi provvedimenti. Particolarmente difficoltosa sembra in particolare la gestione della seconda fattispecie introdotta dalla legge n. 94, ovvero quella che punisce il «trattenimento» all’interno dei confini nazionali. A seconda delle stime di volta in volta considerate, il numero di stranieri irregolarmente presenti all’interno del territorio italiano oscilla tra i 500.000 ed il milione6. Non si vede, realisticamente, come la giustizia italiana in generale potrà fare fronte ad una tale, improvvisa ed impegnativa mole di lavoro. Il nuovo sbrigativo rito disposto per l’accertamento dei reati in esame è stato infatti interamente affidato al giudice di pace, dinanzi al quale la forza pubblica ha la facoltà di condurre l’imputato colto in flagranza di reato (ovvero, senza documenti). Il magistrato, a seguito di un accertamento sommario, può pronunciare una sentenza di condanna che deve essere immediatamente eseguita (art. 20-bis e -ter, nonché 32-bis del decreto legislativo n. 274/00, come modificato dalla legge 94/09).
I giudici di pace avevano già visto dilatarsi notevolmente le loro competenze in materia di immigrazione quando, nel 2004, la legge 271 aveva trasferito loro il compito di giudicare della validità dei trattenimenti presso i centri di permanenza temporanea. La scelta, ai tempi, provocò moltissime perplessità, non solo per il notevole incremento del carico di lavoro imposto a ciascun giudice di pace, ma anche per i dubbi circa la capacità, da parte di tali mgistrati (le cui risorse operative non possono certo equipararsi a quelle di altri organi giudiziari), di gestire il notevole livello di tensione e di conflittualità che caratterizza le udienze di convalida dei trattenimenti. Le ulteriori nuove incombenze che d’ora in poi saranno fatte gravare su questi giudici (di cui già in fase di approvazione della legge la stampa ha riferito le corali proteste per la temuta ingestibilità del carico di lavoro che la nuova disciplina avrebbe abbattuto sui loro uffici) potrebbero ora determinarne la completa paralisi funzionale. E se anche così non fosse, comunque, il rischio è che la congestione si ripercuota sulle fasi di appello, che dovrebbero, secondo le norme ordinarie (visto che nulla in contrario ha stabilito il legislatore), continuare a gravare sul tribunale di primo grado in composizione monocratica.
Il linguaggio della legalità
Spesso si dimentica, nel variegato frastuono dei richiami all’ordine e alla «legalità» che si sentono echeggiare nel nostro paese, quanto la fiducia nel rispetto delle regole (così essenziale per la «felicità» delle cittadinanze)7 debba essere innanzi tutto preparata e costruita dallo stesso legislatore con un’attenta ponderazione dei precetti da introdurre nell’ordinamento. Precetti che dovrebbero essere credibili ed effettivamente applicabili grazie alle risorse di concreto enforcement che il sistema istituzionale abbia preventivamente messo a disposizione della magistratura e della pubblica amministrazione. Ciò anche per evitare la corsa a sanatorie, condoni e controriforme di vario segno, assolutamente deleteri, secondo ogni studio delle dinamiche della psicologia collettiva, per la credibilità, la tenuta e, dunque, la vigenza fattuale, ossia per la reale osservanza da parte dei consociati delle regole giuridiche.
Una conferma di quanto poco questa preoccupazione di legalità «sostanziale» sia stata considerata dal legislatore — intento soprattutto a esibire platealmente alle cittadinanze la muscolatura dei suoi provvedimenti diretti ad «affrontare» i «problemi di ordine e sicurezza pubblica» — si è potuta cogliere nelle curiose vicende immediatamente successive all’approvazione della legge n. 94: tra proteste, smentite, rettifiche, dinieghi e proclami solenni, infatti, il governo ha introdotto in extremis una disposizione che consente, a particolari condizioni, la regolarizzazione di colf e badanti, sia italiane sia straniere8. Del resto anche la riforma precedente, introdotta con la legge n.189/2002, era stata accompagnata contestualmente da una sanatoria generalizzata.
Occorre prendere atto di quanto, oggi come trent’anni fa, il diritto dell’immigrazione si presti più di altri settori dell’ordinamento ad essere un laboratorio indisturbato per sperimentazioni ardite e nuove ibridazioni: non solo perché si colloca «in una di quelle “zone di confine” fra rami diversi dell’ordinamento che finiscono per essere le più trascurate», ma soprattutto perché, nella sua elaborazione, centrale resta «il segreto convincimento circa la politicità della materia, e circa il necessario affidamento di questi provvedimenti a quel potere (esecutivo) che più direttamente interpreta la volontà politica dello Stato»9.
Un diritto penale «pauroso»
La sensazione è che, ancora una volta, il legislatore abbia scelto di percorrere la strada più facile e vistosa, inscenando una sorta di experimentum legis in corpore vili e apponendo nuovi mattoni all’edificazione di un diritto penale «pauroso», in tutti e tre i sensi della definizione del termine che ci offre un dizionario della lingua italiana: come ciò «che abitualmente prova paura» e «che per carattere è incline a spaventarsi facilmente o manca di coraggio»; «che incute paura»; che è «enorme, esagerato». Nelle parole del legislatore (che dovrebbero essere le parole con cui si esprime l’intera comunità sociale) tende a infiltrarsi quello che, in una straordinaria intervista recente10, lo scrittore israeliano David Grossman identifica come il «potere di morte e distruzione» della guerra, che rende «anonima» e sequestra una gran parte della nostra realtà «attraverso un linguaggio vuoto e impietrito diretto a separarci gli uni dagli altri». Avendo come sottofondo un tale tremore «istituzionalizzato», anche le parole che usiamo nella vita di ogni giorno ci rendono infatti capaci ormai solo di trasmettere informazioni difensive e standardizzate e sempre meno di esprimere quella molteplicità, quell’atmosfera di significati in cui solo può svilupparsi la ricchezza delle nostre vite interiori. Tenderemo a non parlare più di persone vive, di relazioni umane, ma di automi meccanici, di rigide e cieche concatenazioni causali.
Eppure, da ciò che rileva un recente studio della Banca d’Italia contenuto nel rapporto sulle economie regionali11, non sembra proprio che il fenomeno migratorio necessiti di certe sonore e concitate «chiamate alle armi»: la crescita della presenza straniera in Italia negli ultimi anni «non si è riflessa in minori opportunità occupazionali per gli italiani», ma ha al contrario evidenziato una «complementarietà tra gli stranieri e gli italiani più istruiti e le donne», favorendo maggiori spazi di occupazione.
Questo dato sembra segnalare ancora una volta come la strada maestra per fronteggiare fenomeni complessi come quello migratorio non possa ridursi al tentativo più o meno goffo di tenere soprattutto sotto controllo con misure repressive quelle che Gregory Bateson chiamava le «variabili usurpatrici», ossia gli aspetti minacciosi e paurosi della alterità sociale e culturale. Si tratta piuttosto di «incoraggiare le persone ad avere conoscenza delle loro libertà e flessibilità e a usarle più spesso»12, il che può avere come possibile ricaduta il riconoscimento nell’altro non solo di una minaccia, ma soprattutto di un’ulteriore opportunità per l’esercizio a tutto campo della propria libertà sociale, culturale ed economica. Si tratta di sviluppare la capacità di contrapporre al potere distruttivo di un linguaggio «bellico», come osservava ancora David Grossman, «la creatività e la precisione delle parole che usiamo». E ciò sarebbe forse anche un primo balenare di quella «fioritura», di quell’ «operazione ardita», di quella «primavera dei cuori» di cui parlava Giovanni Colombo su queste stesse colonne13.
(*) Si ringrazia la dott. Lucia Della Torre per la documentazione e vari spunti offerti per la stesura del presente articolo.
1 A ulteriori effetti «incontrollabili» della legge, fa ad esempio riferimento un recente editoriale del settimanale «Famiglia Cristiana», dove si ricordano le devastanti conseguenze sulle «nozze miste» (ossia tra italiani e stranieri irregolari), delle modifiche («scritte da don Rodrigo») apportate all’art. 116 del codice civile. «Quand’anche il 50 per cento dei matrimoni misti siano combinati e “truffaldini”», si legge nell’editoriale, non si vede «per quale ragione dobbiamo proibire l’altro 50 per cento e gettare il bambino con l’acqua sporca». Cfr. «Famiglia cristiana», n. 34 del 23 agosto 2009: Se sono i politici a decidere le nozze che s’hanno da fare. L’articolo è stato ripreso anche da «La Repubblica», 18 agosto 2009, p. 9: Lega come don Rodrigo sui matrimoni.
2 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1763, Cap. XLII, “Delle scienze”: «Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta».
3 F. Bacon, Of the Advancement of Learning, libro II, p. 157: «dopo che la forza dell’eloquenza e della persuasione hanno fatto apparire presenti le cose future e remote, allora la ragione può prevalere sull’immaginazione ribelle». Il brano è ripreso, nello stesso contesto, da C. Perelman — L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, [1958], tr. it., Einaudi, Torino 1966, p. 124.
4 W. Rother, Cittadinanza e diritti dell’uomo, in Illuminismo. Un vademecum, a cura di G. Paganini ed E. Tortarolo, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 57.
5 Così definita espressamente dalla Corte Costituzionale con sentenza 105/2001. Riportiamo il passaggio più significativo: «Il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione… Si determina, nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere, e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della dignità personale» (corsivi nostri).
6 Sono più o meno concordi le stime dell’Ismu e della Caritas, secondo le quali gli stranieri irregolari presenti in Italia sarebbero circa 650.000 (Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes, 2008); il rapporto Ocse 2009 (International Migration Outlook 2009, Oecd) stimava il numero degli stranieri clandestini in Italia nel 2006 tra le 500.000 e le 750.000 presenze, comunque al di sotto della media europea.
7 Cfr. ad es. le conclusioni della ricerca condotta nel 2007 dalla University of Cambridge (http://www.admin.cam.ac.uk/news/dp/2007041701 ) sul livello di felicità nei paesi europei, da cui è emerso che «trust in society is very important. The countries that scored highest for happiness also reported the highest levels of trust in their governments, laws and each other». Cfr. Anche F.Bof, Italia, italiani e senso etico: perché gli scandinavi sono più felici di noi?, in «Ticonzero», 2007, 74.
8 La disposizione è contenuta nel c.d. «decreto anticrisi», legge numero 102/09, art. 1-ter
9 F. Bricola, Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione, in Politica criminale e scienza del diritto penale, Il Mulino, Bologna 1997, p. 99.
10 Cfr. l’intervista C. Emke, «Ich möchte nicht wütend sein», in «Die Zeit», 13 August 2009, p. 38.
11 V. «Corriere della sera», 18 agosto 2009.
12 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 2000, pp. 547-548.
13 G. Colombo, La «Signoria» e la primavera dei cuori, in «Appunti di cultura e politica», 2009, 3, pp. 1ss.