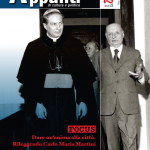Appunti 5_2009
Questo nostro «bel paese»
› Luciano Caimi
Un paese eternamente sospeso tra le staordinarie bellezze della natura, della storia e del savoir vivre nazionale e l’altrettanto straordinaria capacità di degrado, acquiescenza, corruzione, esagerazione, individualismo, trascuratezza. L’Italia, al di là di tutti i clichés più vieti della letteratura internazionale, non finisce di stupire. Ma questo clima perverso chiede di reagire con nettezza e senso di responsabilità.
È dell’abate Antonio Stoppani (Lecco, 1824 – Milano, 1891), scienziato e letterato, il celebre libro Il bel Paese (1875), capolavoro di divulgazione scientifica sulle bellezze naturali d’Italia. Il titolo della fortunata opera viene abitualmente assunto per indicare la nostra penisola. Certo, nonostante il pervicace tentativo da parte di molti d’infliggere, per interessi speculativi o addirittura criminali o, in qualche caso, per ignoranza crassa, ferite mortali al patrimonio naturalistico italiano, bisogna dire che tante e tali sono le meraviglie del nostro paese, da reggere anche agli sfregi più gravi. Incendi boschivi a parte (triste nota delinquenziale, purtroppo, di ogni estate), uno degli ultimi reati, grave anche per il valore simbolico, è stato l’inquinamento delle acque antistanti la Grotta Azzurra di Capri: per dire la straordinaria capacità autolesionistica che ci contraddistingue!
Ma non è dei beni naturali del «bel paese». e della necessità di tutelarli che intendo parlare. Vorrei piuttosto proporre qualche punteggiatura su alcune vicende degli ultimi mesi, che intorbidano il nostro paesaggio socio-culturale e politico-istituzionale.
Responsabilità ed equilibrio dei vertici istituzionali
La prima concerne le recenti disavventure «private» del presidente del Consiglio, con quello che ne è seguito. Il caso, a tutti noto, ha travalicato i nostri confini, occupando stabilmente la scena dei media internazionali. Mi preme riprendere un punto centrale della questione: il rapporto fra le dimensioni pubblica e privata dei rappresentanti delle istituzioni. Non si nega il sacrosanto diritto alla loro privacy, ma ciò non può costituire alibi per doppie «morali» o per calare spessi veli sul dovere della trasparenza del loro agire. Sarò all’antica, però credo legittimo pretendere da chi riveste ruoli istituzionali di così alta responsabilità stili di vita, in pubblico e in privato, consoni con il proprio mandato, quindi «seri», «controllati», non eccentrici. Diversamente s’incrina lo stesso rapporto fiduciario con l’elettorato. Il mondo cattolico, rimasto cauto sulle prime, è poi intervenuto, esprimendo perlopiù disappunto e riprovazione circa i disinvolti comportamenti «privati» della persona in questione. Esponenti autorevoli della gerarchia e organi di stampa (fra i quali «Avvenire») hanno ribadito, con parole misurate ma chiare, la necessità di una correttezza morale da parte degli uomini politici in genere e, nella fattispecie, del capo del governo.
La vicenda, come sappiamo, ha avuto pesanti sviluppi. Siamo giunti alle querele degli organi di stampa che hanno svolto con puntualità il loro «mestiere» d’informazione e denuncia. Naturalmente, una volta scelta la linea dello scontro frontale con gli autori delle critiche, non si è andati per il sottile: ne sono stati pure testimonianza i virulenti attacchi giornalistici al direttore di «Avvenire», con il noto esito delle sue dimissioni. La cosa inaccettabile, fra le altre, è che chi pone il problema della moralità, anche privata, per i rappresentanti delle istituzioni venga ormai tacciato da molte parti come «moralista» (una sorta di quasi-insulto!) o come persona dedita al gossip (dunque, fatua e… affetta da «guardonismo»). In realtà, il penoso caso in esame, comunque si tenti di girarlo, getta discredito, oltre che sul diretto interessato, anche sul nostro sistema istituzionale e, in definitiva, sull’intero «bel paese». Per convincercene, basta mettere la testa fuori dai confini!
Un paese incattivito e problemi di difficile gestione
Quanto ai motivi di preoccupazione per l’Italia e la sua immagine, l’elenco sarebbe lungo. Prendiamo, ad esempio, le recenti disposizioni legislative in tema d’immigrazione e di sicurezza. Intendiamoci, siamo dinanzi a problemi gravi, che la popolazione avverte con particolare acutezza. Del resto, proprio su questi aspetti nevralgici per la vita civile il centro-destra ha impostato parte considerevole della campagna elettorale del 2008. E la scelta lo ha ampiamente ripagato. Certo, non è facile regolamentare, mettendo in tensione virtuosa sicurezza, legalità e solidarietà, il complesso fenomeno migratorio dai vari Sud del mondo in preda a povertà endemica, fame, guerre fratricide. Però c’è modo e modo. L’introduzione del reato di clandestinità, che colpisce chi, disperato, fugge dalla miseria, dalle dittature, dai conflitti, in cerca di un briciolo di speranza di vita e il respingimento dei barconi con il loro carico di umanità affranta portano consensi politici, ma sollevano enormi problemi di natura giuridica e, prima ancora, morale. La retorica governativa sugli aiuti a tutti coloro che si trovano nel bisogno («Non lasciamo indietro nessuno», si sente ripetere) trova nelle drammatiche vicende migratorie una smentita clamorosa. Abbiamo registrato con soddisfazione denunce a più riprese di rappresentanti dell’associazionismo cattolico e di organismi ecclesiali impegnati ogni giorno in favore degli immigrati. Ci confortano sul fatto che non possiamo avallare politiche così vessatorie nei confronti di chi chiede di fruire almeno delle briciole della doviziosa tavola dei paesi ricchi. Oltre tutto — ed è risaputo — senza le braccia degli immigrati per lavori e mansioni che noi non vogliamo più svolgere (incominciando dall’assistenza domiciliare a cronici e disabili), la nostra economia s’inceppa e molte famiglie non saprebbero che fare.
Le scelte politiche su immigrazione e sicurezza s’inseriscono in una strategia di difesa ed esclusione più che di accoglienza regolata ma inclusiva. Nessuno nega il diritto-dovere di proteggere i confini nazionali (il «sacro suolo della Patria», secondo la retorica d’antan) e di disciplinare il flusso immigratorio, corresponsabilizzando, fra l’altro, in modo concreto le istituzioni europee. Ma — ripetiamo — c’è modo e modo. In realtà, è in gioco una prospettiva di fondo, che investe l’idea stessa dello straniero (hospes o hostis?), il modello di società auspicata («aperta» o chiusa a riccio?), il rapporto fra identità autoctone e culture «altre», il riconoscimento effettivo dei diritti umani universali (compreso quello d’asilo). Purtroppo, registriamo un clima brutto nel paese, di chiusura e di antagonismo. Ci fa essere feroci con i deboli, incominciando dai disperati dei barconi e induce a pericolose generalizzazioni stigmatizzanti: l’«albanese» ieri, il «romeno» oggi (per non parlare del «mussulmano»). Ricchi come siamo, abbiamo dimenticato in fretta che anche i nostri nonni sono stati stranieri, vittime, sovente, di pregiudizi e umiliazioni inenarrabili. Non si tratta allora di spargere «buonismo» a larghe mani, ma di coltivare una precisa coscienza di civiltà e umanità.
Primo: curare il bene comune
Il paradosso italiano (meglio, uno dei paradossi) è che, mentre da un lato si legifera per difendere (si dice) i confini nazionali dagli assalti indiscriminati dei clandestini, dall’altro si trama per sgretolare l’idea stessa della «Repubblica, una e indivisibile» (art. 5 della Costituzione). Ancora una volta i mesi estivi sono stati occasione per la Lega Nord di un’offensiva propagandistica. Si è incominciato con le cosiddette «ronde» a presidio del territorio e con le «gabbie salariali», per differenziare, in rapporto al costo della vita, gli stipendi fra settentrione e meridione. Poi si è proseguito con una sequenza di proposte fantasmagoriche, delle quali è persino difficile tenere il conto: introduzione delle bandiere regionali, sostituzione del verdiano Va’ pensiero all’Inno di Mameli, esami di cultura locale per gli insegnanti, inserimento del dialetto nei curricoli scolastici. Al di là del folklore, siamo in presenza di «provocazioni» mirate e sistematiche, volte a incrementare, innanzitutto psicologicamente, il processo di disarticolazione interna del paese, per provare poi, nei fatti, a scindere i destini del Nord, ricco e produttivo, da quelli del Sud. L’obiettivo fondamentale resta, non tanto la cura del «bene comune» per l’intera penisola, quanto piuttosto la tutela degli interessi delle regioni settentrionali. Con tanti saluti alla solidarietà nazionale, in virtù della quale è legittimo e doveroso aspettarsi che chi più ha dia una mano a chi, per una serie di ragioni, fa maggiore fatica, senza volere con ciò giustificare e tollerare forme colpevoli di negligenze, ruberie e fatalismi.
Non è un momento facile per il «bel paese», alle prese con altri intricati nodi del vivere civile che, non risolti, finiscono con l’incancrenire, incidendo sulla stessa qualità della nostra democrazia. Si pensi solo all’ingombrante questione del conflitto d’interessi, specialmente ma non solo, nel sistema dei media (televisione, in primis), che tocca da vicino il presidente del Consiglio. In tutti i paesi occidentali di democrazia matura la situazione italiana su questo punto è semplicemente inconcepibile. Da noi, invece, per gran parte dei cittadini sembra non costituire più problema. Stante gli attuali, squilibratissimi rapporti di forza parlamentari fra maggioranza e opposizione, ogni seria ipotesi di riforma dell’esistente è destinata, purtroppo, al naufragio. Ciascuno però intende che in una società sempre più dominata dalla cosiddetta democrazia dell’audience, se il sistema della comunicazione/informazione pubblica, soprattutto televisiva, resta, di fatto, in regime di controllo quasi-monopolistico, diventa effettivo il rischio per la democrazia, la quale ha nella libertà di espressione e nella tutela del pluralismo irrinunciabili capisaldi. Su queste cose non si scherza. Il timore, si badi, non è per un salto all’indietro verso forme impositivo-autoritarie di altri tempi, ma per un balzo in avanti sempre più risoluto verso una sorta di eutanasia del pensiero, omologato e plaudente nei confronti del «Manovratore», che tenta un osceno baratto: l’offerta di «tranquillità sociale» e divertissement generalizzati in cambio dell’esercizio dello spirito critico e della denuncia civile.
Sì, siamo in un momento delicato per il «bel paese». Le vicende dell’estate, penose in alcuni casi, inquietanti in altri, debbono indurci a serie riflessioni e autocritiche. Non è più tempo di esasperate astuzie diplomatiche e d’interessati calcoli politici. Occorre il coraggio delle parole chiare. Come cattolici abbiamo responsabilità indifferibili.