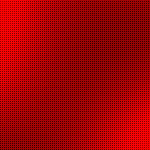Appunti 1_2009
La finezza del cuore del costituzionalista Elia
Enzo Balboni
La scomparsa repentina di Leopoldo Elia (Fano, 4 novembre 1925 – Roma, 5 ottobre 2008) ha privato il costituzionalismo italiano di un faro indiscusso, la politica italiana di una voce meditata e saggia, il cattolicesimo democratico di uno dei suoi più autorevoli interpreti, la cultura italiana in generale di un intellettuale curioso e di molteplici interessi. Lo ricordiamo qui con un contributo articolato e appassionato, non nascondendo che la nostra rivista e l’associazione Città dell’uomo hanno un motivo in più per ricordarlo con gratitudine: Elia fu tra i fondatori dell’associazione, vicepresidente con Lazzati e poi ebbe a guidarla dopo la scomparsa del fondatore.
Leopoldo Elia ha ragionato, militato e combattuto, nell’intero e intenso corso della sua vita, nella pattuglia d’avanguardia del «cattolicesimo democratico», da fedele cristiano munito di una solida maturità laicale, mantenendo un’ammirevole coerenza tra il pensiero e l’azione degli anni giovanili, quelli della maturità (assolvendo durante una lunga e operativa fase rilevantissimi incarichi pubblici) e poi nel tempo della sua anzianità, che è stata attiva ed efficace sino alla soglia della sua scomparsa. Per lui vale in pieno il detto e il vissuto paolino del bonum certamen certavi (II Tim 4, 7).
Elia è stato un giovane seguace dossettiano e, come lui, aderirono a quella linea, tra gli altri, Alberigo, Ardigò, Gorrieri; diversa per formazione, accenti e stile è la vicenda di Pietro Scoppola, amico di Leo ma non dossettiano, anche per ragioni biografiche, che certamente appartiene al nucleo cattolico democratico.1 Adesso sono tutti scomparsi, nel breve volgere di pochi anni, lasciando un vuoto che sarà impossibile colmare, ma ci consegnano un’eredità culturale e morale che chiede di essere onorata e a sua volta trasmessa. Per ciascuno di loro le stelle fisse rispetto alla cui posizione progettare il percorso e traguardare le opere e i giorni furono: un pensiero e una politica cristianamente ispirati, ma non clericali e lo sforzo di far progredire l’Italia verso una democrazia sostanziale.
Dovendo scegliere una chiave di lettura unitaria, ho ritenuto di inscrivere la parabola di Elia sotto il segno di due idee fondamentali, sintetizzabili nella sobria formula «Concilio e Costituzione», legate tra loro, alla maniera maritainiana e lazzatiana, da un et… et, piuttosto che, giacobinianamente, da un aut… aut.
Un «cristiano laico, adulto»
Le annotazioni su Elia possono cominciare col riportare la sua presenza come giovane della provincia (Ancona) che prende parte al XXVIII Congresso nazionale della Fuci, che si tiene a Napoli dal 2 al 6 settembre 1947 sul tema «L’universitario di fronte ai problemi della vita». Tra gli universitari compagni di Elia le cronache annotano, tra gli altri, i nomi di Alfredo Carlo Moro (Presidente nazionale della Fuci), Trebeschi (Brescia), Zàccaro (Firenze), ma ci sono anche don Franco Costa e Mons. Emilio Guano: due tra le migliori intelligenze e personalità di spicco della Chiesa, che seppero accompagnare il laicato cattolico sulla e oltre la via giovannea del Vaticano II.
Relatore principale al Convegno è Giuseppe Dossetti, in quel momento deputato all’Assemblea Costituente, professore universitario e guida indiscussa della corrente di sinistra della Dc. Anche se non possediamo testimonianze scritte dei risultati immediati dell’incontro tra Dossetti ed Elia (ma solo quelle orali, a me riferite da Leo stesso e suffragate da Trebeschi) l’impatto deve essere stato forte e plasmante. Il nucleo solido del messaggio, di alto valore culturale e religioso, che Dossetti trasmette ai fucini è l’argomentata contestazione del concetto di libertà come esposto dalle dottrine liberali (ma anche di quelle collettiviste e totalitarie e di non convincenti «terze vie», e qui cita Röpke). La nostra via è un’altra, sostiene Dossetti: «Essa riconosce la libertà non originaria, ma come dono che viene dall’alto attraverso una conquista personale, riconosce la libertà aperta verso le cose, verso gli altri e verso Dio»2. Elia prese parte alla II Commissione nella quale si articolarono i lavori del Congresso e questa trattò, sotto la direzione dello stesso Dossetti, della libertà come apertura verso gli altri.
Il sodalizio con Bachelet, A.C. Moro, Dossetti e Lazzati
Mi è parso significativo che, nel tracciare un ricordo dell’amico carissimo Vittorio Bachelet, barbaramente ucciso dalle Br nel febbraio 1980, Elia ne abbia sottolineato la concezione della democrazia come esercizio della responsabilità eticamente fondata, richiamandosi a un’idea di politica vissuta come «servizio pubblico» che, se trova il suo luogo privilegiato nelle istituzioni, si realizza però in tutto il tessuto della comunità civile3.
Elia e Bachelet erano coetanei e molto legati tra loro (il terzo grande amico era Alfredo Carlo Moro, il fratello minore di Aldo, direttore responsabile del quindicinale fucino “Ricerca”, di cui Leo fu condirettore): entrambi professori universitari prestigiosi e ammirati avevano scelto di approfondire e insegnare le discipline giuspubblicistiche. All’uno e all’altro furono affidati incarichi impegnativi e di alto rilievo: la funzione di giudice e poi presidente della Corte costituzionale per l’uno (1976-1985) e la vice-presidenza del Consiglio superiore della magistratura per l’altro (dal 1978 fino al barbaro assassinio nel 1980)4.
Elia sentì fortemente il fascino di Dossetti, del quale fu collaboratore fin da giovane (nella redazione di «Cronache sociali», per la quale appuntava regolarmente eccellenti cronache parlamentari sui dibattiti di maggior spessore e peso politico) e col quale riprese una consuetudine di fecondi incontri al momento del ritorno sulla scena pubblica di don Giuseppe nel biennio 1994-1996, quando il monaco di Monte Sole diede avvio, con i suoi ammiratissimi e trascinanti discorsi, e soprattutto con l’iniziativa dei Comitati per la difesa attiva della Costituzione alla battaglia civile che fu sintetizzata nello slogan: «valori da custodire e istituti da riformare».
Su Lazzati basterà ricordare che il fondatore di Città dell’uomo volle Elia tra i co-fondatori della nuova associazione di cultura e formazione politica con l’ufficio di vice-presidente. Non si dimentichi poi l’importante colloquio-intervista a Dossetti e Lazzati che Elia condusse nel 1984 insieme a Scoppola, edita poi nel 2003.
Sulla solida e immediata risaldatura del sodalizio con Dossetti posso dare testimonianza diretta fin dalla presenza di Elia alla gran giornata milanese del 18 maggio 1994, quando nella sede di Città dell’Uomo don Giuseppe, chiamato a rievocare Lazzati, ri-lanciò l’appassionato grido biblico Sentinella, a che punto è la notte?, per proseguire negli incontri con i costituzionalisti amici, il primo dei quali si tenne a Milano nel settembre 1994 e si svolse per tutto il successivo biennio.
Seguirono gli altri grandi discorsi di Dossetti sulla Costituzione e i pericoli per l’ordinamento democratico: a Milano, nel gennaio 1995, a Bari e Napoli nel maggio dello stesso anno. Ad essi Leo fu sempre presente, con i suoi interventi finemente argomentati e pacati nei toni, ma progressivamente sempre più incisivi e carichi di pathos, sino all’ultimo nell’aula Santa Lucia dell’Università di Bologna, il 3 febbraio 1996, svoltasi in assenza di Dossetti malato e in un’atmosfera gremita di appassionati della Costituzione e carica di una tensione politica che progressivamente si faceva sempre più acuta e quasi fisicamente percepibile5.
Una politica laica, cristianamente ispirata: ora come allora
Mi limito in questa sede al tentativo di mostrare, con l’aiuto di alcuni semplici materiali esemplari, uno degli abiti virtuosi che Leo ebbe sempre come proprio: quello del cristiano laico maturo. Per illuminare il tema, possiamo contare su un testo meditato e come sempre di alta qualità che, anche per la speciale sede in cui fu pronunciato, in forma di relazione al Convegno annuale dei costituzionalisti italiani (Napoli 2007), nonostante il titolo lessicalmente sobrio di Introduzione ai problemi della laicità, rappresenta una sintesi felice ed autorevole delle sue idee su un tema così delicato.
Prima di passare ai problemi dell’oggi, va fatto un collegamento con le convinzioni di un passato remoto, mai fortunatamente rimosso. È sempre bello e consolante scoprire che ci sono persone che sono rimaste fedeli ad un ideale, sempre che questo sia sano ed eticamente valido. Elia scrive, infatti, su «Ricerca» del 15 settembre 1948 un articolo significativamente intitolato Guardare lontano. Il testo è noto a pochi (immagino che sarà incluso nella Raccolta degli scritti che è in preparazione) e merita pertanto un’abbondante citazione. L’incipit corrisponde al titolo del pezzo: adesso che abbiamo vinto sembra naturale dimenticarsi «troppo spesso che una società cristiana è il presupposto inderogabile di una politica cristiana» [e non viceversa]. Invece, soggiunge Elia, qui ci si propone di raggiungere in fretta obiettivi immediati, quasi che una politica cristiana — evidentemente quella che molti si aspettano debba conseguire dalla vittoria elettorale — sia in grado di costruire una società cristiana, senza farsi troppi problemi, senza avanzare distinguo che possano venire bollati come intellettualistici, avendo di mira essenzialmente «di creare un’opinione pubblica» favorevole. E aggiunge, assai significativamente rispetto alle ondate propagandistiche che si erano succedute nei mesi precedenti: «spingere milioni di persone a votare in un determinato senso non è ancora creare un’opinione: bisogna piuttosto sviluppare alcuni motivi di azione, isolandoli in un contesto psicologico che oggi è ancora confuso e indecifrabile. È un lavoro senza scadenze fisse e che non si regge su espedienti organizzativi: è perciò il lavoro più difficile». E precisa: «Lo spirito che deve animarci è uno spirito di libertà». Occorre la fatica e il riconoscimento dell’esistenza di problemi: «partire con la convinzione di avere già in mano le soluzioni […] sarebbe equivoco fallimentare». Adesso arriva la parte di quei pensieri che hanno mantenuto una evidente attualità, ed è anche per questa ragione che li trascrivo:
«E’ vero: il cristiano non può mai accontentarsi del problemismo: e tuttavia questa disposizione spirituale condiziona la nostra idoneità ad essere fattori di storia. Del resto porci con spirito di indipendenza di fronte ai problemi non significa affatto dimenticare le soluzioni supreme del Vangelo e della Chiesa; significa piuttosto cercarne le possibilità di realizzazione temporale, tenendo conto di tutte le incognite di un’epoca. I cattolici, in questo campo, hanno bisogno non tanto di direttive che risultano di necessità controproducenti, ma piuttosto di un richiamo costante alle loro responsabilità: e anche di alcune condizioni negative che facilitino la loro opera». Nel nostro ambiente — ne è consapevole Elia — da alcuni «si vorrebbero solo parole d’ordine, direttive di marcia e non si comprende come questo della perplessità, dell’esitazione necessaria sia un momento indispensabile di ogni effettiva presa di coscienza. Una comprensione più acuta nei riguardi della ricerca dovrebbe dunque manifestarsi, non certo tentando di organizzare quel che non è possibile organizzare, ma evitando di soffocare nell’urgenza delle soluzioni la coscienza dei problemi. Ogni forma di paternalismo sarebbe qui non solo controproducente ma addirittura impotente». L’alternativa al modello di Gedda è scolpita con nettezza.
Mettersi per quella via, attivistica, presenziale e non problematica — conclude Elia — «getterebbe un discredito preventivo sopra qualsiasi sforzo di duratura influenza spirituale: creerebbe una inibizione invincibile per molti, forse per troppi. È questo un punto fondamentale…». Gli stessi concetti erano stati espressi, a caldo, il 1° maggio 1948 sullo stesso periodico da Bachelet nell’editoriale intitolato Dopo le elezioni: un testo che, curiosamente non è compreso nella pur pregevole raccolta dei suoi Scritti civili già citata, bensì in quella degli Scritti ecclesiastici. Per questa ragione ne trascrivo uno dei passi conclusivi: «Da ultimo il risultato positivo di queste elezioni ci pone di fronte a nuove e più grandi responsabilità. Se del buon esito di queste elezioni noi eravamo in qualche modo responsabili verso la patria, verso la Chiesa e verso il mondo, oggi questa nostra responsabilità non è diminuita. Non basta qualche settimana di entusiasmo e di lavoro generoso. L’umanità, la Chiesa, la patria, hanno bisogno di un lavoro rude e costante di uomini preparati e capaci, intelligenti e buoni. Il lavoro di formazione e di educazione su cui sempre abbiamo insistito assume oggi una importanza ancora più grande» e prosegue, concludendo: «noi dobbiamo educarci a un cristianesimo completo, a una cultura vera, a una socialità capace di offrire soluzioni».
Ruini segua Moro: non leggi ma evangelizzazione
Se, adesso, facciamo un salto di sessant’anni e ci riportiamo ai nostri giorni, che hanno visto numerose incursioni e massicce prese di posizione, su temi etici ma con alta valenza politica, da parte della gerarchia ecclesiale con in testa la Conferenza Episcopale italiana, sentiamo vibrare ancora la parola di Elia. Per chi lo ha conosciuto bene e ha avuto il privilegio di godere della sua fine amicizia e di frequentare la sua mitezza (ma niente affatto arrendevolezza, come ha bene chiarito Alessandro Pace nel suo ricordo) saranno a prima vista apparse un po’ sopra le righe le parole da lui scambiate con Aldo Cazzullo nel pieno della vicenda delle «unioni di fatto» che prende nome dai Dico, nome infelice di un disegno di legge governativo che i proponenti, i ministri Bindi e Pollastrini e la maggioranza pro-tempore, non riuscirono a presentare adeguatamente, segnalando in positivo l’urgenza equitativa di riconoscere la realtà delle unioni di fatto con interventi di carattere assistenziale, particolarmente a favore del soggetto debole di queste unioni, ma finendo poi per essere travolti nella guerra ideologica che ne scaturì.
Il progetto venne assalito e battuto in breccia da una campagna di opinione quanto mai aspra ed intensa, nella quale si distinsero i cosiddetti teo-dem e gli «atei devoti» e, poco dopo, venne abbandonato nella palude dei lavori delle commissioni parlamentari. Per Elia fu doloroso constatare e dover prendere atto di un atteggiamento della Chiesa non solo battagliero, ma assai più duro delle dichiarazioni e dei comportamenti tenuti in occasione di fatti assai più gravi e dolorosi, quali l’introduzione del divorzio e la legittimazione dell’aborto: leggi, dunque, che ferivano davvero a fondo l’istituto del matrimonio e il diritto alla vita. Inoltre, ben diversa, perché più misurata, era stata la reazione della Conferenza episcopale spagnola nei confronti di un leader cattolico come Aznar, la cui proposta sulle unioni di fatto non si discostava troppo da quella pensata in Italia. Lo stesso discorso poteva valere per le reazioni episcopali che si erano avute con riguardo ai Pacs in Francia. Pareva che solo l’Italia potesse e dovesse fare eccezione lasciando intendere propositi di riconquista e di egemonia culturale poco consoni alla temperie dei tempi e dei luoghi: «Fatto sta che la Chiesa italiana non accetta di europeizzarsi», aggiunge Leo e par di vederlo scuotere sconsolatamente la testa6.
C’era stata nel 2005 l’altra dolorosa e fratturale vicenda della legge che aveva disciplinato la fecondazione assistita e un ultimo caso (per ora?) si è verificato nel luglio 2007, nel corso dell’ormai lungo percorso di approvazione di una legge in tema di libertà religiosa: nel corso di un’audizione parlamentare monsignor Betori ha segnalato preoccupazioni e contrarietà della Chiesa italiana, in via generale, «per l’introduzione del principio di laicità, addirittura quale fondamento della legge sulla libertà religiosa» e, in modo più specifico, circa una «sostanziale omologazione alla religione cattolica delle confessioni religiose». Registrando queste preoccupazioni il cristiano laico maturo Elia le commenta così: «Veramente non si capisce come una confessione così forte in fatto e in diritto come quella cattolica, almeno in Italia, possa nutrire simili preoccupazioni»7.
Non è con una legislazione eventualmente imposta né con una «politica cristiana» che si costruisce e si mantiene una società cristiana, ma è con la condivisa presenza, coltivazione e assimilazione dei valori cristiani — compreso quello del principio di laicità che operi insieme ad altri valori umani e universali (i quali non vanno ovviamente in opposizione ai primi) — che si può tentare di dare vita progressivamente e problematicamente a una società pienamente umana e a una convivenza cristianamente ispirata.
Problemi pratici della laicità
In almeno due importanti occasioni di riflessione scientifica Elia si è soffermato, negli ultimi anni della sua vita, sui problemi della laicità, avendo riguardo in particolare ai problemi ed anzi ai dilemmi posti dalla bioetica e dalla biopolitica (ad es. sull’inizio e la fine della vita). Da una parte egli segnalava il cambio di scenario intervenuto con la scomparsa dei grandi attori politici collettivi, a cominciare dalla Dc. Afferma Elia — e credo ci sia un largo consenso sul tema — che nel «rapporto di corrispondenza biunivoca» che, di fatto aveva collegato per decenni la Chiesa italiana e il partito politico rappresentativo della larga parte dei cattolici italiani, «De Gasperi e gli altri uomini di governo democratico-cristiani avevano dimostrato in più di una circostanza di possedere una misura notevolissima di senso dello Stato». Nel vuoto di rappresentanza e di potere creatosi in seguito, si sono inserite forze politiche che «per acquisire vantaggi elettorali» hanno inteso «offrire soluzioni di questioni sul tappeto (non ancora chiuse) ritenute da essa più favorevoli per le autorità ecclesiastiche»8.
In secondo luogo, nella consapevolezza della difficoltà aspra e sovente dilemmatica che i problemi evidenziano, Elia sostiene la tesi che funzione del diritto è, in certi casi, quella del permettere e del facoltizzare. Non solo nel caso del divorzio, dell’aborto, della procreazione assistita, del trattamento degli embrioni e del fine vita, ma in tutti i casi nei quali si discute nell’opinione pubblica e nelle istituzioni di argomenti umani ed etici essenziali devono essere garantiti alla Chiesa e ai pastori le occasioni e gli spazi, non solo negli edifici di culto ma nel dibattito pubblico, per dissuadere chi ascolta la loro voce da atti e comportamenti che sono inconciliabili con il vissuto evangelico. Tuttavia, la Repubblica e il suo diritto debbono poter consentire e «permettere» quelle pratiche che non infrangano i diritti umani costituzionalmente garantiti. In taluni casi, opportunamente, i credenti potranno far valere una loro motivata e seria obbiezione di coscienza (come esemplarmente accade nei casi di interruzione volontaria della gravidanza e in altri casi assimilabili, legislativamente normati o da disciplinare).
È bello e consolante però che Leopoldo Elia rivendichi di esporre le sue idee come sempre con pacatezza ma con altrettanta umile fierezza, volendosi esprimere «come costituzionalista e come cittadino cattolico»9. L’intervista pubblicata sul Corriere della sera aveva un incipit emozionante, come di chi si mette nella scia di un Bonhoeffer:10 «Forse sarò troppo drastico, ma preferisco parlar chiaro oggi piuttosto che pentirmi domani per aver taciuto»11. Sono parole che si addicono a un maestro di diritto e di etica e Leo lo è stato: per questo non consideriamo di averlo perduto.
2 È interessante annotare che il nucleo forte di questa convinzione tornerà nella grande relazione dossettiana Funzioni e ordinamento dello Stato moderno (1951), soprattutto nel corso dell’acceso dibattito tra Dossetti e Carnelutti.
3 L. Elia, La lezione di Vittorio Bachelet per l’oggi (1980): traggo la citazione dalla bella introduzione di M. Truffelli agli Scritti civili di V. Bachelet pubblicati da Ave, Roma 2005, pp. 19-20 e spec. 32.
4 Del robusto sodalizio amicale tra A.C. Moro, Elia e Bachelet, ha scritto un bel ricordo Giovanni, il figlio di Vittorio, su «Democratici davvero» dell’8 ottobre 2008, consultabile anche sul sito di Astrid (www.astrid.it).
5 Per un’attenta rilettura di quel periodo e dell’impegno di Dossetti, a sostegno del quale Elia ebbe gran parte, anche per l’alta considerazione in cui lo teneva don Giuseppe, rinvio al contributo di U. Allegretti, in A. Melloni (a cura di), Giuseppe Dossetti: la fede e la storia, il Mulino, Bologna 2007.
6 Intervista di A. Cazzullo a L. Elia in «Corriere della sera», 13 febbraio 2007.
7 L. Elia, Introduzione ai problemi della laicità, Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (Napoli 2007) nel volume degli Atti edito da Cedam, Padova 2008.
8 L. Elia, A proposito del principio di laicità dello Stato e delle difficoltà di applicarlo, in Studi in onore di G. Berti, Jovene, Napoli 2005, vol. II, pp. 1073-1074.
9 L. Elia, Introduzione ai problemi della laicità cit., p. 9.
10 Sul quale, da ultimo, ha scritto dense pagine molto belle G. Ruggieri, La verità crocifissa, Carocci, Roma 2007, pp. 115-140.
11 Intervista di A. Cazzullo cit.