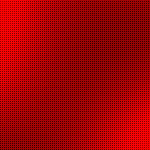Appunti 1_2009
Pd, un partito… mai partito
Franco Monaco
I lettori di «Appunti» mi sono testimoni. Su queste pagine, subito dopo la caduta del governo Prodi, dunque ben prima della débacle elettorale, proposi una mia lettura decisamente critica della «nuova stagione» del Pd. In particolare, avanzai la tesi secondo la quale il Pd si costituiva nel segno della sconfessione piuttosto che della realizzazione e del compimento del progetto dell’Ulivo. Quella che allora poteva essere interpretata come un’illazione o un pregiudizio è stata poi autorevolmente avallata da Veltroni e dai suoi più stretti collaboratori. Non solo e non tanto attraverso una campagna elettorale condotta all’insegna della parola d’ordine «nascondere Prodi e far dimenticare il suo governo» (quasi che esso si risolvesse nella sola persona di Romano Prodi e la sua struttura portante non coincidesse con l’intero gruppo dirigente del Pd, circostanza questa che Berlusconi ebbe facile gioco nel fare valere in campagna elettorale), ma soprattutto nel segno dell’assunto, espressamente formulato da Veltroni, dei «quindici anni buttati».
Quindici anni che, per incidens, sono stati appunto gli anni dell’Ulivo. Assunto quanto mai eloquente, che sconcerta per la sua leggerezza prima che per la sua ingenerosità. Non solo perché misconosce gli oggettivi risultati conseguiti dai governi dell’Ulivo ma — qui sta il punto — soprattutto perché ignora la circostanza che, senza quel progetto politico, l’intero attuale gruppo dirigente del Pd sarebbe stato accompagnato alla porta già all’inizio degli anni Novanta. Gli ex comunisti in quanto, pur nella relativa peculiarità italiana, associati a una tragedia di portata epocale: appunto il comunismo; gli ex democristiani a motivo di una meno drammatica ma comunque indubitabile decadenza politica. Penso non tanto alla degenerazione della moralità e del costume, quanto alla cattiva amministrazione. Quella che ha condannato tutti i governi che sono seguiti, di destra o di sinistra, a destinare larga parte delle loro energie e delle risorse disponibili a sanare il colossale debito pubblico accumulato irresponsabilmente negli anni Ottanta e che tuttora incombe su di noi.
Sconcerta e irrita, specie sulle labbra di ex comunisti (già, ma Veltroni sostiene di non esserlo mai stato), la tesi dei quindici anni buttati se si considera che, solo grazie all’Ulivo, la sinistra italiana è assurta per la prima e unica volta a responsabilità di governo in sessant’anni di storia repubblicana. Non mi pare poco.
A prendere atto della discontinuità del Pd rispetto all’Ulivo, traendone le conseguenze, è stato lo stesso Romano Prodi. Senza sollevare polemiche, già prima delle elezioni in forma riservata per non recare danno, aveva provveduto a dimettersi dalla presidenza del Pd con una lettera indirizzata a Walter Veltroni. Dimissioni che egli non ha ritenuto di revocare poi, nonostante le pressioni in tal senso esercitate su di lui.
Il progetto dell’Ulivo
Facciamo allora un passo indietro. Qual era la sostanza dell’Ulivo, la visione e il progetto ad esso sottesi? A questa domanda si può rispondere in due modi. Primo: riflettendo sulla storia non solo politica ma anche culturale e civile del nostro paese, chi pensò l’Ulivo si proponeva di concorrere a sanare le due principali linee di frattura che l’avevano segnata: quella tra comunisti e anticomunisti e quella, con radici più antiche e più profonde e che poi si è rivelata ancor più insidiosa, tra laici e cattolici. Le si definì, sinteticamente, questione comunista e questione cattolica, nella sua valenza politica.
Ma c’è un secondo modo di declinare la missione che l’Ulivo assegnava a se stesso: quello di far compiere uno scatto in avanti alla democrazia italiana. Una democrazia ancora giovane, bloccata, difficile, incompiuta (sono solo alcuni degli aggettivi, per lo più ascrivibili a Moro, con i quali si designava la democrazia italiana nel primo tempo della Repubblica). Uno scatto in avanti, una positiva evoluzione del sistema politico che può essere a sua volta articolata in tre direzioni:
1. passare da una democrazia bloccata a una democrazia competitiva e dell’alternanza;
2. da una democrazia della mera rappresentanza a una democrazia governante, cioè da un sistema nel quale i cittadini si limitano a eleggere i propri rappresentanti in parlamento a un sistema nel quale essi scelgono i governi, sottraendoli alla morsa e agli interessi angusti delle oligarchie di partito, così da conferire loro più forza e più stabilità;
3. da una democrazia tutta e solo dei partiti a una democrazia restituita ai cittadini al servizio dei quali gli stessi partiti dovrebbero porsi. Si rammenteranno, al riguardo, due fortunate metafore rispettivamente coniate da Gianfranco Pasquino e Roberto Ruffilli: si trattava di restituire lo scettro al principe, al cittadino sovrano e di fare di esso l’arbitro-decisore del sistema democratico.
Lungi da me sostenere che quegli ambiziosi obiettivi, davvero di portata storica, siano stati conseguiti, ma mi si consentirà di reagire a chi, con una battuta, liquidava quell’esperienza e quel progetto maiuscolo come da buttare. Testimoniando leggerezza e nuovismo, come se la storia cominciasse con se stessi. Del resto, i risultati della decantata «nuova stagione» concepita all’insegna della discontinuità rispetto all’Ulivo sono sotto i nostri occhi.
Le primarie
È bene tornare con la mente all’autunno 2007, all’atto di nascita del Pd, coinciso con le primarie per eleggere il segretario politico. Mi esprimo sinteticamente così: il Pd, nato con grande ritardo, in quel frangente, conobbe un’inopinata accelerazione. La più parte dei problemi del Pd affonda le sue radici appunto in quella sciagurata precipitazione. Le primarie erano segnate in radice da un equivoco: nei fatti non si andava ad eleggere il segretario politico del partito, ma il candidato premier di elezioni giudicate imminenti e che, con quell’accelerazione, si contribuiva ad avvicinare. Con un corollario: dovendosi attrezzare per una prova elettorale, si pensò bene di convergere tutti o quasi sul candidato ritenuto più competitivo con l’avversario, più che su quello idoneo alla leadership di partito con un suo preciso profilo politico. Di qui la sostanziale vanificazione delle primarie come competizione aperta tra più candidati intestatari di piattaforme politiche distinte e distinguibili; di qui l’occultamento, dietro l’unanimismo di facciata, delle differenze politiche che ci sono, eccome, dentro il Pd (sarebbe sorprendente il contrario) e che poi sono puntualmente venute a galla; di qui lo slittamento o meglio lo snaturamento delle primarie nella direzione di un rito plebiscitario d’investitura del candidato pensato come unico; di qui l’originaria rinuncia di Veltroni a sfidare l’establishment dei partiti e delle correnti (come si conviene a un vero leader) e, al contrario, la sigla di un patto oligarchico che gli assicurasse il plebiscito; di qui l’esito già scritto di una larga investitura personale cui tuttavia corrispondeva un pesante condizionamento da parte degli apparati; di qui quel mix di velleità leaderiste e di prassi oligarchiche che ha contrassegnato e contrassegna la travagliata vita del Pd; di qui, infine, l’identità incerta e la linea ondivaga di un partito condannato al «ma anchismo», a cento linee e a nessuna linea un po’ su tutto.
A questo esito, a mio avviso, hanno condotto quattro fattori: l’istinto personale di Veltroni refrattario alle sfide a rischio; l’invincibile resistenza degli apparati, delle correnti e delle cordate personali a cedere al leader effettiva sovranità; la cultura dei due partiti promotori rispettivamente ispirata al mito-dogma comunista dell’unità del partito Ds che non ammette competizione plurale e che dunque non poteva che avere un candidato solo (si pensi al ritiro indotto dell’annunciata candidatura di Bersani), nonché alle pratiche da caminetto di marca democristiana che, storicamente, hanno sempre mal sopportato leadership forti; le regole stesse delle primarie accuratamente disegnate in vista del candidato unico. Si pensi alla singolare, furbastra regola secondo la quale un candidato poteva essere sostenuto da più liste e dunque da piattaforme politiche diverse. Veltroni, a differenza di Bindi e Letta, ne ebbe ben tre su base nazionale ed altre in sede locale. Sino alla bizzaria di una lista denominata «a sinistra per Veltroni», che raccolse un largo consenso attratto dalla parola «sinistra» (appunto la parola), nel mentre Veltroni al Lingotto di Torino esordiva con un discorso di chiara marca centrista.
La crisi del governo Prodi
Su queste equivoche basi, le primarie si risolsero in una piccola, grande truffa e in una occasione mancata, in una falsa partenza. Era poi evidente che il dualismo Prodi-Veltroni non avrebbe potuto reggere. Il primo impegnato a tirare il carro del governo, con la sua pesantezza e i suoi contrasti, e dunque condannato all’impopolarità, l’altro libero e leggero nel disegnare nuovi, azzurri orizzonti. Vecchio contro nuovo, grigiore e pesantezza contro sogno e leggerezza. Prodi era piombo nelle ali con le quali Veltroni si librava nel cielo della bella politica.
Il colpo mortale al governo Prodi venne dall’annuncio che il Pd avrebbe corso da solo. Come si poteva difendere un governo che si reggeva su una formula politica che il principale partito di maggioranza aveva solennemente sconfessato, decretandola non solo esaurita, ma, di più, fallita? La destra aveva buon gioco a denunciare tale clamorosa contraddizione, la sua polemica politica entrava facilmente come una lama nel burro della nostra ambiguità.
A questo proposito, merita osservare che se il governo è caduto per mano di un manipolo di trasformisti posizionati sul fronte destro della maggioranza e se, certamente, la sua immagine è stata appannata dai frequenti distinguo e dalle tensioni introdotte dalla sinistra critica, non meno decisiva è stata l’azione di logoramento di lunga lena operata da singoli e gruppi interni al perimetro dell’Ulivo. Mi limito a un solo esempio: quello di Rutelli che, già nella primavera del 2007, se ne uscì con la proposta delle «alleanze di nuovo conio», corredata da giudizi politici sul governo non dissimili da quelli dell’opposizione. Tradotto dal politichese, il «nuovo conio» significava sbarcare le forze di sinistra, cioè spaccare la maggioranza sulla quale si reggeva il governo di cui Rutelli era vicepremier in carica.
Chi volesse conoscere più in dettaglio tutti i passaggi e anche qualche retroscena inedito non ha che da leggere il bel libro di Rodolfo Brancoli, stretto collaboratore di Prodi a Palazzo Chigi, dal titolo Fine corsa, le sinistre italiane dal governo al suicidio, Garzanti, Milano 2008. Si tratta di un documentatissimo atto d’accusa della miopia e dell’irresponsabilità dell’intero gruppo dirigente del centrosinistra, soprattutto dell’egoismo di partiti, gruppi e singoli esponenti politici, spesso mossi da ossessione di visibilità e di posizionamento in vista di sviluppi politici futuri. È un libro, quello di Brancoli, che fornisce le prove documentali della profonda solitudine di Romano Prodi. Una solitudine attestata persino dall’epilogo: Prodi, pressoché solo, fortissimamente volle parlamentarizzare la sua caduta, in nome della trasparenza delle responsabilità e della conformità alla Costituzione. Prodi, come ama dire lui stesso, ha vinto due volte e due volte è stato buttato giù dai «suoi» (?). Ma egli può vantare un singolarissimo merito nella storia della Repubblica: quello appunto di essere stato sfiduciato in parlamento, come si conviene alla democrazia parlamentare.
La campagna elettorale
Il tentativo di costituire un governo Marini era condannato a fallire. A dispetto delle infinite chiacchiere sulla riforma delle regole, a cominciare da quella elettorale, quando Berlusconi intravide la possibilità di andare all’incasso, in un minuto mollò il Pd che, con una buona dose di ingenuità, gli aveva prestato credito, mettendo in fibrillazione la maggioranza. Si precipitò dunque verso elezioni. Come anticipato, la campagna elettorale fu condotta nel segno della (vana prima che ingiusta) dissociazione dal governo Prodi e della teorizzata discontinuità rispetto all’Ulivo. Ma, già nel vivo della campagna elettorale, si sono puntualmente manifestati i menzionati deficit di identità, di visione e di strategia che affondavano le radici nelle primarie-plebiscito.
Basti notare che tutti, ma proprio tutti, i quattro capisaldi della campagna elettorale (buoni o cattivi che fossero) sono stati poi abbandonati: la pretesa autosufficienza, l’alleanza esclusiva con l’Idv, la partnership privilegiata con Berlusconi per riformare lo Stato, il maggioritario e il modello francese. Una questione, quest’ultima, che non è problema tra i tanti. Essa riveste una portata strategica, concorre a definire il Pd. Vi sottendono una visione o un’altra affatto diversa del sistema politico e della dinamica evolutiva cui si intende contribuire e, a valle, diverse interpretazioni circa l’identità e la missione del Pd. Ma, avendo D’Alema messo a verbale la sua opzione per la proporzionale e il modello tedesco, il vertice del Pd non si è azzardato a incrociare le armi, ancora una volta condannandosi a non disporre di un profilo e di una linea riconoscibili.
Le elezioni e il dopo
Le elezioni sono andate come sono andate. Il problema è che sono state raccontate come una mezza vittoria. Intendiamoci: la sconfitta elettorale ci stava tutta, era in un certo modo nel conto. Ma, ben oltre la sconfitta elettorale, seguita poi dalla disfatta di Roma, della Sicilia e dell’Abruzzo, sì è trattato di sconfitta politica di carattere strategico certificata da due dati: 1) tutta la campagna elettorale del Pd mirava a sfondare al centro, il risultato è stato affatto diverso: da quel lato non si è preso nulla e si sono invece cancellate le formazioni a sinistra del Pd; 2) ne è sortito un campo di centrosinistra devastato, più piccolo e, insieme, più diviso. Un risultato che si deve alla sciagurata «separazione consensuale» consumata con allegria e in leggerezza tra Veltroni e Bertinotti. Che quel rapporto non potesse essere riproposto come tale si può convenire, ma è stato sbagliato caricare quella rottura di una valenza strategica e irreversibile. Ci si mette un attimo a operare la rottura, ci vogliono poi anni per ristabilire un rapporto. Un processo unitario difficile e travagliato ma il cui filo, prima o poi, dovrà essere ripreso.
A fronte di una débacle di tali proporzioni ci si sarebbe attesi un severo e coraggioso esame critico e autocritico, la convocazione di un congresso o comunque dell’assemblea costituente del Pd, unico organo democraticamente eletto insieme al segretario, che invece è stato liquidato. Nulla di tutto questo. In verità era lecito attendersi anche le dimissioni del segretario. Le primarie conferiscono grande potere e dunque responsabilità al leader, con una investitura diretta che associa strettamente il partito alla sua persona. Sembrerebbe ovvio che il segretario non voglia trascinare il partito nel logoramento di sé e della sua immagine che inesorabilmente segue alle sconfitte. I loquaci consiglieri giuridici di Veltroni, in passato, avevano teorizzato in ogni sede sia il principio di responsabilità per cui il leader sconfitto passa serenamente la mano, sia il principio di contendibilità per il quale le primarie o sono competitive o non sono primarie. Dunque, niente discussione aperta sulle sconfitte, niente verifiche, niente congressi o assemblee. Al loro posto una conferenza programmatica slittata di mese in mese e ora fissata a ridosso delle elezioni europee ed amministrative. Inesorabilmente, una kermesse elettorale, niente a che vedere con un confronto serrato, con un chiarimento politico, con una verifica del gruppo dirigente.
Le elezioni europee e la disputa sulla soglia
La stessa campagna per le elezioni europee è cominciata nel peggiore dei modi: con una forzatura sulla soglia al 4 per cento concordata con il Pdl. Una misura che incappa in quattro obiezioni:
1. circa i tempi: noi stessi levammo alte grida nel 2006 contro il varo della legge elettorale nazionale a ridosso del voto;
2. circa l’oggetto: le elezioni europee non mirano a costituire maggioranze atte a sostenere governi di cui l’Ue ancora non dispone e dunque non giustificano forzature in senso maggioritario miranti alla governabilità;
3. circa il contesto: vale la pena aggiungere altri motivi di divisione nel campo, già devastato, nel centrosinistra?
4. non è affatto certo che tale forzatura porti voto utile «da sinistra» al Pd (fuor di ipocrisia, questa è la vera ragione della soglia), anzi essa potrebbe ingrassare l’astensionismo risentito. Tanto più che oggi il Pd non esercita più quel potere di attrazione che esso esercitava solo un anno fa.
Del resto, è da chiedersi perché mai Berlusconi, che si è fatto scaltro politicamente e non regala nulla, avrebbe fatto tale dono al Pd se non calcolando quei costi politici in capo ad esso? In concreto, scommettendo su un bipolarismo asimmetrico nel quale egli, che è riuscito nell’impresa di dare unità nel suo campo, è destinato a vincere agevolmente contro un Pd in rotta con gli alleati attuali e potenziali. Mi chiedo: un Pd stimato al 25 per cento può immaginare non dico di vincere ma anche solo di competere con il centrodestra senza tessere con cura una rete di alleanze? Può proclamare la sua vocazione maggioritaria nel mentre si consegna alla solitudine e dunque al suo contrario, cioè a una condizione e a un destino minoritario permanente?
Come non bastasse, qualche sapientone preme per un divorzio dall’Idv, oggi stimato quasi al 10 per cento. Si dovrebbe piuttosto adoperarsi per stabilire una rete di alleanze che comprenda ma insieme trascenda (e temperi) l’Idv. Non c’è bisogno di essere geniali strateghi, basta saper fare di conto per considerare che un centrosinistra sotto di oltre 15 punti non può allegramente rompere con una forza del 10 per cento. A meno che si rinunci pregiudizialmente alla competizione o si pensi a governi di larghe intese con (sotto) Berlusconi. Non solo: se gli uomini asserragliati nel bunker al vertice del Pd si sporgessero un po’ fuori o anche solo leggessero le rilevazioni scoprirebbero che alla base, tra elettori e militanti, lo spirito unitario tra Pd e Idv è infinitamente più forte che non ai vertici. Sì, talvolta Di Pietro è scomposto, le sue parole e i suoi comportamenti non sono sempre in linea con il «politicamente corretto», ma egli rappresenta istanze legalitarie ed energia oppositiva cui lo stesso Pd non dovrebbe essere insensibile. Il Pd potrebbe e dovrebbe adoperarsi per ricondurre tali istanze parziali a una visione più organica e di governo, se solo avesse un po’ più di fiducia in se stesso.
Ma, anche a questo riguardo, siamo rinviati alla differenza tra Ulivo e Pd. L’Ulivo era pensato come soggetto unitario promotore di unità dentro una più vasta alleanza riformatrice con vocazione e cultura di governo, che, come si scrisse, esclude solo chi si esclude. Anche per dare il senso di tale tensione unitiva e inclusiva e non per timidezza o ipocrisia, lungo il percorso dell’Ulivo, ci siamo a lungo inibiti la parola «partito». Non perché il partito non ci voglia, anzi, ma per marcare l’esigenza di non irrigidirne i confini, per tenerli aperti a nuovi, ulteriori soggetti. Un soggetto che è anche un processo, esattamente come la UE.
Del resto, come sorprendersi della distanza tra l’attuale Pd e l’idea originaria dell’Ulivo? Basterebbe riflettere alla circostanza che oggi, alla guida di un Pd precipitosamente messo su in poche settimane, sta esattamente lo stesso gruppo dirigente dei vecchi partiti che, per tredici lunghi anni, vi si sono opposti strenuamente. Qualcuno dovrà pur ricordare, per la storia, che il governo Prodi non avrebbe avuto i problemi che ha avuto a motivo di una risicatissima maggioranza al Senato se solo, per quel ramo del parlamento, ci fossimo presentati con la lista unitaria dell’Ulivo che invece fu affossata da una sciagurata decisione di Margherita in una drammatica assemblea del 2005 nella quale Rutelli e Marini, Franceschini e Fioroni fecero la spunta nominativa dei loro seguaci.
Che fare?
La ricostruzione del percorso che ha preceduto e seguito la nascita del Pd ci autorizza a concludere — mi si perdoni il gioco di parole — che il partito del Pd ancora non è partito, privo com’è di identità politica e di democrazia interna. Che fare, dunque?
In sintesi, si dovrebbe agire in tre direzioni.
La prima: mettere a punto un programma audacemente riformatore nitidamente alternativo al sistema di valori della destra berlusconiana. Affrancandosi da una subalternità culturale prima che politica ai paradigmi e alle soluzioni della destra. Non adottando le sue stesse ricette con la sola variante di un loro temperamento, in nome di un declamato riformismo (mai parola fu tanto abusata ed equivoca) fatto coincidere con il moderatismo. A tale omologazione concorre, a mio avviso, una certa ossessione revisionista, quasi il complesso dell’estremismo giovanile di chi, venendo dalla sinistra comunista, ha smarrito o ripudiato i vecchi riferimenti. Così pure concorre a tale subalternità la sterilità di idee e di proposte politiche in senso proprio degli ex popolari, dopo Moro e Andreatta. Al punto da marcare talvolta una propria distinzione solo in negativo, subendo l’egemonia dei teodem, culturalmente agli antipodi del cattolicesimo liberale e democratico.
Della seconda direttrice di azione si è già detto: tessere una politica delle alleanze su più fronti a partire dal programma riformatore cui si è fatto cenno. Terza, infine, la priorità delle priorità: la democrazia interna di partito. C’è un che di paradossale nella circostanza che un partito denominato democratico sia totalmente privo della benché minima democrazia interna. Come si diceva, esso non dispone di un solo organo nazionale democraticamente eletto. La sua direzione è stata nominativamente designata dal vertice sulla base di quote convenzionali assegnate alle correnti vere e persino a quelle presunte, a cordate personali spesso preesistenti persino ai due partiti che pure si dichiarava di superare dentro il partito nuovo. Alla luce della ricostruzione sopra abbozzata la cosa si spiega: l’assetto di vertice rispondeva esattamente al patto oligarchico che aveva blindato le primarie. Si ha un bel predicare contro la litigiosità, certo deprecabile. Ma dove altrimenti si può fare valere un’opinione se non sulle pagine dei giornali quando non esiste un solo luogo nel quale sviluppare un confronto di posizioni e, a valle di esso, assumere decisioni comuni che, solo a queste condizioni, possono essere impegnative per tutti?
È questa, insisto, la madre delle priorità. Sia perché senza democrazia interna, senza un aperto confronto non si può forgiare un’identità e una linea politica coerenti e riconoscibili, condannandosi ad essere il partito del «ma anche». Sia perché — è convinzione che ho maturato da tempo — quello della chiusura oligarchico-castale è il vero, decisivo handicap del Pd e del centrosinistra. Il suo svantaggio competitivo in rapporto al centrodestra. Il nostro personale politico trasmette un messaggio di autoreferenzialità e di chiusura alla società. Dà l’impressione di essere una casta per la semplice ragione che lo è. Quelli, per dirla con la brutale efficacia di Berlusconi, che non hanno mai lavorato. Un’immagine che ci fa male, che segna la nostra condanna. Non è così a destra, la cui struttura è piuttosto monarchica. Ove però il monarca, nella sua sovrana libertà, può permettersi di cooptare un personale politico, parlamentare e persino di governo, che rispecchia di più la società. Nel bene e nel male. Dilettanti, affaristi e veline comprese.
Possibile che, tra l’assetto oligarchico della sinistra e quello monarchico della destra, non sia possibile praticare una terza via, quella democratica, che tuttavia esige un vasto e radicale ricambio di un personale politico oggettivamente consumato? Un rinnovamento che certo non si risolve nella cooptazione occasionale di ragazzotti, portaborse o anche imprenditori politicamente eccentrici da esibire in campagna elettorale e congedare il giorno dopo in quanto politicamente inutili. Tale cosmesi rappresenta l’esatto contrario, una scorciatoia e una copertura per l’inamovibilità di un ceto politico che, pur di sopravvivere personalmente e politicamente, non si fa scrupolo di mettere nel conto la sconfitta comune del centrosinistra.
Il nodo cruciale è l’ermetica chiusura dei partiti. Torna d’attualità la formula, che non può essere sbrigativamente liquidata come qualunquista perché è vicina alla verità, della «partitocrazia senza partiti». Nessuno più presta credito alla loro declamata disponibilità all’autoriforma. Forse, come ammoniva l’ultimo Scoppola, è tempo di mettere in cantiere una legge sui partiti di iniziativa popolare, in attuazione dell’art. 49 della Costituzione e, segnatamente, del metodo democratico che esso prescrive relativamente alla loro vita interna.
Ma questo è tema troppo impegnativo sul quale merita tornare. E che l’associazione «Città dell’uomo» ha già messo in agenda.