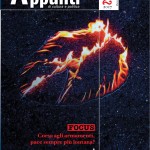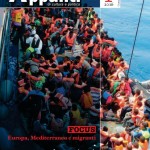Appunti 6_2008
L’economia della produzione e l’economia dei castelli di sabbia
› Roberto Schiattarella
Ormai si parla apertamente di crisi epocale, di necessità di un cambiamento nel paradigma culturale che negli ultimi trenta anni ha regolato i rapporti tra Stato e mercato, tra pubblico e privato in economia. Capire l’origine della crisi non basta, non basta chiedersi come mai le leggi siano andate sistematicamente a permettere operazioni sempre più spregiudicate, gli organi di vigilanza abbiano vigilato a rovescio, tutelando i fornitori di servizi finanziari a danno dei risparmiatori, come mai i governi siano intervenuti con almeno un anno di ritardo; ora è necessario ripensare alla politica, a quale economia vogliamo a sostegno di quale società.
L’origine della crisi
Definire con chiarezza il punto di partenza dell’attuale situazione economica è molto importante. La crisi non è di natura finanziaria. La sua origine va ricercata invece in problemi che hanno a che fare con il modo in cui la crescita si è realizzata in tutto il mondo occidentale, ma soprattutto negli Usa. Ha a che fare, in particolare, con i cambiamenti che si sono realizzati nella distribuzione del reddito a partire dagli anni Ottanta; cambiamenti che hanno comportato un forte peggioramento della posizione relativa di quelli che in genere vengono chiamati «ceti medi».
I recentissimi studi dell’Ocse ci dicono che il fenomeno non ha riguardato solo gli Usa, ma è indubbio che è in questo paese che le contraddizioni legate alla distribuzione del reddito hanno portato ad una situazione che in questo momento appare ingovernabile. Per la verità, a lungo il tessuto sociale statunitense è sembrato tenere, sia pure per il concorso di situazioni assolutamente particolari. La liberalizzazione dei movimenti di capitali ha infatti determinato un forte afflusso di capitali verso quello che era ed è il centro del sistema finanziario internazionale. Questo afflusso ha portato, tra l’altro, ad un forte apprezzamento dei valori di borsa aumentando in maniera significativa (la crescita è stata di sei volte in 7-8 anni) il valore dei titoli azionari posseduti dalle famiglie (ovviamente dei ceti medio alti).
In questo modo, in pratica per tutti gli anni Novanta, una gran parte della società Usa è riuscita a partecipare al miglioramento del benessere generale, nonostante che la crescita del reddito vero e proprio si concentrasse quasi tutta nel venti per cento più ricco delle famiglie.
Quando all’inizio degli anni Duemila la borsa negli Usa ha esaurito la sua fase espansiva, e quindi di sostegno del reddito dei ceti medi, cioè nei mesi immediatamente precedenti e successivi alle «torri gemelle», è iniziata la crescita del mercato immobiliare (i prezzi si sono moltiplicati di tre-quattro volte nel giro di pochi anni). Anche in questo caso, quello che si è determinato è stato il cosiddetto «effetto ricchezza», come gli economisti chiamano l’aumento della spesa da parte delle famiglie legato ad un miglioramento delle condizioni patrimoniali. Con una differenza rispetto al decennio precedente e cioè che l’aumento del valore degli immobili non è altrettanto facilmente monetizzabile rispetto a quello che si può realizzare con le azioni.
Il risultato è stato un crescente indebitamento delle famiglie per finanziare la spesa corrente; sia quelle che hanno pensato di riuscire a guadagnare attraverso l’acquisto della casa, sia quelle che si son fatte prestare soldi per rendere liquidi i guadagni ottenuti attraverso l’aumento dei prezzi degli immobili.
La crisi dei ceti medi si trasforma in crisi finanziaria
La rapida crescita del fenomeno ed il progressivo coinvolgimento di gruppi sociali sempre più ampi ha reso questo meccanismo di crescita della domanda negli Usa assolutamente non sostenibile nel lungo periodo. Non sorprende dunque che fosse opinione diffusa tra gli economisti di formazione macroeconomica che un simile meccanismo avrebbe innescato col tempo una crisi di grandi dimensioni. I limiti sono diventati ancora più evidenti quando si è capito che l’espansione dell’indebitamento delle famiglie non trovava più il suo vincolo naturale nella credibilità finanziaria del debitore.
L’esistenza di prestiti fatta a soggetti difficilmente solvibili era nota a tutti attraverso il sistema di rating. Il nuovo sistema di garanzia sembrava essere divenuto quello del passaggio di mano di questi crediti ad altri intermediari finanziari che a loro volta li rivendevano in una qualche forma. La percezione del rischio implicito era poi resa minima dal fatto che spesso questi stessi titoli finivano con l’essere garantiti da una qualche istituzione finanziaria terza. In sostanza, si è creata una sorta di convinzione diffusa che il meccanismo di salvaguardia fosse diventato quello di diluire i rischi fino al punto da poterli far diventare in qualche modo assicurabili. In altre parole, gli operatori dei mercati finanziari non hanno colto la dimensione sistemica che in questo modo davano al problema dell’insolvenza di una parte delle famiglie americane.
I processi cumulativi
Una volta che questo meccanismo, che ha funzionato in modo virtuoso per quasi quindici anni, ha raggiunto il suo punto di non ritorno, i processi che si sono attivati hanno moltiplicato i problemi. Molte famiglie, nell’impossibilità di pagare le rate dei prestiti, sono state costrette a vendere gli immobili. Con la conseguenza di una diminuzione nel prezzo degli stessi, ma anche del valore delle garanzie dei prestiti fatti ad altre famiglie. Facendo emergere in questo modo nuove situazioni di potenziale insolvenza, e determinando una nuova spinta alla vendita degli immobili posti a garanzia dei prestiti concessi dalle banche. Il tutto in una spirale che ha moltiplicato il numero dei debitori insolventi e abbassato in maniera significativa il valore degli immobili. Il sistema bancario Usa si è venuto a trovare in questo modo stretto tra una crescita dei problemi di insolvenza delle famiglie ed una crescente presenza nei propri portafogli di titoli di dubbia esigibilità (per non parlare dei vincoli che derivano dai deficit crescenti del bilancio dello Stato e di bilancia dei pagamenti) e non ha retto.
La dimensione internazionale
Il problema si manifesta negli Usa in maniera assolutamente evidente ma tracce delle stesse contraddizioni si possono cogliere anche in quasi tutti i paesi industriali avanzati. Per quel che riguarda la distribuzione del reddito, sono concordi le indicazioni che segnalano un allargamento dei divari di reddito in tutti i paesi avanzati negli ultimi venti anni. Proprio in questi giorni uno studio dell’Ocse ci segnala che in Italia la divaricazione dei redditi ha assunto una dimensione particolarmente consistente. Risultato forse non sorprendente di una crescita economica che, a partire dagli anni Novanta, è stata tutta centrata sul mercato. Il mercato, spesso può garantire lo sviluppo, mai l’equità.
D’altra parte questi cambiamenti nella distribuzione del reddito hanno generato comportamenti delle famiglie europee differenti rispetto a quelli che si sono avuti negli Usa. È vero che anche in Europa si è assistito ad una espansione del credito al consumo; ma è altrettanto vero che questo indebitamento non ha mai raggiunto i livelli degli Usa. Questo non ha tuttavia impedito al sistema bancario europeo di essere pienamente coinvolto dalla crisi americana. La forte integrazione dei mercati finanziari ha infatti favorito da un lato la diffusione dei titoli spazzatura e, dall’altro, il rapido propagarsi della crisi di fiducia dal centro alla periferia del sistema economico internazionale. È ragionevole pensare che paesi come la Cina o l’India subiranno conseguenze meno gravi dalla crisi, ma sperare che questi paesi facciano da traino alla domanda mondiale è assolutamente fuori luogo. Il loro peso sulla domanda mondiale è attualmente trascurabile (poco più del due per cento per la Cina).
La crisi finanziaria vera e propria
Anche se il punto di partenza della crisi è espressione di contraddizioni legate alla distribuzione del reddito ed al modo in cui i ceti medi hanno finanziato la loro domanda negli Usa, il trasformarsi della crisi in crisi finanziaria dà luogo a due altre conseguenze.
Da un lato moltiplica ed accentua i problemi di domanda negli Usa e, dall’altro, come si è appena detto, finisce col coinvolgere l’intero sistema internazionale. La crisi finanziaria asiatica, o le altre crisi finanziarie locali avevano interessato la periferia del sistema economico. Ed era stato possibile isolarne gli effetti. La nuova crisi nasce al centro e non può che diffondersi su tutto il sistema internazionale proprio perché mette in discussione il pilastro su cui si regge qualunque sistema finanziario, la fiducia. Nessun sistema finanziario e nessuna moneta può sopravvivere alla mancanza di fiducia. Da un certo punto di vista, anzi, si può dire che la perdita di fiducia è in qualche modo l’elemento che identifica una crisi finanziaria.
Questo è il motivo per cui tutte le autorità pubbliche hanno sentito il bisogno di intervenire. Certo se lo avessero fatto nell’agosto del 2007 quando ormai i termini della crisi erano evidenti, i costi dell’intervento sarebbero stati minori, ma occorre dire che far diventare pubblica una parte importante del sistema finanziario (dopo aver per anni parlato dello Stato come il soggetto che crea i problemi e non come quello che li risolve) era una politica difficile da farsi per il governo più ostile alla presenza dello Stato in economia dopo quello Reagan.
Nel breve periodo gli interventi hanno indubbiamente funzionato, soprattutto per il loro valore di annuncio. Non si sono scatenate le possibili situazioni di panico tra i risparmiatori. Il problema è ora quello di riuscire a mantenere nel tempo un livello di fiducia adeguato. Operazione non semplice in una situazione in cui permangono ed anzi diventano sempre più chiari i problemi reali che possono mettere in discussione la credibilità della finanza. Il primo è costituito evidentemente dalla scarsa trasparenza dei mercati che è emersa col tempo in tutta la sua evidenza. Se tra gli economisti era diffusa la coscienza dei limiti di un certo tipo di sviluppo e delle probabili conseguenze sui sistemi finanziari, i mercati sembrano essere stati quasi sorpresi da quanto stava accadendo, e, in ogni caso, sicuramente lo sono state le famiglie. Sorpresa che è a sua volta sorprendente perché, come detto, era noto a tutti il fatto che una parte dei crediti verso le famiglie Usa era inesigibile, e soprattutto che su questi crediti erano state costruite delle vere e proprie piramidi di titoli che erano ormai presenti nei portafogli di cittadini ed istituzioni di tutto il mondo.
Il fatto che le stesse autorità di politica monetaria dei più importanti paesi al mondo non siano state in grado di ricostruire un quadro meno indefinito della dimensione del valore dei titoli diventati inesigibili certo ci dà una dimensione meno approssimativa del grado di rischio di chi vuol ancora operare sui mercati finanziari. La considerazione che tutti i sistemi di garanzia si siano dimostrati del tutto inadeguati, quando non truffaldini, non ha certo contribuito ad aumentare la fiducia nei mercati finanziari.
La prima conseguenza di questa assoluta mancanza di trasparenza è stata che il confine tra titoli esigibili (e che possono essere considerati titoli sicuri) e non esigibili (non sicuri) é diventato tanto incerto che ha finito col coincidere con la divisione tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Questo vuol dire, in altre parole, che nella percezione dei risparmiatori è l’intero comparto dei titoli privati o non garantiti dal pubblico che viene considerato inaffidabile. È vero che si è annunciato che i cosiddetti titoli spazzatura saranno comprati dall’operatore pubblico. Ma come può essere credibile questo particolare annuncio quando è evidente a tutti che nessuno sa cosa questo impegno significhi in termini di risorse che gli Stati devono mettere a disposizione? Quanto costerà, in altre parole, ai diversi stati nazionali, e quindi ai loro cittadini attraverso la fiscalità, l’operazione di salvataggio del sistema finanziario.
È invece molto più facile da intuire il fatto che è estremamente poco probabile che il sistema pubblico riesca a farsi carico delle possibili perdite sui titoli a rischio intervenendo come acquirente di ultima istanza. Questa parte della crisi finanziaria non è ancora emersa perché per una parte dei titoli il mercato è sostanzialmente congelato. Ma presto o tardi si formerà un prezzo per questi titoli e solo allora si potrà capire la dimensione della distruzione di ricchezza determinata dalla crisi finanziaria. Non si fa molta fatica tuttavia a pensare che, al di là dei fattori psicologici, ed al di là delle considerazioni fatte in precedenza, che indubbiamente faranno prevalere l’offerta di titoli sulla domanda, esiste almeno un’altra ragione estremamente convincente che non può che scoraggiare coloro che volessero mantenere i propri risparmi in attività finanziarie.
Ora se è indubbio che un sistema finanziario che non gode più della fiducia del pubblico è morto e che per risorgere ha bisogno di regole talmente nuove da poter riconquistare la fiducia dei mercati, è altrettanto indubbio che in questa fase è molto difficile prevedere in che direzione andrà il cambiamento. Sugli interventi immediati il consenso non poteva che essere abbastanza forte. Su come costruire i nuovi mercati finanziari, invece, le idee possono essere le più svariate. Anche perché i costi degli interventi si distribuiscono in maniera diseguale tra i paesi e gli interessi potrebbero diventare divaricanti.
E dunque è ragionevole supporre che occorrerà del tempo perché si delinei una via di uscita condivisa, ammesso che ci si riesca. E in tutto questo tempo prevarranno condizioni di incertezza. E visto che, a seconda delle scelte che si faranno, i costi per i possessori di titoli potrebbero essere molto diversi, è ragionevole ipotizzare che vi sarà una spinta molto forte a livello internazionale ad abbandonare i titoli a rischio.
Per riassumere, è ragionevole supporre che i prezzi dei titoli saranno tenuti bassi a) dal fatto che è attualmente difficile distinguere tra titoli spazzatura e non; b) dalla incertezza (che non sarà di breve durata) circa le linee su cui si ricostruiranno i mercati finanziari; c) dal fatto che è poco probabile che l’intervento dello Stato possa assumere la forma di acquirente di ultima istanza dei titoli in vendita. Si deve dunque mettere in conto che le perdita di ricchezza da parte delle famiglie e delle istituzioni che sono in possesso di questi titoli non saranno marginali.
Gli effetti reali della crisi finanziaria
Dopo un primo momento in cui alcuni leaders politici hanno tentato di nascondere il fatto (o non hanno capito) che quella che oggi appare soprattutto come crisi finanziaria avrebbe avuto effetti non marginali sull’intero sistema economico internazionale, ormai anche sui giornali si è diffusa la coscienza delle implicazioni sull’economia reale dell’attuale situazione di crisi.
C’è in primo luogo un effetto diretto su imprese e famiglie legato alla distruzione di ricchezza (finanziaria) che la crisi ha determinato e — crediamo — determinerà. La contrazione del valore dei patrimoni (anche quelli reali, per effetto di un abbassamento nei prezzi) ridurrà indubbiamente la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese.
Emblematico a questo proposito è quello che con ogni probabilità accadrà alle pensioni nei sistemi previdenziali privati. Quello che resterà del risparmio previdenziale privato è molto difficile che riesca a garantire un reddito adeguato ai sottoscrittori. Non si deve dimenticare a questo proposito che in un contesto recessivo anche i corsi dei titoli azionari tendono a ridimensionarsi in maniera drastica, come infatti sta succedendo. Se si pensa che negli Usa i fondi pensione sono la principale forma di sostegno economico delle persone che vanno in pensione, si può comprendere l’entità dei problemi che si porranno in quel paese. E la ridurrà anche indirettamente perché diminuirà la loro capacità di accedere al credito per effetto della diminuzione del valore delle garanzie reali.
Ci sono poi gli effetti sui comportamenti degli agenti economici. L’incertezza renderà prudenti sia le imprese nei loro piani di investimento e nelle politiche di costo, sia le famiglie che probabilmente ridurranno i consumi. In sostanza, la crisi finanziaria determinerà un insieme di effetti che purtroppo vanno tutti nella direzione di una contrazione della domanda da parte sia delle famiglie che delle imprese. Tendenza questa che non riguarderà solo gli Stati Uniti ma coinvolgerà l’intero sistema economico internazionale.
Il ruolo dello Stato
La conseguenza di questo stato di cose sarà l’emergere di un eccesso di capacità produttiva a livello internazionale che a sua volta comporterà un’accentuazione della concorrenza sui mercati internazionali per contendersi una domanda residua. Molte imprese entreranno in difficoltà e si renderà con ogni probabilità necessaria una riorganizzazione dei sistemi industriali di tutti i paesi, costosa sul piano economico e sociale.
Per le famiglie i problemi saranno ancora maggiori. In una situazione di distribuzione del reddito già particolarmente sfavorevole, le famiglie si troveranno a confrontarsi con un maggior rischio di disoccupazione e con un futuro pensionistico incerto (in alcuni paesi, come gli Usa); con una accentuazione della pressione fiscale determinata dal fatto che l’intervento pubblico sarà una delle forme di superamento della crisi nel breve periodo. Anche con politiche di bilancio molto meno austere di quelle seguite fino ad ora.
Allo Stato sarà richiesto contemporaneamente di sostenere il sistema finanziario (e in misura possibilmente consistente) almeno fino al momento in cui si riuscirà a trovare un accordo internazionale su come costruire un nuovo sistema finanziario. Di sostenere le imprese che entreranno in difficoltà per effetto del calo della domanda e di aiutarle nei loro processi di riorganizzazione. Di sostenere le famiglie che si troveranno schiacciate da una distribuzione del reddito che le ha penalizzate negli anni Novanta e Duemila, dalle perdite finanziarie, dall’aumento del rischio di disoccupazione, dall’aumento del rischio sulle pensioni (in alcuni paesi), e dalla riluttanza delle imprese a fare concessioni sul piano salariale. Il tutto in un contesto istituzionale reso difficile dall’esistenza di banche centrali (in particolare quella europea) cui è assegnato il compito di controllare l’inflazione e che quindi dovrebbero intervenire restringendo il credito in una fase di espansione delle politiche di spesa pubblica.
Le vie di uscita dalla crisi
Qui ovviamente le opinioni possono divergere anche in funzione della diversità culturali o di interessi. Ma su alcuni punti non può non esserci convergenza. Il primo, e forse più importante, è che la situazione è diventata così complessa che tutte le parti in causa dovranno rendersi conto che è necessario andare al di là del proprio specifico interesse di breve periodo. Il secondo è che dalla crisi si uscirà solo quando verranno meno le condizioni che l’hanno determinata. In primo luogo quando si potrà considerare superata la questione della distribuzione del reddito negli Usa (aggravata dagli effetti della crisi finanziaria). Senza una forte ripresa della domanda proveniente dai ceti medi in Usa è difficile pensare di poter uscire dalla crisi. E non si sta parlando di interventi di breve periodo quali l’abbassamento del tasso di interesse. Occorre ricordare a) che la domanda degli Usa è pari al 20 per cento della domanda complessiva; b) che negli anni Novanta e Duemila i ceti medi hanno mantenuto elevati livelli di spesa solo attraverso il ricorso all’indebitamento; c) che non solo il ricorso all’indebitamento per queste famiglie non è più possibile ma che è necessario che queste stesse famiglie facciano fronte ai debiti accumulati. Questo per quel che riguarda il centro del sistema economico.
Per quel che riguarda la periferia i margini della politica non sembrano essere molto più ampi. Quello che è certo è che in questi paesi, in ogni caso, sarà compito della politica ripensare ad un tipo di sviluppo diverso, capace di coinvolgere maggiormente i gruppi sociali penalizzati in passato e capace contemporaneamente di rendere più stabili le condizioni di crescita. È possibile che esistano molte strade, ugualmente legittime, capaci di dare una risposta ai problemi che si stanno ponendo. Una ce la suggerisce l’esperienza che viene dal passato. Keynes negli anni Trenta si é trovato di fronte a problemi non troppo diversi dagli attuali ed ha potuto sperimentare quanto sia difficile portare avanti politiche di redistribuzione del reddito ma anche come queste politiche portino a risultati più che soddisfacenti in un arco di tempo non lungo. Negli Stati Uniti la politica di sostegno della domanda ha avuto tanto successo da determinare, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta e fino a tutti gli anni Quaranta, un processo di sviluppo assolutamente impressionante.
Ragionevolmente altre politiche possono raggiungere questi risultati. Ma non si deve dimenticare che se queste scelte saranno il frutto di società più rigide sia dal punto di vista della elaborazione politica che da quello degli interessi economici come l’Italia del ventennio, il percorso finirà con l’essere molto più accidentato. Non ci si deve dimenticare che in Italia si sono dovuti aspettare due decenni perché un processo di sviluppo come quello realizzato negli Usa si avviasse e trasformasse il nostro paese.
I tempi
I tempi sono quelli della politica. E quindi non si può essere certi che saranno quelli richiesti dalla gravità del momento attuale e di quelli che vivremo nei prossimi mesi ed anni. Non può non far riflettere il fatto che si è perso un anno intero perché il governo Usa prendesse provvedimenti che apparivano a molti come immediatamente necessari. È vero che questo ritardo ha reso la situazione talmente drammatica che le obiezioni alla strategia di intervento adottata dal governo Usa sono state marginali, anche se si trattava di una politica che ribaltava tutta la filosofia intorno alla quale era stato costruito il rapporto tra Stato e mercato nei due decenni precedenti. Ed è altrettanto vero che alla fine il governo più ottusamente liberista si è trovato a fare l’intervento più «statalista» (un termine che da solo fa emergere chiaramente il giudizio di valore sottostante) della storia degli Usa.
Non c’è alcun dubbio che si è ad un punto di svolta epocale, come negli anni Trenta e come all’inizio degli anni Ottanta. Il modo di funzionare e di organizzarsi del sistema economico di domani sarà diverso da quello del passato.
In un momento di questo tipo è forte la speranza che non saranno gli elevati costi sociali, pagati dai singoli sistemi nazionali, a rendere più rapide le risposte che la politica sarà costretta a dare. Bisogna evitare che si arrivi alla tragedia perché si riescano a trovare le energie per avviarci su nuove strade.
La speranza è che negli Stati Uniti, dove i problemi si pongono con maggiore urgenza (si pensi in primo luogo alla necessità di sostegno del sistema pensionistico), si metta in moto un processo relativamente rapido di riforme che possa costituire un punto di riferimento capace di aggregare consenso e rendere più agevole il superamento dei problemi che si porranno all’interno dei singoli paesi. Problemi legati al fatto che il ripensamento (se non l’abbandono) di paradigmi culturali consolidati nel corso di oltre venti anni (anche nel «senso comune») non può che essere molto faticoso, e al fatto che gli interessi particolari, soprattutto in Italia, hanno sempre avuto una forte capacità di resistenza.