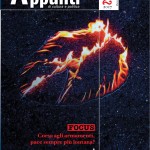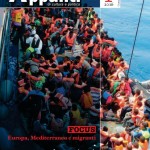Appunti 6_2008
Quando i maestri ci lasciano…
› Luciano Caimi
La riflessione sulla scomparsa recente di alcuni maestri della cultura e dell’esperienza cattolico-democratica, propone una rinnovata decisione a condurre avanti una testimonianza di parresia e onestà intellettuale, ciascuno nelle proprie condizioni e con i propri carismi.
Nel giro di un anno ci hanno lasciato alcuni cari amici e maestri. Mi riferisco in particolare a Pietro Scoppola (25 ottobre 2007), Achille Ardigò (10 settembre 2008), Leopoldo Elia (5 ottobre 2008).
Diversi per sensibilità, competenza scientifica, percorsi di vita, hanno nondimeno testimoniato una convergente tensione nella costante ricerca di una sintesi o, per meglio dire, di punti d’intesa «sostenibili» fra valori cristiani e dimensione civico-politica. Ognuno a modo suo e con accenti specifici ha dato linfa al filone di pensiero e di presenza cattolico-democratica. Da loro viene la conferma di una lezione imperniata sulla fedeltà ai principi e ai valori costituzionali, in difesa della laicità delle istituzioni e della politica, con il programmatico intento di favorire partecipazione, dialogo fra le varie componenti sociali, opportunità d’inclusione nei processi di nuova cittadinanza.
Scoppola, Ardigò, Elia sono stati interpreti, ciascuno con personale originalità, della figura di cristiano laico «adulto», additataci dal concilio. Uomini responsabilmente partecipi della vita e della missione della Chiesa, ma anche custodi gelosi della loro interiore libertà e sempre attenti all’evangelica distinzione fra «Dio» e «Cesare», «trono» e «altare». Pur nella diversità degli stili, non ha mai fatto difetto in loro l’attitudine alla parresia, quel parlare franco, dentro e fuori della comunità ecclesiale, che anche Gesù suggerisce, quando invita i discepoli ad essere persone di una «sola» parola: «sì, sì», «no, no».
La scomparsa di questi amici e maestri in un arco temporale così ravvicinato ci trova un po’ più soli. Avvertiamo la mancanza del loro magistero sapiente nell’attuale, difficile fase della storia italiana, dove la complessità dei problemi politico-istituzionali e socio-culturali sul tappeto richiederebbe un sovrappiù di lungimiranza riflessiva e di coraggio operativo da parte degli stessi cattolici. Certo, a questo proposito, anche negli ultimi tempi non sono mancate importanti occasioni e sollecitazioni (penso al Convegno ecclesiale di Verona, 2006, alla 45ª Settimana sociale di Pistoia-Pisa, 2007). Però l’impressione è che una volta celebrati simili eventi di richiamo si rientri subito in una routine priva di slanci creativi. Oltretutto, troppi cattolici sembrano preda di un processo di anestetizzazione, che li induce a un’acquiescenza sull’esistente, non facendo mistero, fra l’altro, di sentirsi, con l’attuale assetto governativo, meglio tutelati nella difesa dei valori e degli interessi che più stanno a cuore.
… la responsabilità di continuare a testimoniare
Vi è nel paese e in larghi strati del cattolicesimo nazionale un deficit di coscienza critica, che non di rado si accompagna a una scarsa capacità di pensare realmente in termini di bene comune, preferendo invece insistere sulla difesa del proprio particulare. La sindrome anestetizzante di cui dicevo sembra avere spento in molti anche un legittimo spirito d’indignazione e di resistenza verso quanto intacca la sostanza della vita democratica: si pensi, per esempio, ai diversi tentativi di stravolgere la carta costituzionale, ai conflitti d’interessi politico-economici, alle leggi ad personam, al continuo ricorso alla decretazione d’urgenza.
Dico questo proprio perché sul tema della costituzione, sulla democrazia, sul senso delle istituzioni, sulle regole di una convivenza civile rispettosa dei diritti e dei doveri di ciascun cittadino, sugli stili propri del credente in rapporto alla vita politica, sociale, professionale la lezione degli amici e maestri citati si conferma in tutta la sua rilevanza.
A noi, che siamo rimasti, tocca raccoglierne gli insegnamenti, con la responsabile consapevolezza di doverli non tanto «ripetere», ma «svolgere» dinamicamente, misurandoci giorno dopo giorno con i nuovi problemi. I maestri ci sono donati per aiutarci a individuare la strada, poi compete a ciascuno di percorrerla con la propria sensibilità e libertà. Dunque, non «ripetizione» meccanica di quanto appreso, ma «svolgimento» creativo. I veri maestri, del resto, hanno sempre interpretato così il cammino dei loro allievi.
«Città dell’uomo», che ebbe fra i firmatari dell’atto costitutivo (4 ottobre 1985) Leopoldo Elia, nel corso dei suoi ventitré anni di vita ha avuto più occasioni per condividere con lui e con gli altri amici scomparsi esperienze istruttive di ricerca e confronto politico-culturale. Il ricordo, affettuoso e grato, di ciascuno di loro è perciò ben vivo nell’associazione, così come l’insegnamento offertoci con singolare intelligenza e passione.
Siamo pertanto persuasi di dover proseguire lungo la strada da essi battuta, raccogliendone, in qualche modo, il testimone. Nella scia del loro magistero, «Città dell’uomo» e la rivista «Appunti» intendono allora concorrere allo sviluppo di una cultura politica irrorata da tensione etica, responsabilità civile e senso della laicità, in una prospettiva aperta ai grandi temi della giustizia, della democrazia, della pace, dei diritti di cittadinanza, con particolare attenzione ai bisogni dei ceti più poveri. Su queste frontiere si gioca, del resto, il futuro dell’Italia, dell’Europa e del mondo intero. Vogliamo, al riguardo, continuare a offrire il nostro contributo, con riflessioni e proposte, che devono non poco anche all’eredità intellettuale e morale degli amici e maestri ricordati.