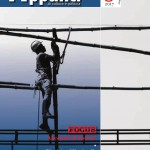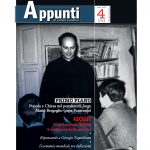Appunti 5_2008
Una crisi che viene da lontano
› Marco Mazzoli
Il panico finanziario delle ultime settimane appare un passaggio delicatissimo e decisivo. Crisi ciclica tipica dell’economia finanziarizzata, frutto dello scoppio della bolla speculativa dell’immobiliaristica statunitense, è forse per gravità e ampiezza, da cogliere come segnale di un passaggio più radicale. Vengono al pettine i nodi della soluzione politica data in Occidente alla crisi degli anni Settanta. Occorre ragionare a fondo sui rimedi e sulla necessità di ripartire da regole profondamente rinnovate con un percorso di ripensamento dei rapporti economia-politica.
Negli anni Sessanta, in piena epoca keynesiana, nell’età dell’oro del capitalismo «regolato», un top manager di una grande impresa americana poteva guadagnare fino a 20 volte lo stipendio di un operaio. Alla vigilia dell’attuale crisi finanziaria, un top manager di una grande banca d’affari o di una grande società finanziaria (anche una di quelle salvate dall’intervento pubblico) poteva arrivare a guadagnare anche 300 volte lo stipendio di un operaio statunitense. Nel frattempo, il Welfare state è stato pesantemente ridotto, la sanità statunitense interamente privatizzata, e, secondo il parere di molti ideologi dell’ultra-liberismo da osteria nostrano, la nostra sanità pubblica avrebbe dovuto seguire lo stesso destino.
Tutto questo prima della crisi finanziaria internazionale. Già… la crisi finanziaria. La sua gravità è data dal fatto che si è manifestata in una fase già di per sé difficile per l’economia dei paesi occidentali, a causa delle forti tensioni politiche internazionali, dell’alto costo delle fonti di energia e del petrolio e a causa del fatto che i confini e le dimensioni del rischio sono, a tutt’oggi, ignote agli operatori: nessuno sa infatti esattamente quale sia l’ammontare complessivo dei mutui e dei titoli fasulli attualmente in circolazione, né si conosce esattamente quali, tra le grandi banche, assicurazioni ed istituzioni finanziarie siano maggiormente esposte al rischio.
Una fase di grande incertezza
Tutto questo genera una drammatica situazione di forte incertezza: le banche non osano prestare, gli investitori non osano investire e le drastiche e salutari immissioni di moneta sui mercati (effettuate dalla Federal Reserve e dalla Bce) per scongiurare il tracollo del sistema, pur riuscendo per il momento ad arginare parzialmente la crisi, generano un aumento solo limitato di circolazione della liquidità, che tende invece ad essere trattenuta e tesaurizzata da operatori finanziari spaventati. In questa situazione (che ricorda la cosiddetta «trappola della liquidità» di keynesiana memoria) il premio Nobel Joseph Stiglitz ha proclamato pubblicamente la fine dell’era del capitalismo senza regole e l’inizio di una fase di capitalismo «regolato», in cui lo Stato deve tornare a giocare un ruolo di supervisore del sistema e i mercati devono essere regolati.
Questa « nuova fase» si apre comunque con l’ennesima redistribuzione di ricchezza a danno dei ceti più poveri e a vantaggio dei ceti più ricchi: le perdite immense causate da manager e affaristi senza scrupoli (e arricchitisi in anni di speculazioni senza limite) saranno scaricate, con le nazionalizzazioni, sull’erario statunitense, mentre le eventuali compensazioni a favore delle famiglie «scottate» sono cosa assai aleatoria.
La crisi dei mutui americani ha tragicamente mostrato la pericolosità e l’assenza di scrupoli di un certo modo aggressivo e competitivo di fare affari nel mondo bancario e finanziario, l’inaffidabilità dei dispositivi di controllo e vigilanza del settore bancario statunitense ed internazionale e l’assenza di governance nei mercati finanziari mondiali, soggetti periodicamente a traumatiche crisi di cadenza decennale: dopo il crollo di Wall Street del 1987, abbiamo assistito alla cosiddetta crisi asiatica del 1997, a quella «russa» del 1998 e a quella attuale, la più grave di tutte.
In generale queste crisi sono precedute da fasi di «euforia irrazionale» (per usare le parole dell’ex presidente della Fed Alan Greenspan), in cui i prezzi dei titoli azionari mostrano trend di crescita spropositati ed eccessivamente ottimistici rispetto agli indicatori dell’economia reale e in cui investitori eccessivamente ottimisti ed inesperti vengono attirati sui mercati dalla speranza di lauti guadagni, prima di essere scottati dalle successive crisi.
Le teorie economiche e le pratiche manageriali, spesso presentate all’uomo con la granitica (quanto usurpata) pretesa di scientificità, hanno offerto alle lobbies finanziarie internazionali le argomentazioni ideologiche per indebolire e svuotare il Welfare state, diffondere in ogni paese il precariato tra i giovani lavoratori, rimuovere ogni forma di controllo sui mercati finanziari internazionali e arrivare all’attuale regime di globalizzazione in cui gli speculatori finanziari internazionali sono più forti di molti governi sovrani. Se veramente sta nascendo un «nuovo capitalismo regolato» e se veramente stiamo tornando ad una nuova (limitata) forma di intervento pubblico, questo deve essere fatto in modo trasparente, chiarendo bene chi paga e chi si avvantaggia da queste forme di intervento, che non devono servire solo a coprire gli errori di alcuni manager disonesti e a garantire loro l’impunità.
Le responsabilità storiche
Credo che non occorra perdere la memoria storica e non stancarsi mai di ripetere e ricordare chi ha la responsabilità politica dell’attuale quadro internazionale. Cominciamo dalle tensioni politiche. Non bisogna mai stancarsi di ripetere che Bin Laden è stato «creato» dai finanziamenti americani, al tempo di Reagan (che lo preferì al più «laico» Massud al tempo della lotta contro l’invasione sovietica dell’Afghanistan), dal sostegno politico e logistico della Cia, fino alla prima guerra dell’Iraq.
Non bisogna mai stancarsi di ripetere e di ricordare che Saddam Hussein è stato lungamente finanziato dagli Stati Uniti al tempo della guerra con l’Iran, secondo la logica spregiudicata e guerrafondaia del pensiero «neocon», che a tutto antepone l’uso della forza e delle armi per conseguire i propri obiettivi (riassumibili negli interessi di alcune lobbies finanziarie militari e petrolifere). Forse giova ricordare che persino un presidente conservatore come Eisenhower mise in guardia da quello che chiamava «l’apparato militare-industriale» americano, in grado di influenzare, o addirittura (come temeva lui per il futuro) determinare, le scelte politiche della più grande potenza economica e militare del pianeta.
Un altro elemento molto importante è che il potere economico è concentrato in pochissime mani e sfugge di fatto al controllo democratico delle opinioni pubbliche, così come sfugge interamente al controllo democratico dell’opinione pubblica e a qualsiasi regola (e sanzione), che garantisca la correttezza dei contenuti, l’informazione mediatica dei grandi circuiti televisivi internazionali. Nel sistema politico bipolare maggioritario di stampo anglosassone (che caratterizza ormai molti paesi occidentali) l’altissimo costo di accesso ai media televisivi garantisce visibilità pubblica solo alle forze politiche finanziate da grandi lobbies. Non a caso, il grande filosofo liberale Popper, in un recente e coraggioso intervento, ha affermato che solo una Tv pubblica, che offra spazio e pari trattamento per tutte le idee, possa garantire la democrazia.
Due anni fa un quotidiano italiano («La Repubblica», venerdì 18 agosto 2006) pubblicava in prima pagina un articolo in cui il premio Nobel Joseph Stiglitz rilevava come ormai nessuno, neppure tra gli economisti ortodossi, creda più alla promessa di sviluppo e benessere per i paesi più poveri associato alla maggiore apertura commerciale verso l’estero: l’idea con cui nacque nel 1948 il Gatt e, sulle sue ceneri, nel 1995 il Wto, l’Organizzazione del commercio mondiale, a cui aderiscono oggi 149 paesi.
Stiglitz osservava come questa antica promessa liberista e capitalistica di un avvenire felice e radioso sia sostituita, nei documenti ufficiali, da più blandi auspici di ventilati vantaggi economici per i paesi che adottino le misure di liberalizzazione. Infine Stiglitz rilevava tristemente che mai come ora, nella storia del mondo, pochi gruppi di lobbies privilegiate (gli agricoltori americani ultra-sussidiati dallo Stato, alcune poche grandi multinazionali dei paesi ricchi) riescano ad imporre la loro volontà politica ad enormi masse di umanità nell’Asia, Africa, America latina.
Com’è possibile tutto questo? Per capirlo occorre ricordare che nelle istituzioni economiche internazionali il meccanismo di voto è basato su indicatori economico-finanziari: i paesi più ricchi esprimono più voti, i paesi più poveri, anche se abitati dalla grande maggioranza dell’umanità, esprimono solo una minoranza di voti.
Stabilità monetaria e mobilità sociale
Alla base di tutto il nostro sistema economico internazionale vi è (o dovrebbe esservi in teoria) il pensiero liberale e la sua dichiarata (e di per sé totalmente condivisibile ed auspicabile) ricerca della «mobilità» sociale, ossia di una situazione in cui il capitale umano e i talenti individuali vengano sfruttati appieno e anche gli individui appartenenti ai ceti sociali più poveri possano raggiungere, se capaci, i vertici della società e un elevato status sociale. Inequivocabilmente a favore della mobilità sociale sono stati i liberali europei ottocenteschi che lottavano contro l’assolutismo e il feudalesimo; i primi movimenti socialisti e socialdemocratici del novecento che lottavano per garantire ai lavoratori le opportunità che erano loro negate; i dissidenti e gli oppositori dello spietato e monolitico regime sovietico.
Inequivocabilmente contro la mobilità sociale sono state le forze restauratrici ottocentesche, i latifondisti latino-americani, nonché i dirigenti e i funzionari di partito nel regime sovietico.
Il lettore si potrà formare le proprie convinzioni su quanto portatrici di mobilità sociale siano le grandi multinazionali, le lobbies, la grande finanza mondiale… oppure anche solo i fautori della privatizzazione del sistema educativo, sul modello statunitense, dove solo poche grandi università dal costo proibitivo sono in grado di garantire un sicuro successo e avvenire ad una esigua minoranza di rampolli di famiglie ricche e ad una ancor più esigua minoranza di membri della middle class, baciati dalla benedizione delle poche borse di studio abbastanza ricche da consentire l’educazione e la vita in una delle top universities statunitensi.
Il sistema economico internazionale architettato nel 1944 a Bretton Woods per i paesi ad economia di mercato prevedeva un sistema a cambi fissi, in cui tutte le valute erano convertibili in dollari e il dollaro era l’unica valuta convertibile in oro. Esisteva dunque, sia pure indirettamente, un legame certo tra le varie valute nazionali e l’oro. Il sistema a cambi fissi (della cui stabilità era investito il Fmi, che aveva anche la funzione di fornire credito ed assistenza finanziaria per la ricostruzione postbellica e, successivamente, per i paesi in via di sviluppo) prevedeva che le svalutazioni e le oscillazioni delle monete fossero fatti episodici, di solito negoziati tra le autorità: se troppo frequenti avrebbero causato una perdita di credibilità da parte delle autorità che le promuovevano. C’era libera circolazione delle merci e delle persone e forti vincoli ai flussi internazionali di capitali, a causa del timore di instabilità finanziaria che questi potevano comportare.
La minore incertezza e maggiore stabilità dei cambi rese stabili le economie, la presenza di regole relativamente affidabili aveva permesso non solo una prodigiosa crescita economica, ma, per la prima volta nella storia dell’umanità, una sua diffusione tra tutti i ceti sociali e in tutte le regioni del mondo. Anche i paesi africani, asiatici e dell’America latina poterono raggiungere ritmi di crescita mai sperimentati e anche le famiglie più povere riuscirono, a partire dagli anni Sessanta in Europa e nel mondo, ad offrire ai loro figli un’istruzione superiore e di livello universitario.
Questo consentì, fino agli anni Settanta, una forte mobilità sociale, un benessere diffuso mai sperimentato prima e un sistema di Welfare che proteggeva le fasce più deboli e che era consentito da due elementi: tassi di crescita delle economie più alti dei tassi di interesse (cosicché la crescita delle entrate fiscali, correlate alla crescita del reddito, fosse più marcata della crescita degli interessi passivi sul debito pubblico, correlati ai tassi di interesse) e forti vincoli ai flussi finanziari: esportare capitali (legalmente) era complicato e costoso. In questo modo i tassi di interesse interni potevano divergere dai tassi di interesse medi a livello mondiale e le autorità monetarie erano completamente libere di perseguire le politiche monetarie desiderate, senza vincoli provenienti dall’estero.
Questa situazione «ideale» trovò il suo culmine negli anni Sessanta e trovava il suo fondamento teorico e scientifico nelle teorie economiche keynesiane, basate su un capitalismo «regolato» dove le brusche perturbazioni dei mercati erano mitigate dal ruolo regolatore dello Stato e da periodici interventi redistributivi per impedire il crollo della domanda (nelle fasi di recessione) dei ceti più poveri.
Ma la fase del capitalismo «dal volto umano» si interruppe bruscamente agli inizi degli anni Settanta per due fatti traumatici. A causa delle altissime e persistenti spese militari statunitensi, causate dalla prolungata guerra in Vietnam, la Federal Reserve aveva messo in circolazione una massa enorme di dollari, insostenibile e incompatibile con il sistema a cambi fissi di Bretton Woods che prevedeva la convertibilità del dollaro in oro. Di fronte a questa situazione, il giorno di ferragosto del 1971, il presidente Nixon annunciò improvvisamente la sospensione della convertibilità di dollari in oro, facendo saltare tutto il sistema a cambi fissi e determinando una forte e prolungata perturbazione nell’economia mondiale.
Due anni dopo, nel 1973, in occasione della guerra del Kippur, che vide contrapposto Israele a Siria ed Egitto, si verificò l’embargo dei paesi Opec verso l’occidente e la prima grande crisi petrolifera, che fece esplodere il prezzo del petrolio e dell’energia.
In questa situazione di turbolenza, i modelli keynesiani, fino ad allora utilizzati per attuare la politica economica, diedero «previsioni» inattendibili, come forse avrebbe fatto qualsiasi modello in un tale terremoto strutturale. Tuttavia ne seguì una critica ideologica e chiaramente «interessata» da parte del pensiero neoconservatore a tutto il pensiero keynesiano, non solo sul piano accademico, ma anche sul piano della politica economica, del Welfare state, del ruolo dello Stato e dei sistemi di protezione dei ceti più deboli.
Le politiche di Thatcher in Gran Bretagna e di Reagan negli Stati Uniti, a partire dagli anni Ottanta, portarono al graduale smantellamento dei sistemi di protezione sociale nei loro paesi (che hanno in parte resistito maggiormente nell’Europa continentale), a politiche monetarie restrittive caratterizzate da alti tassi di interesse che, facendo alzare il livello medio dei tassi di interesse a livello mondiale, hanno reso insostenibile per i governi di tutto il mondo la spesa per interessi passivi sul debito pubblico, costringendoli a drastici tagli sulla spesa sociale.
La globalizzazione dei mercati finanziari e la frammentazione dei controlli
Ma fu soprattutto la deregulation finanziaria a cambiare la faccia del mondo. Accogliendo precise istanze degli ambienti finanziari, vennero gradualmente eliminati negli Usa, in Gran Bretagna e, successivamente, in Europa (spesso da governi «socialdemocratici» o socialisti, che avevano adottato in toto politiche economiche ultra-liberiste) tutti i vincoli ai flussi internazionali di capitale.
A partire dagli anni Novanta la globalizzazione era dunque un fatto compiuto. In pochi secondi si potevano spostare da una borsa all’altra del pianeta miliardi di dollari. Il capitale era perfettamente mobile, mentre la mobilità del lavoro, anche quando legale, era comunque lenta, costosa e imperfetta. Mentre dal 1945 agli anni Ottanta le crisi finanziarie furono poco frequenti e di portata molto limitata, dall’87 a oggi (cioè dai primi ani della globalizzazione a oggi) se ne contano già quattro, catastrofiche e di dimensione planetaria.
Esiste dunque un drammatico problema di governance delle istituzioni economiche internazionali ed è opportuno domandarsi se sia lecito che la finanza conti di più del numero di esseri umani nel decidere le politiche economiche mondiali. Non esiste più il «contratto sociale», la mediazione tra le parti, poiché un ceto sociale, quello degli investitori finanziari e degli speculatori, si è sottratto alla «polis» in cui avvengono i confronti. I flussi finanziari non sono soggetti ad alcuna sovranità poiché possono spostarsi istantaneamente da un paese all’altro. Se nel primo trentennio del dopoguerra lo Stato si è reso più democratico e più partecipativo, il pensiero neoconservatore ha radicalmente modificato la sua natura: da incarnazione dell’autorità dello Stato si è trasformato in negazione del ruolo dello Stato, in assertore dello svuotamento delle funzioni dello Stato: dall’economia, ai servizi sociali, all’educazione, salvo poi recuperare (proprio in questi giorni) l’intervento dello Stato, con finalità di salvataggio e scaricando i costi sui contribuenti (in generale soggetti a reddito fisso, senza la possibilità di eludere o evadere il fisco). Le lobbies dominanti del pianeta non hanno nessuno scrupolo né alcun problema di coerenza: ecco dunque che Bush nazionalizza assicurazioni e grandi istituzioni finanziarie (prendendo atto dell’inefficienza ex post del mercato) e gli ultra liberisti del New labour nazionalizzano una banca…
In una società in cui la «nascita» sembra tornata a svolgere un ruolo essenziale, in cui l’assistenza e la tutela hanno perso i connotati etici del «dono» e della «gratuità» (tanto presenti, se ci pensiamo, nella nostra teologia cristiana), ma sembrano piuttosto subordinate all’appartenenza ad un gruppo o ad una lobby, stiamo assistendo, quasi impotenti, alla drammatica esclusione di enormi masse di persone dal meccanismo economico e dalle forme più elementari di benessere.
Una via per rimediare: trasparenza, pari opportunità, responsabilità
La nuova fase del capitalismo e del liberismo (evocate da Stiglitz e, di fatto, già messe in pratica dai paesi anglosassoni con le loro nazionalizzazioni e i loro pesanti interventi sull’economia) deve avvenire con trasparenza: non può e non deve sottrarsi al dibattito pubblico almeno in Europa e nei paesi dove ancora esiste una forma di democrazia e di accesso ai media. Non può e non deve essere a solo uso e consumo di pochi manager senza scrupoli che fino a ieri lanciavano anatemi contro ogni forma di intervento pubblico regolatore.
Su quali principi e a quali finalità deve rivolgersi? Una prima finalità, che sintetizza il principio dell’uguaglianza (liberale, ma anche cristiano e socialdemocratico) è quello della mobilità sociale, verso l’alto e verso il basso: è un principio che implica pari opportunità e uguali diritti di accesso all’educazione, ai mezzi di informazione (di qui le importanti prese di posizione di Popper sull’importanza di avere Tv pubbliche con regole precise), da attuare con principi di «incentivo-compatibilità»: laddove c’è uso di denaro pubblico ed intervento pubblico (che non va più demonizzato in nome del dio profitto e dell’ideologia neocon), si devono individuare precisi centri di responsabilità, meccanismi di monitoraggio (preferibilmente attuati con la partecipazione degli utenti) e sanzioni in caso di inefficienza o di assenteismo. Chi crede nelle politiche economiche attive e nell’importanza del ruolo regolatore e riequilibratore dello Stato non può accettare che lo Stato sia un’arma spuntata ed inefficiente: paradossalmente dovrebbe essere (solo in questo) «più thatcheriano della Thatcher»
Il resto dei propositi forse è ancora da costruire… con l’aiuto delle scienze sociali e di una nuova economia, non più ideologica, non più dogmatica, il cui linguaggio esoterico deve essere maggiormente spiegato ai cittadini: in altre parole, non possiamo più avere modelli matematici usati per finalità di politica economica (e che quindi decidono sul destino di miliardi di persone) dove, ad esempio, si ipotizza a priori che la distribuzione del reddito non ha alcun effetto sull’economia, i disoccupati, se sono tali, lo sono volontariamente e dove tutti gli individui sono identici, senza alcuna differenza (descritti con la metafora del cosiddetto agente rappresentativo) e onniscienti (cioè, impossibilitati, in media, a formulare previsioni sbagliate, in nome del principio delle cosiddette «aspettative razionali»). Sembra impossibile, ma la scienza economica e i modelli «ortodossi» di politica economica sono proprio basati su questi principi: forse solo appena un po’ più ideologici del leninismo.