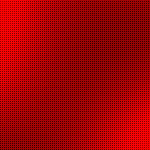Appunti 4_2008
Ai soci e agli amici di Città dell'uomo
Luciano Caimi
Milano, 5 luglio 2008
Cari amici e amiche,
mi preme raggiungervi con questa lettera intanto per comunicarvi che il 16 giugno u.s. il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha provveduto, secondo Statuto, al rinnovo delle cariche associative.
Il nuovo organigramma, per il triennio 2008-2011, risulta così definito: Presidente, il sottoscritto; Vice-presidente, prof. Eugenio Zucchetti; Segretario, dott. Vincenzo Satta; Tesoriere, prof. Sergio Parazzini.
Come potete vedere, a me è stato conferito l’incarico della presidenza. Subentro, pertanto, all’amico prof. Guido Formigoni, che per tre mandati consecutivi, con l’ausilio dei Consiglieri via via succedutisi nel corso dei nove anni, ha così bene guidato “Città dell’uomo”. A Guido (e ai suoi collaboratori) va il ringraziamento del nuovo Consiglio e mio personale per il lavoro svolto con intelligenza e passione, in fedeltà agli scopi associativi.
Dunque, tocca a me raccogliere il testimone dell’Associazione che, passo dopo passo, è ormai giunta a un’età… rispettabile: quasi 23 anni! Era il 4 ottobre 1985, giorno di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, quando, nell’ambito di un seminario su «I cristiani per la città dell’uomo», tenutosi presso il Centro Paolo VI di Milano, venne siglato l’atto costitutivo di Città dell’uomo. Con Giuseppe Lazzati, furono firmatari Leopoldo Elia, Giuseppe Glisenti, Marco Ivaldo, Ettore Massacesi, Giorgio Pastori, Luciano Pazzaglia, Luigi Franco Pizzolato, Cesare Trebeschi.
Io ero presente all’incontro. Ricordo l’atmosfera di soddisfazione e di fiduciosa speranza per il contributo che la nuova Associazione, gratificata subito da parecchie e significative adesioni, avrebbe potuto fornire in una stagione di cambiamenti sempre più accelerati ai livelli culturale, socio-politico, ecclesiale.
A distanza di così tanto tempo può essere istruttivo per noi riandare alle parole con le quali Lazzati introdusse il suddetto seminario. L’indimenticato professore così definiva fisionomia e scopo di Città dell’uomo: «un servizio culturale-politico» per «aiutare l’elaborazione, la promozione e la diffusione di una cultura politica capace di rispondere, oggi, alle esigenze di una più illuminata, creativa, partecipata presenza dei cristiani nella polis»1. «Concezione cristiana dell’uomo e del mondo», «senso della distinzione fra i valori specificamente religiosi e quelli politici», fedeltà ai «princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana con la continua attenzione a rispondere alle complesse esigenze della società in trasformazione»: dovevano essere questi gli assi portanti della nascente Associazione.
Lazzati osservava, poi, che Città dell’uomo si rivolgeva particolarmente, ma non esclusivamente, ai cattolici. D’altra parte, egli era ben consapevole del fatto che la riflessione associativa intorno ai problemi della polis si sarebbe dovuta confrontare con quelle espresse dagli esponenti dei diversi orientamenti culturali e politici presenti nel Paese. Il professore, inoltre, significativamente precisava: «si tratta di uscire da presunte ipotesi di “nuova cristianità”, di “città cristiana” più o meno palesi e perseguite in ambienti e in movimenti cristiani, naturalmente senza perdere la coscienza, anzi coltivandola, dell’apporto che “lo specifico cristiano” reca all’individuazione ed attuazione dell’autenticamente umano»2.
Dal 4 ottobre 1985… ne è passata di acqua sotto i ponti! Eppure le parole del nostro fondatore, serenamente orientatrici circa il lavoro cui avrebbe dovuto attendere l’Associazione, sono di palpitante attualità. Quanto urgente sia oggi l’esigenza di un «servizio» culturale-formativo per aiutare i cattolici, adulti e giovani, a (ben) «pensare politicamente», è sotto gli occhi di tutti.
Annoto ciò, avendo presente la complessa realtà del mondo cattolico italiano. Di esso conosciamo meriti e pregi: per esempio, la capacità di richiamare nel dibattito pubblico la rilevanza dei valori etici intorno ai gravi problemi che agitano la coscienza contemporanea; la presenza ai livelli territoriale e popolare con capillari attività di natura religioso-spirituale, culturale e di «promozione umana» (meritoria, in tal senso, l’opera delle parrocchie e quella di molteplici associazioni, movimenti, gruppi); l’iniziativa in settori strategicamente rilevanti per la crescita personale e sociale (si pensi a scuola e Università); la dedizione, espressa da numerosi «soggetti» e con varietà di forme, ai bisogni antichi e nuovi della gente, in special modo dei più deboli.
Ma, detto questo, è altresì onesto rilevare alcune questioni aperte nella «galassia» cattolica, che ne fotografano l’interna complessità e finiscono con l’interpellare, in modo più o meno diretto, anche la nostra Associazione. Rammento, a titolo esemplificativo: le considerevoli, persistenti differenze d’indirizzo teologico, ecclesiale, culturale e politico fra associazioni e movimenti di larga diffusione, causa anche di ricorrenti attriti; le crescenti spinte verso posizioni socio-politiche di centro-destra, non di rado difformi, su alcuni aspetti della vita sociale (pensiamo a giustizia, lavoro, legalità, immigrazione, pace, sottosviluppo…), dagli insegnamenti del Magistero; la scarsa capacità, anche da parte di esperienze aggregative che vanno per la maggiore, d’interpretare, in fedeltà dinamica, l’eredità del Concilio; i preoccupanti arroccamenti ideologici, a sostegno d’identità religioso-culturali rigide e bloccate; la debole propensione a esprimere, in modo storicamente persuasivo, una genuina tensione profetico-evangelica.
Sul versante propriamente partitico, è da tempo chiusa la stagione dell’«unità» dei cattolici, coincisa con la pluridecennale, massiccia adesione alla Democrazia cristiana. Politicamente, i cattolici italiani, oggi, sono (o sembrano)… in libera uscita. V’è però da domandarsi se la nuova situazione non ponga, a sua volta, problemi seri. L’interrogativo mi sembra più che legittimo, considerate le stesse vicende elettorali degli ultimi anni. Di ciò avremo senz’altro modo di parlare in altre occasioni.
Quello che mi sento di affermare con chiarezza, anche alla luce delle tendenze culturali-politiche in atto e della preoccupante passività di troppi cittadini (cattolici compresi) dinanzi ai segni di «declino» della nostra democrazia (pensiamo alle ricorrenti lacerazioni della Carta costituzionale, ai continui strappi istituzionali, all’imperante populismo demagogico, al flebile senso della legalità…), è l’urgente necessità d’investire in iniziative di «cultura politica». A tale riguardo, Città dell’uomo, fedele agli indirizzi statutari, vuole continuare il cammino di ricerca, di riflessione e di proposta sin qui percorso, in spirito di piena libertà e di aperto dialogo con tutti.
Un aspetto dovrà essere ulteriormente rinvigorito: la cura per la formazione socio-politica dei giovani più sensibili, da svolgere, se del caso, d’intesa con altre realtà del panorama ecclesiale. Penso che il nostro fondatore sarebbe pienamente d’accordo con l’intento programmatico di applicarsi in attività formative destinate al mondo giovanile.
Vorrei inoltre aggiungere che per Città dell’uomo il fatto di gestire, dal 2002, la rivista «Appunti di cultura e politica», promossa — com’è noto — nel 1978 dalla Lega democratica, costituisce un’opportunità significativa per fare circolare «le nostre idee», ma anche motivo di ulteriore impegno nella ricerca e nell’elaborazione culturale-politica.
Non posso chiudere questa lettera senza esprimere un sincero ringraziamento a tutti voi soci, che, tramite la vostra costante adesione, confermate di credere in Città dell’uomo e, con ciò, mostrate d’incoraggiare chi ne porta in forma più diretta la responsabilità della gestione.
Agli amici del Consiglio direttivo ho già avuto modo di manifestare, fra l’altro, l’intento di volere procedere in spirito di genuina collegialità. Secondo questa linea, auspico altresì un’Associazione sempre più aperta alla comunicazione interna, allo scambio schietto di opinioni e suggerimenti.
Qui mi fermo. Nel cogliere l’occasione per augurarvi una serena estate, vi do sin d’ora appuntamento alle prossime iniziative di Città dell’uomo, che a tempo debito segnaleremo. Con viva cordialità, Luciano Caimi
mi preme raggiungervi con questa lettera intanto per comunicarvi che il 16 giugno u.s. il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha provveduto, secondo Statuto, al rinnovo delle cariche associative.
Il nuovo organigramma, per il triennio 2008-2011, risulta così definito: Presidente, il sottoscritto; Vice-presidente, prof. Eugenio Zucchetti; Segretario, dott. Vincenzo Satta; Tesoriere, prof. Sergio Parazzini.
Come potete vedere, a me è stato conferito l’incarico della presidenza. Subentro, pertanto, all’amico prof. Guido Formigoni, che per tre mandati consecutivi, con l’ausilio dei Consiglieri via via succedutisi nel corso dei nove anni, ha così bene guidato “Città dell’uomo”. A Guido (e ai suoi collaboratori) va il ringraziamento del nuovo Consiglio e mio personale per il lavoro svolto con intelligenza e passione, in fedeltà agli scopi associativi.
Dunque, tocca a me raccogliere il testimone dell’Associazione che, passo dopo passo, è ormai giunta a un’età… rispettabile: quasi 23 anni! Era il 4 ottobre 1985, giorno di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, quando, nell’ambito di un seminario su «I cristiani per la città dell’uomo», tenutosi presso il Centro Paolo VI di Milano, venne siglato l’atto costitutivo di Città dell’uomo. Con Giuseppe Lazzati, furono firmatari Leopoldo Elia, Giuseppe Glisenti, Marco Ivaldo, Ettore Massacesi, Giorgio Pastori, Luciano Pazzaglia, Luigi Franco Pizzolato, Cesare Trebeschi.
Io ero presente all’incontro. Ricordo l’atmosfera di soddisfazione e di fiduciosa speranza per il contributo che la nuova Associazione, gratificata subito da parecchie e significative adesioni, avrebbe potuto fornire in una stagione di cambiamenti sempre più accelerati ai livelli culturale, socio-politico, ecclesiale.
A distanza di così tanto tempo può essere istruttivo per noi riandare alle parole con le quali Lazzati introdusse il suddetto seminario. L’indimenticato professore così definiva fisionomia e scopo di Città dell’uomo: «un servizio culturale-politico» per «aiutare l’elaborazione, la promozione e la diffusione di una cultura politica capace di rispondere, oggi, alle esigenze di una più illuminata, creativa, partecipata presenza dei cristiani nella polis»1. «Concezione cristiana dell’uomo e del mondo», «senso della distinzione fra i valori specificamente religiosi e quelli politici», fedeltà ai «princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana con la continua attenzione a rispondere alle complesse esigenze della società in trasformazione»: dovevano essere questi gli assi portanti della nascente Associazione.
Lazzati osservava, poi, che Città dell’uomo si rivolgeva particolarmente, ma non esclusivamente, ai cattolici. D’altra parte, egli era ben consapevole del fatto che la riflessione associativa intorno ai problemi della polis si sarebbe dovuta confrontare con quelle espresse dagli esponenti dei diversi orientamenti culturali e politici presenti nel Paese. Il professore, inoltre, significativamente precisava: «si tratta di uscire da presunte ipotesi di “nuova cristianità”, di “città cristiana” più o meno palesi e perseguite in ambienti e in movimenti cristiani, naturalmente senza perdere la coscienza, anzi coltivandola, dell’apporto che “lo specifico cristiano” reca all’individuazione ed attuazione dell’autenticamente umano»2.
Dal 4 ottobre 1985… ne è passata di acqua sotto i ponti! Eppure le parole del nostro fondatore, serenamente orientatrici circa il lavoro cui avrebbe dovuto attendere l’Associazione, sono di palpitante attualità. Quanto urgente sia oggi l’esigenza di un «servizio» culturale-formativo per aiutare i cattolici, adulti e giovani, a (ben) «pensare politicamente», è sotto gli occhi di tutti.
Annoto ciò, avendo presente la complessa realtà del mondo cattolico italiano. Di esso conosciamo meriti e pregi: per esempio, la capacità di richiamare nel dibattito pubblico la rilevanza dei valori etici intorno ai gravi problemi che agitano la coscienza contemporanea; la presenza ai livelli territoriale e popolare con capillari attività di natura religioso-spirituale, culturale e di «promozione umana» (meritoria, in tal senso, l’opera delle parrocchie e quella di molteplici associazioni, movimenti, gruppi); l’iniziativa in settori strategicamente rilevanti per la crescita personale e sociale (si pensi a scuola e Università); la dedizione, espressa da numerosi «soggetti» e con varietà di forme, ai bisogni antichi e nuovi della gente, in special modo dei più deboli.
Ma, detto questo, è altresì onesto rilevare alcune questioni aperte nella «galassia» cattolica, che ne fotografano l’interna complessità e finiscono con l’interpellare, in modo più o meno diretto, anche la nostra Associazione. Rammento, a titolo esemplificativo: le considerevoli, persistenti differenze d’indirizzo teologico, ecclesiale, culturale e politico fra associazioni e movimenti di larga diffusione, causa anche di ricorrenti attriti; le crescenti spinte verso posizioni socio-politiche di centro-destra, non di rado difformi, su alcuni aspetti della vita sociale (pensiamo a giustizia, lavoro, legalità, immigrazione, pace, sottosviluppo…), dagli insegnamenti del Magistero; la scarsa capacità, anche da parte di esperienze aggregative che vanno per la maggiore, d’interpretare, in fedeltà dinamica, l’eredità del Concilio; i preoccupanti arroccamenti ideologici, a sostegno d’identità religioso-culturali rigide e bloccate; la debole propensione a esprimere, in modo storicamente persuasivo, una genuina tensione profetico-evangelica.
Sul versante propriamente partitico, è da tempo chiusa la stagione dell’«unità» dei cattolici, coincisa con la pluridecennale, massiccia adesione alla Democrazia cristiana. Politicamente, i cattolici italiani, oggi, sono (o sembrano)… in libera uscita. V’è però da domandarsi se la nuova situazione non ponga, a sua volta, problemi seri. L’interrogativo mi sembra più che legittimo, considerate le stesse vicende elettorali degli ultimi anni. Di ciò avremo senz’altro modo di parlare in altre occasioni.
Quello che mi sento di affermare con chiarezza, anche alla luce delle tendenze culturali-politiche in atto e della preoccupante passività di troppi cittadini (cattolici compresi) dinanzi ai segni di «declino» della nostra democrazia (pensiamo alle ricorrenti lacerazioni della Carta costituzionale, ai continui strappi istituzionali, all’imperante populismo demagogico, al flebile senso della legalità…), è l’urgente necessità d’investire in iniziative di «cultura politica». A tale riguardo, Città dell’uomo, fedele agli indirizzi statutari, vuole continuare il cammino di ricerca, di riflessione e di proposta sin qui percorso, in spirito di piena libertà e di aperto dialogo con tutti.
Un aspetto dovrà essere ulteriormente rinvigorito: la cura per la formazione socio-politica dei giovani più sensibili, da svolgere, se del caso, d’intesa con altre realtà del panorama ecclesiale. Penso che il nostro fondatore sarebbe pienamente d’accordo con l’intento programmatico di applicarsi in attività formative destinate al mondo giovanile.
Vorrei inoltre aggiungere che per Città dell’uomo il fatto di gestire, dal 2002, la rivista «Appunti di cultura e politica», promossa — com’è noto — nel 1978 dalla Lega democratica, costituisce un’opportunità significativa per fare circolare «le nostre idee», ma anche motivo di ulteriore impegno nella ricerca e nell’elaborazione culturale-politica.
Non posso chiudere questa lettera senza esprimere un sincero ringraziamento a tutti voi soci, che, tramite la vostra costante adesione, confermate di credere in Città dell’uomo e, con ciò, mostrate d’incoraggiare chi ne porta in forma più diretta la responsabilità della gestione.
Agli amici del Consiglio direttivo ho già avuto modo di manifestare, fra l’altro, l’intento di volere procedere in spirito di genuina collegialità. Secondo questa linea, auspico altresì un’Associazione sempre più aperta alla comunicazione interna, allo scambio schietto di opinioni e suggerimenti.
Qui mi fermo. Nel cogliere l’occasione per augurarvi una serena estate, vi do sin d’ora appuntamento alle prossime iniziative di Città dell’uomo, che a tempo debito segnaleremo. Con viva cordialità, Luciano Caimi
1 G. Lazzati, Introduzione, in I cristiani per la città dell’uomo, Cooperativa In Dialogo, Milano 1986, p. 7.
2 Ibid., p. 9.
2 Ibid., p. 9.