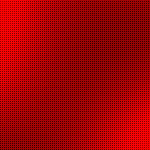Appunti 2_2008
Strategia ecclesiale e impegno pluralista dei cattolici in politica
› Guido Formigoni
L’attuale posizione dei vertici ecclesiastici italiani rispetto alla politica è stata fissata autorevolmente più di dieci anni fa, al convegno ecclesiale di Palermo, dopo la fine imposta dai fatti dell’unità politica precedente. Come interpretarla? Che conseguenze essa pone per i credenti laici impegnati in politica? Le domande erano al centro di questo intervento, presentato a Roma lo scorso 17 febbraio al convegno «Democrazia e bene comune», organizzato da una serie di esponenti cattolici nel Partito democratico per riflettere sull’esperienza in atto, e concluso da Walter Veltroni.
Occorre partire da un punto che non deve sembrare banale: ricordare il fatto che l’unità politica dei cattolici ha costituito una parabola storica delimitata. Non una sorta di condizione «naturale», tanto da condurci oggi a rimpiangere di vivere in un quadro negativamente eccezionale. Essa infatti è stata il frutto di un’operazione storica, costruita dalla Dc degasperiana nell’immediato dopoguerra, in accordo con la sponda montiniana Oltretevere, dopo parecchi decenni di divisioni tra cattolici attorno a tutti i passaggi storico-politici decisivi dello Stato unitario (pro o contro il Risorgimento, pro o contro la crescita delle masse popolari, pro o contro l’intervento in guerra nel 1915, pro o contro il fascismo…). La stessa premessa storica parziale e discussa dell’esperienza del Ppi aveva rivestito in questo quadro un ruolo del tutto effimero. La creatura degasperiana invece è durata per cinquant’anni, un tempo indubbiamente cospicuo, ma delimitato, ed ormai si è esaurita da ben quindici anni.
La sua conclusione non è avvenuta per scelta ecclesiale o per scarso impegno di tutela da parte dei cattolici italiani (come una certa vulgata conservatrice rimproverava negli anni del post-Concilio ai cattolici «conciliari»). Anzi, occorre ricordare l’enfasi ecclesiastica degli anni ’80, che tornava a giustificare l’unità partitica sulla base dell’appello diretto alla dottrina sociale della Chiesa: si pensi all’impostazione successiva al convegno ecclesiale di Loreto del 1985. La sua conclusione è avvenuta piuttosto per l’implosione del modello «partito di ispirazione cristiana» sotto i colpi della crisi del sistema politico e della crescente incompatibilità tra i componenti di quella mobile «federazione» di gruppi e correnti che ormai era divenuta la Dc. È stata quindi frutto di una dinamica tutta politica, che naturalmente ha influito e retroagito pesantemente sulle scelte ecclesiali.
Lo «schema di Palermo»
Dopo l’ultima scissione del Ppi avvenuta nella primavera del 1995 (con la convergenza dei due spezzoni sulla destra e sulla sinistra dello schieramento politico), tale esperienza si poteva considerare definitivamente dissolta. La nuova strategia dei vertici ecclesiali di fronte alla politica, messa rapidamente a punto, pur senza grandi ripensamenti o autocritiche sul modello precedente, comportava una grande novità. Potremmo definire questa impostazione nuova lo «schema di Palermo», perché codificato di lì a pochi mesi dall’intervento autorevole di Giovanni Paolo II al convegno ecclesiale di Palermo. In seguito più volte ribadito e ripreso dalla Cei, è ancora il modello sostanzialmente in vigore.
Si tratta del combinato disposto di due scelte essenziali integrate tra loro. La prima afferma che la Chiesa non compie nessuna scelta e non esprime nessuna preferenza rispetto al gioco partitico. Il discorso di papa Giovanni Paolo II al convegno ecclesiale di Palermo del novembre 1995 ha fissato autorevolmente il punto: «La chiesa non deve e non intende coinvolgersi con alcuna scelta di schieramento politico o di partito, come del resto non esprime preferenze per l’una o l’altra soluzione istituzionale o costituzionale»1. Non c’è più nessuna primogenitura dei diversi spezzoni cattolici e quindi, per ricaduta logica, anche nessuna scelta di principio per un modello organizzativo piuttosto che un altro (identità «cattolica» visibile? presenza o assenza di un simbolo identitario? convergenza dei cattolici in un partito di ampia aggregazione?). Si tratta ormai di questioni ridotte tutte «allo stato laicale» del libero confronto.
La seconda scelta precisa e integra la prima. Il riconoscimento del pluralismo politico non comporta nessuna diaspora culturale: anzi, si immaginò proprio in questi anni il cosiddetto «progetto culturale», per trarre le conseguenze dell’unità di fede nel discernimento comunitario sui grandi problemi dell’epoca storica. Si torna spesso a richiamare di conseguenza ogni cattolico impegnato alla «comune adesione ai contenuti dell’antropologia e dell’etica cristiana, espressi nella dottrina sociale della Chiesa», senza «operare indebite selezioni tra tali contenuti»2. Giovanni Paolo II a Palermo ha subito precisato il proprio discorso asserendo che il rifiuto di uno schieramento politico della Chiesa «non ha nulla a che fare con una diaspora culturale dei cattolici, con un loro ritenere ogni idea o visione del mondo compatibile con la fede, o anche con una loro facile adesione a forze politiche e sociali che si oppongano, o non prestino sufficiente attenzione, ai princìpi della dottrina sociale della Chiesa sulla persona e sul rispetto della vita, sulla famiglia, sulla libertà scolastica, la solidarietà, la promozione della giustizia e della pace»3. Insomma, la stessa tavola dei valori che precedentemente era citata per motivare l’unità, diventava termine di paragone del nuovo implicito pluralismo. Versioni magari leggermente diverse di questo elenco di valori essenziali vengono infatti regolarmente rese pubbliche ad ogni turno elettorale per dare il segno di un ancoraggio della Chiesa a questo orizzonte.
Un alveo positivo per i cattolici «democratici»
Questa impostazione è rimasta da quasi tre lustri linea autorevole della Chiesa italiana. Il punto importante da notare è che — a mio parere — essa appare del tutto coerente con la cultura cattolico-democratica. Se sviluppata a fondo, infatti, costituirebbe un alveo positivo perché tale cultura possa sviluppare tutte le sue virtualità. Occorre però intenderci a cosa alludiamo con l’espressione «cattolicesimo democratico». Essa infatti non è solo costituita dalla banale condizione della somma delle due qualificazioni (definendo quindi con questa etichetta i cattolici che siano anche democratici: il che poco definisce, soprattutto perché oggi non sono molti quelli che si dicono apertamente antidemocratici, pur in una condizione di oscillazione sul reale giudizio nei confronti della democrazia, tema su cui torneremo più avanti).
Il cattolicesimo democratico, inteso in senso forte, affonda piuttosto le radici in una larga sintesi esperienziale plurisecolare (i primi cattolici democratici furono coloro che si schierarono dalla parte dei «principi dell’89» ai tempi della grande rivoluzione!), costituita da molteplici rivoli convergenti, che ha essenzialmente sempre avuto due perni centrali. Il primo è la concezione laica della politica, l’idea che occorra sempre una mediazione tra valori e progetti, e quindi anche che accostandosi alla politica democratica moderna il credente assume inevitabilmente una «aggettivazione», che fa parte della storia e dei suoi cangianti conflitti (è una illusione infatti, in quest’ottica, pretendere di essere «cattolici senza aggettivi», antica formula largamente rilanciata nella contemporaneità; delle due l’una: o si trascurano i conflitti reali in una mal spesa ansia compromissoria, o si identifica il cattolicesimo con una parte sociale e politica, in genere quella tradizionalista e resistente alle innovazioni). Altro corollario di questa impostazione è che non si dà politica se non come disegno sintetico di perseguimento del bene comune, senza isolare battaglie specifiche, ancorché giuste e necessarie, ma iscrivendo tutte le proprie istanze in una sintesi che trovi il consenso e la forza politica per mutare l’esistente.
Il secondo pilastro del cattolicesimo democratico è sempre stata una concezione avanzata nel senso dell’uguaglianza e della giustizia: la «democrazia dei moderni» è infatti essenzialmente la lotta dei «molti» per avere cittadinanza, riconoscimento, diritti, opportunità, nel tessuto della modernizzazione, in modo da allargare i confini elitari e notabiliari dello Stato pre-moderno e ottocentesco. Democrazia quindi come sviluppo personalistico e comunitario della società, non come mera tutela dei rapporti di forza spontaneamente costruiti in essa. Via via modificandosi a seconda dei conflitti reali, questa intuizione è rimasta centrale, per dare il senso a una scelta politica non ideologica, ma attenta ad alcune istanze fondamentali, sviluppate nella concretezza della battaglia civile.
Questi due pilastri della concezione cattolico-democratica la distinguono da altre impostazioni (cattolico-sociali, cattolico-liberali, cattolico-intransigenti): sarebbe interessante approfondire queste linee di frattura, ma qui ovviamente non ne abbiamo l’opportunità. Basti dire che l’intreccio delle due opzioni rende il cattolicesimo democratico una sintesi che mi pare possa trovare una positiva collocazione all’interno dello «schema di Palermo» sopra sintetizzato. Infatti le due scelte fondamentali impongono e chiedono di costruire una mediazione propria, la più avanzata possibile, tra la tavola dei valori discendente dalla dottrina sociale della Chiesa e le opzioni concretamente in gioco. Spendendosi positivamente per un obiettivo progettuale, proprio e diverso da quello di altri cattolici, con la prudenza della parzialità (senza immeschinire l’esigente richiamo dei pastori ma senza rivendicare primati rispetto alla fede, in un gioco a scavalco degli avversari), ma anche con l’ambizione della creatività in nome del bene comune. Sviluppando tutte le potenzialità dell’inserimento convinto, da credenti, nel quadro democratico. Tale cultura si inscrive quindi fedelmente nell’elenco di valori sopra ricordato, tutti acquisendo ma al loro interno articolando magari le priorità e mettendo continuamente i valori alla prova della loro relazione reciproca, perché la staticità dell’elenco formale prenda la carne e il sangue di disegni concreti e responsabili di cambiamento.
Le debolezze del percorso ecclesiale
Questo percorso possibile ha conosciuto peraltro in questi anni punti di crisi e battute d’arresto, è inutile nascondercelo. Non si è riusciti a rendere organico e solido lo sviluppo nel tempo di quelle intuizioni originarie. Certo, ci sono in questa storia interrotta anche profonde responsabilità dei politici credenti e degli ambienti culturali che hanno tentato di sviluppare tali idee. Ma i problemi più importanti nello sviluppo di questa impostazione negli ultimi quindici anni sono stati connessi — a mio avviso — alla sua difficile metabolizzazione nel corpo ecclesiale. Essa infatti non era semplice e ovvia, ma chiedeva alcune precondizioni esigenti. Richiedeva in primo luogo una maggior abitudine al discernimento comunitario ecclesiale. E invece si è scelto spesso il silenzio nelle comunità ecclesiali, per impedire il temuto scontro tra le nascenti diversità partitiche, in nome di una retorica dell’unità nella Chiesa spesso fortemente aprioristica e rigida. Non mancano nel paese realtà di vivace ricerca, contesti di confronto vivo e di valutazione comune delle coerenze delle diverse posizioni politiche. Ma una vera «opinione pubblica» interna alla Chiesa, in un fecondo dialogo tra pastori e popolo di Dio, non si è ancora creata.
In secondo luogo, richiedeva maggior fiducia nella responsabilità laicale al momento della mediazione politica. Il problema delicato è infatti non tanto l’adesione ai valori nella loro astrattezza, ma proprio l’interpretazione autentica del legame (sempre necessariamente provvisorio) tra i valori e le leggi, o le scelte politiche di governo, che li attuano o li sviluppano. E a tratti la Cei ha ristretto molto i margini di questo ambito congetturale, attorno a singole questioni. Si ricordi ad esempio il momento forse più critico, la Nota del Consiglio permanente della Cei del marzo 2007 sulla questione della regolazione delle convivenze, che sembrava prosciugare ogni spazio per un «cattolicesimo politico», di qualunque segno, adombrando una impostazione che avocasse la decisione autorevole sui passaggi cruciali alla sola gerarchia. Una linea che, se resa organica, sarebbe indubbiamente diversa dallo «schema di Palermo» sopra descritto, e che infatti traspare soltanto a tratti in questa esperienza complessa.
In terza istanza, il successo di questa nuova stagione richiedeva maggior fiducia verso la democrazia, intesa come contesto e procedimento attraverso cui far passare l’appello ai valori dalla proclamazione allo sviluppo. E invece si sono moltiplicate preoccupazioni e critiche, implicite od esplicite, spinte fino alle insensibili prese di distanza. Una sfiducia verso la democrazia come orizzonte intrascendibile della dialettica politica, appare proprio a partire dai quei testi magisteriali che pure per certi versi hanno segnato un approdo definitivo alla valorizzazione di questa condizione della politica moderna (concludendo un percorso non semplice, sviluppatosi da Pio XII a Paolo VI e al Concilio). Ad esempio, la «Centesimus Annus» di papa Giovanni Paolo II, del 1991, subito dopo aver positivamente salutato i regimi politici basati sulla libertà di scelta e il coninvolgimento dei cittadini nella decisione sui governi, afferma: «A questo proposito, bisogna osservare che, se non esiste nessuna verità ultima la quale guida ed orienta l’azione politica, allora le idee e le convinzioni possono esser facilmente strumentalizzate per fini di potere. Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia. […] la libertà è pienamente valorizzata soltanto dall’accettazione della verità: in un mondo senza verità la libertà perde la sua consistenza, e l’uomo è esposto alla violenza delle passioni ed a condizionamenti aperti od occulti»4. Il timore del relativismo, insomma, fa capolino nella considerazione positiva dei successi della democrazia. In termini magisteriali, il problema è aperto, in termini pastorali questi dubbi possono facilmente essere estesi in dissociazioni concrete e pesanti.
Risultati politici ambigui
Rispetto agli esiti più strettamente politici, i più discutibili risultati di questa deriva sono stati a mio parere due. Il primo è il ritorno di una lacerante contrapposizione laicismo-clericalismo, che ripetutamente rischia la messa in discussione di conquiste di convivenza civile che sembravano solide fino a pochi anni fa. Una ferita aperta, complicata dalla strumentale acquisizione da parte delle destre tutte (anche quelle fino a poco tempo fa anticlericali) dell’orizzonte del cattolicesimo (non della fede cristiana, si badi bene, et pour cause) come bandiera identitaria.
Il secondo, più sottile, ma non meno problematico, rispetto all’equilibrio alto richiesto dallo «schema di Palermo», è il rischio di tornare a creare una parzialità sui valori. Si è infatti in questi anni insensibilmente creata una progressiva differenziazione tra diverse aree di valori e istanze politiche: quelle «eticamente sensibili» (su cui non ci sarebbe margine di differenziazione possibile per i cattolici, non tanto e non solo sul valore in sé, ma addirittura su alcune ricadute operative, spesso ritenute le uniche possibili) e quelle invece delegate alla mediazione giornaliera, quasi derubricate da questioni politiche a pure banalità amministrative, fino ad essere in fondo considerate irrilevanti per la coscienza etica. Solo attorno ai valori e alle scelte della vita, della famiglia, della bioetica (i cosiddetti «valori non negoziabili» della più recente retorica diffusa), l’appello ecclesiastico è stato pressante e continuo, infatti, quasi a creare un senso identitario spiccato attorno ad essi, trascurando tutte le altre occasioni dell’agenda politica. Mi pare una deriva grave per una concezione alta della politica e anche una infrazione seria al sopra richiamato «schema di Palermo».
Un nuovo contributo progettuale necessario
Il contributo dei cattolici democratici per uscire da queste, che a me paiono indubbie difficoltà, dovrebbe comportare una grande stagione di creatività, primariamente in materia di cultura politica. Si dovrebbe mostrare la fecondità di una riflessione che operi a partire dallo «schema di Palermo», collocandosi in mare aperto.
Faccio due esempi essenzialissimi, per capirci, tra i tanti possibili. In primo luogo, occorrerebbe mostrare, da parte di un’area di credenti appassionata della politica, il rilievo etico delle proprie scelte politiche complessive e anche la capacità di rispondere su tutti i fronti e su tutte le questioni (quelle della vita e della famiglia come quelle della pace e della giustizia) all’appello esigente della radicalità evangelica. Non a caso Moro definiva l’ispirazione cristiana con i termini di «principio di non appagamento e di mutamento dell’esistente nel suo significato spirituale e nella sua struttura sociale». Questo appello forte riguarda dunque l’insieme delle sfide politiche dell’attualità. Non è infatti vero, a mio parere, che la cosiddetta «questione antropologica» — come sostiene qualcuno — abbia preso ormai assoluta e irriducibile centralità nello spazio politico: è vero piuttosto che una politica «debole», non solidamente consapevole di sé, ha talvolta ceduto a una vulgata culturale per cui la differenziazione tra le opzioni politiche di destra o di sinistra si starebbe sbiadendo. Ciò ha rischiato di concedere spazio a una visione per cui su una vasta gamma di problemi legati all’attività di governo corrente, oggi non ci sia più reale differenziazione di valori e progetti, e quindi non ci sia nemmeno rilevanza evidente di un confronto politico di spessore etico complessivo. In questo quadro, quindi, i problemi su cui invece ci si differenzia quasi spontaneamente nel dibattito pubblico sono rimasti quelli della regolazione giuridica delle questioni privatissime e delicatissime della vita, della sua trasmissione, del suo inizio e della sua conclusione, su cui la contrapposizione è spesso spontanea, quanto irriflessa e frutto a volte di schematismi ideologici forti. Il lavoro che ci aspetta è quindi la ricostruzione del significato complessivo delle grandi opzioni progettuali che abbiamo di fronte, su tutta la gamma delle questioni rilevanti per il bene comune. Senza «doppi binari» tra valori diversi. Mostrare nei fatti (prima ancora che rivendicare come diritto) che una mediazione politica alta e la costruzione di aperte sintesi tra valori e di chiare priorità di valore è possibile e praticabile. Tale lavoro si dovrebbe ispirare non a una perdente logica difensiva (il linguaggio conta, infatti: quando si parla di «difendere» astrattamente i valori, si intende sempre contrapporsi al nuovo, inteso come un pericolo), ma a una attiva e propositiva «promozione» dei valori, realizzando un’approssimazione più forte al loro «dover essere». Tra l’altro, la logica della «difesa» dei valori trascura il fatto che nell’esperienza concreta della società attuale molti di essi sono stati già ampiamente «negoziati»: solo con una logica promozionale le scelte politiche e legislative possono essere usate come leva per cercare di avvicinare ai valori coloro che ne sono lontani (la parabola della regolazione legislativa delle convivenze «di fatto» esattamente a questo mirava e mira: rendere più facile un avvicinamento al valore della stabilità, rispondendo con la richiesta di adempimento di alcuni doveri a chi chiede diritti e parità).
In secondo luogo, appare opportuno aprire una sottile ma operosa e profonda ricerca sulla democrazia, per liberarla dal sospetto di «relativismo etico»: di che natura è infatti la «verità ultima» di cui Giovanni Paolo II richiamava la necessità anche in democrazia, come sopra abbiamo visto? Il tema è stato più volte poi ripreso anche dall’attuale pontefice, senza peraltro uscire da una sollecitazione indiretta e interrogativa, che lascia aperta la questione. Possiamo tentare di dare una provvisoria risposta, che apre la strada di una ricerca. Se si trattasse infatti di una verità ultima asserita e sanzionata da un’autorità esterna al gioco democratico, non potremmo più ritrovarci nell’orizzonte della modernità e garantire cittadinanza piena a tutte le scelte personali e collettive in materia di opzioni religiose o filosofiche. Se, invece, questa «verità ultima» fosse intesa come la condensazione dei valori della persona e della convivenza riconosciuti da tutti, al di là delle diverse opzioni rispetto al governo dei problemi, al di là del variare di maggioranze o minoranze, la democrazia moderna potrebbe contare su questa risorsa, esplicitamente valorizzando tale sedimentazione dei valori (che non saprei definire se non «costituzionali»), indisponibili al variare delle maggioranze. Insomma, si esce da queste preoccupazioni solo elevando la democrazia rispetto al mero livello minimo indispensabile del «principio di maggioranza»: si legittima la democrazia se la si intende come orizzonte possibile di un discorso comune di ricerca della verità in cui — tra diversi e restando diversi — si possono perseguire livelli più alti di accordo e convivenza civile. La difesa e la tutela creativa della costituzione — soprattutto nella sua irrinunciabile prima parte — a cui il cattolicesimo democratico ha dato il suo alto contributo, sta tutta inscritta in questo orizzonte.
Come si può vedere, su questi punti, un’iniziativa coraggiosa di credenti, condotta all’interno di una esperienza plurale come il Partito democratico, potrebbe aiutare molto la consapevolezza comune. Basta non chiudersi nei ghetti di una linea soltanto difensiva e correntizia, ma competere in campo aperto, con tutte le risorse che la fede e la ragione ci danno.
1 «Il Regno – Documenti», 1995, 21, p. 671.
2 Lettera del presidente della Cei card. Ruini, marzo 1995 (ibid., 1995, 9, p. 285).
3 Ibid., 1995, 21, p. 671.
4 «Centesimus Annus», n. 46. Cfr. anche la «Veritatis splendor», n. 101, dove si parla del «rischio dell’alleanza tra la democrazia e il relativismo etico».