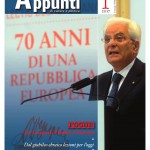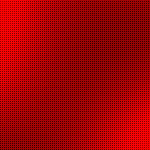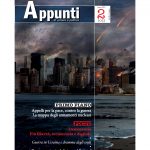Pensare politicamente luglio_2007
Il Cardinale Achille Silvestrini e l’attualità di Lazzati
Sintesi dell’omelia nella Messa per il ventunesimo anniversario della morte del Professor Giuseppe Lazzati, celebrata ad iniziativa della Sezione di Roma dell’Associazione “Città dell’Uomo” nella Chiesa di Santa Maria della Pietà in piazza Colonna in Roma il 17 maggio 2007.
Oggi Lazzati è più attuale di prima. Il suo insegnamento nasceva dalla consapevolezza della “paradossalità” che ispira il comportamento cristiano. Lazzati spiegava che noi non abbiamo la pretesa di creare nel tempo una Gerusalemme celeste ma nemmeno rinunciamo a introdurre nella parzialità della storia le ragioni del fine soprannaturale. La parzialità della storia sono la città, la Chiesa, le istituzioni. C’è in lui il perseguimento continuo, paziente della costruzione di una matura personalità credente che cerca sempre il senso delle cose. Lazzati l’ha fatto nella Chiesa intesa come comunità del cristiano comune alieno da percorsi ecclesiali paralleli e da una formazione religiosa separata e specializzata, ritenendo che le differenze e le particolarità dovessero essere messe in comune come ricchezza per tutti e che lo stare
insieme tra diversi fosse una valida ascesi di comunione intellettuale e morale. Ebbe un’ intensa partecipazione alla vita della Chiesa locale; nella Chiesa di tutti seppe sempre inserirsi, anche soffrendo quando gli appariva lenta. La sua obbedienza era consapevole, non servile, perché motivata, non formale perché non rinunciava a proporre strade nuove di formazione fraterna, per far maturare una posizione comune più avanzata ed elevata. Un’ obbedienza da figlio: grande, rispettosa dei ruoli, partecipe responsabilmente dei limiti. L’obbedienza come virtù da costruire con l’educazione spirituale.
Il cristiano maturo era per lui il fedele, divenuto consapevole del ruolo sacerdotale, regale e profetico e dell’impegno per esercitarlo nel rispetto della natura della Chiesa e del mondo.
Nella vita politica seppe ricondurre i problemi alle loro radici culturali; perché solo quelle motivazioni rendono la politica un fatto educativo per la maturazione di un popolo. Esigente era il suo richiamo alla coerenza tra proposta politica e testimonianza cristiana. Il suo “pensare politicamente” mirava a trasformare in fatti politici, costruttori nelle città di tutti, i valori della cultura cristiana, elaborati come valori di promozione di tutta la città. Questa opera di “mediazioni” consisteva nel proporre i valori cristiani come forza di crescita della città. Quindi non solo la difesa dei valori cristiani affidata all’affermazione di essi e alla contrattazione con i valori altrui. La mediazione invece si sforza di insediare e far valere tutti i valori accomunanti fondati sulle ragioni comuni di senso. Cosi stavano a cuore anzitutto le ragioni della città di tutti (“la città dell’uomo”),
Lazzati paventava il rischio – diventato purtroppo realtà – che una opposizione cieca e aculturale al fenomeno della secolarizzazione finisse con l’accelerare il processo trasformandola in vero “secolarismo” sprovvisto di riferimento alla trascendenza; e riteneva che bisognasse sempre tentare di guidare i processi di trasformazione. Era persuaso che si fosse tardato troppo, da parte cattolica, a prendere in seria considerazione questi fenomeni culturali lasciando che il costume si degradasse fin al punto da rendere impossibile una ripresa naturale e rapida. Egli preferiva comunque praticare, anche in situazioni che parevano disperate, non l’opposizione del muro a muro, ma la strada della partecipazione paziente e responsabile alla costruzione della convivenza più umana possibile.
La sua esperienza politica fu da lui vissuta come un momento educativo per insegnare ai cattolici a pensare con mente politica. La politica restò per lui la più alta attività del cristiano e la palestra più alta della spiritualità laicale. Ebbe fortissimo il senso della prudenza dell’agire nel mezzo tra bontà oggettiva ed efficacia storica e applicava i dati della rivelazione, meditati con continua e personale preghiera, alle situazioni storiche con operazione sapienziale,
insieme tra diversi fosse una valida ascesi di comunione intellettuale e morale. Ebbe un’ intensa partecipazione alla vita della Chiesa locale; nella Chiesa di tutti seppe sempre inserirsi, anche soffrendo quando gli appariva lenta. La sua obbedienza era consapevole, non servile, perché motivata, non formale perché non rinunciava a proporre strade nuove di formazione fraterna, per far maturare una posizione comune più avanzata ed elevata. Un’ obbedienza da figlio: grande, rispettosa dei ruoli, partecipe responsabilmente dei limiti. L’obbedienza come virtù da costruire con l’educazione spirituale.
Il cristiano maturo era per lui il fedele, divenuto consapevole del ruolo sacerdotale, regale e profetico e dell’impegno per esercitarlo nel rispetto della natura della Chiesa e del mondo.
Nella vita politica seppe ricondurre i problemi alle loro radici culturali; perché solo quelle motivazioni rendono la politica un fatto educativo per la maturazione di un popolo. Esigente era il suo richiamo alla coerenza tra proposta politica e testimonianza cristiana. Il suo “pensare politicamente” mirava a trasformare in fatti politici, costruttori nelle città di tutti, i valori della cultura cristiana, elaborati come valori di promozione di tutta la città. Questa opera di “mediazioni” consisteva nel proporre i valori cristiani come forza di crescita della città. Quindi non solo la difesa dei valori cristiani affidata all’affermazione di essi e alla contrattazione con i valori altrui. La mediazione invece si sforza di insediare e far valere tutti i valori accomunanti fondati sulle ragioni comuni di senso. Cosi stavano a cuore anzitutto le ragioni della città di tutti (“la città dell’uomo”),
Lazzati paventava il rischio – diventato purtroppo realtà – che una opposizione cieca e aculturale al fenomeno della secolarizzazione finisse con l’accelerare il processo trasformandola in vero “secolarismo” sprovvisto di riferimento alla trascendenza; e riteneva che bisognasse sempre tentare di guidare i processi di trasformazione. Era persuaso che si fosse tardato troppo, da parte cattolica, a prendere in seria considerazione questi fenomeni culturali lasciando che il costume si degradasse fin al punto da rendere impossibile una ripresa naturale e rapida. Egli preferiva comunque praticare, anche in situazioni che parevano disperate, non l’opposizione del muro a muro, ma la strada della partecipazione paziente e responsabile alla costruzione della convivenza più umana possibile.
La sua esperienza politica fu da lui vissuta come un momento educativo per insegnare ai cattolici a pensare con mente politica. La politica restò per lui la più alta attività del cristiano e la palestra più alta della spiritualità laicale. Ebbe fortissimo il senso della prudenza dell’agire nel mezzo tra bontà oggettiva ed efficacia storica e applicava i dati della rivelazione, meditati con continua e personale preghiera, alle situazioni storiche con operazione sapienziale,