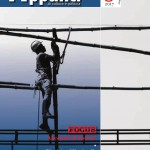Pensare politicamente luglio_2007
Testimoni nella città dell’uomo
alla luce dell’insegnamento di Giuseppe Lazzati
(Estratto della relazione presentata da Marco Ivaldo all’Assemblea della Sezione del 28 aprile 2007)
La democrazia si presenta oggi come una questione irrisolta e un cantiere aperto sia sul piano delle “questioni di giustizia” che su quello delle “questioni antropologiche”. Tale situazione di incompiutezza e di fragilità ci riguarda particolarmente come cattolici democratici. Domanda la capacità – spirituale e culturale – di vivere in feconda dialettica l’identità e l’apertura, l’appartenenza e l’ascolto delle ragioni degli altri, ossia di praticare quella che Giuseppe Lazzati ha chiamato: l’unità dei distinti. E’ necessario che emerga un laicato cattolico che nella unità di un piano di vita radicato nella Parola di Dio e alimentato nella Chiesa sappia pensare e agire politicamente in maniera responsabile e autonoma. Il contributo della fede cristiana alle controverse questioni di fondo che si aprono nello spazio politico pubblico, e che riguardano sia le questioni di giustizia che le questioni antropologiche della democrazia passa infatti essenzialmente per l’azione dei cristiani laici, e perciò richiede un nuovo protagonismo dei laici che riassuma con forza la dottrina sul laicato del Vaticano II .
Lazzati ha insegnato che la politica deve fondarsi sulla cultura, e che una parte essenziale della cultura è la visione dell’uomo. Tuttavia la questione antropologica più che come un luogo di incontro si presenta oggi come un campo di conflitto fra diverse visioni dell’uomo e ciò non resta senza ripercussione sulla politica (pensiamo alle legislazioni in ambito bioetico). Si tratta perciò di affrontare la questione antropologica nella sua carica conflittuale, per vedere se non sia possibile costruire un arduo, ma necessario riconoscimento comune di valori, ovvero ricercare quel “punto comune di ragione”, come diceva Lazzati, che consenta via via il massimo possibile di realizzazione dei valori umani. Inoltre si pone l’esigenza di allargare l’idea di laicità, superando la concezione della religione come affare privato e a costruendo forme di fecondazione reciproca in vista della giustizia e del bene comune fra le tradizioni o le culture religiose e la ricerca politica. Sembra necessario progredire da una visione ‘escludente’ a una visione ‘includente’ di laicità, secondo la quale laicità sarebbe l’apertura e la garanzia di uno spazio o di un terreno di incontro tra soggetti diversi (per religione, ideologia, cultura, stili di vita ecc.) in vista di una trattazione consensuale delle questioni che riguardano il loro coesistere in vista del bene collettivo. Infine occorre trovare una via media fra la realizzazione per imposizione giuridica di una sola concezione di valori, e un relativismo per il quale tutte le forme e scelte di vita sono parimenti valide e accettabili a condizione che non interferiscano l’una nell’altra. Per il laico cristiano in ambito politico si pone in particolare la questione di coniugare valori non-negoziabili e negoziazione politicamente necessaria, ovvero di portare a unità principi non disponibili e pratica della politica come costruzione dialogica di misure volte al bene comune e capaci di conquistare consenso. La distinzione fra il diritto e la moralità può qui offrire un certo aiuto: ad esempio, in società pluralistiche e di fronte al presentarsi di forme non tradizionali di legame affettivo fra gli individui la legge positiva sarebbe chiamata a stabilire e garantire diritti e doveri delle persone e fra le persone interessate, ma sempre in maniera che questa pattuizione “non contraddica” (cioè non neghi e renda impossibile) la libera realizzazione di relazioni morali che la società giudica fondanti per lei stessa e che può/deve a sua volta sostenere con leggi e misure ad hoc. Si tratta di un approccio che consente un certo margine al diritto, e all’intervento della saggezza politica, senza negare il primato di quella fondante relazione etica che viene espressa dal binomio: matrimonio e famiglia.
Per realizzare una sintesi sostenibile di valori non-negoziabili e politica si apre allora lo spazio di quella che la nostra tradizione chiama “mediazione culturale”, la cui funzione essenziale si impone nuovamente per la natura stessa delle questioni in gioco. Il laico cristiano può fare politica – sapere e agire che ha leggi e valori specifici – partendo da valori non-negoziabili, solo se pratica buone mediazioni culturali, le quali non possono che fondarsi sul principio della “unità dei distinti”. In caso contrario si condanna al tradimento dei valori o alla inefficacia politica. L’insegnamento di Giuseppe Lazzati sembra in questo senso più fecondo che mai, e Città dell’Uomo in questo complesso passaggio politico e culturale deve farlo conoscere e valorizzarlo nella discussione pubblica, nella comunità cristiana e nelle giovani generazioni.
Lazzati ha insegnato che la politica deve fondarsi sulla cultura, e che una parte essenziale della cultura è la visione dell’uomo. Tuttavia la questione antropologica più che come un luogo di incontro si presenta oggi come un campo di conflitto fra diverse visioni dell’uomo e ciò non resta senza ripercussione sulla politica (pensiamo alle legislazioni in ambito bioetico). Si tratta perciò di affrontare la questione antropologica nella sua carica conflittuale, per vedere se non sia possibile costruire un arduo, ma necessario riconoscimento comune di valori, ovvero ricercare quel “punto comune di ragione”, come diceva Lazzati, che consenta via via il massimo possibile di realizzazione dei valori umani. Inoltre si pone l’esigenza di allargare l’idea di laicità, superando la concezione della religione come affare privato e a costruendo forme di fecondazione reciproca in vista della giustizia e del bene comune fra le tradizioni o le culture religiose e la ricerca politica. Sembra necessario progredire da una visione ‘escludente’ a una visione ‘includente’ di laicità, secondo la quale laicità sarebbe l’apertura e la garanzia di uno spazio o di un terreno di incontro tra soggetti diversi (per religione, ideologia, cultura, stili di vita ecc.) in vista di una trattazione consensuale delle questioni che riguardano il loro coesistere in vista del bene collettivo. Infine occorre trovare una via media fra la realizzazione per imposizione giuridica di una sola concezione di valori, e un relativismo per il quale tutte le forme e scelte di vita sono parimenti valide e accettabili a condizione che non interferiscano l’una nell’altra. Per il laico cristiano in ambito politico si pone in particolare la questione di coniugare valori non-negoziabili e negoziazione politicamente necessaria, ovvero di portare a unità principi non disponibili e pratica della politica come costruzione dialogica di misure volte al bene comune e capaci di conquistare consenso. La distinzione fra il diritto e la moralità può qui offrire un certo aiuto: ad esempio, in società pluralistiche e di fronte al presentarsi di forme non tradizionali di legame affettivo fra gli individui la legge positiva sarebbe chiamata a stabilire e garantire diritti e doveri delle persone e fra le persone interessate, ma sempre in maniera che questa pattuizione “non contraddica” (cioè non neghi e renda impossibile) la libera realizzazione di relazioni morali che la società giudica fondanti per lei stessa e che può/deve a sua volta sostenere con leggi e misure ad hoc. Si tratta di un approccio che consente un certo margine al diritto, e all’intervento della saggezza politica, senza negare il primato di quella fondante relazione etica che viene espressa dal binomio: matrimonio e famiglia.
Per realizzare una sintesi sostenibile di valori non-negoziabili e politica si apre allora lo spazio di quella che la nostra tradizione chiama “mediazione culturale”, la cui funzione essenziale si impone nuovamente per la natura stessa delle questioni in gioco. Il laico cristiano può fare politica – sapere e agire che ha leggi e valori specifici – partendo da valori non-negoziabili, solo se pratica buone mediazioni culturali, le quali non possono che fondarsi sul principio della “unità dei distinti”. In caso contrario si condanna al tradimento dei valori o alla inefficacia politica. L’insegnamento di Giuseppe Lazzati sembra in questo senso più fecondo che mai, e Città dell’Uomo in questo complesso passaggio politico e culturale deve farlo conoscere e valorizzarlo nella discussione pubblica, nella comunità cristiana e nelle giovani generazioni.