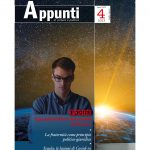Appunti 2_2007
Immigrato, cioè cittadino
Alberto Guariso
Il passaggio dello straniero da ospite (o meglio «utile invasore» secondo la puntuale definizione di Maurizio Ambrosini) a titolare di diritti non dipende certo da una prescrizione giuridica, quanto piuttosto da un atteggiamento culturale del paese ospitante, da consuetudini quotidiane e da una opzione politica di fondo. Tuttavia, senza un intervento legislativo, il passaggio non avviene. E da questo punto di vista il governo della XV legislatura, pur con la sua pachidermica agilità, comincia a produrre qualcosa. Non si vuol qui fare riferimento al problema di quanti e quali stranieri possano avere ingresso in Italia, sul quale intervengono le proposte di modifica della legge sull’immigrazione, ma alle novità normative che riguardano una fase di gran lunga successiva a quella di ingresso, sulla quale si è finora prestata poca attenzione.
Una immigrazione che diventa stabile
Vi è infatti inevitabilmente un momento nel quale lo status del «postulante», di colui che vive perennemente sospeso tra una domanda e una autorizzazione (il «permesso» di soggiorno), precariamente ammesso a spendere le sue energie lavorative sul territorio nazionale, deve cessare per fare posto a «qualcos’altro». Stabilire in cosa consista questo «qualcos’altro» (un permesso stabile, la cittadinanza o altro ancora) e quando questo passaggio debba avvenire, è ovviamente una scelta squisitamente politica, sulla quale ogni motivata opinione deve essere presa in considerazione. Certo è che posticipare all’infinito il momento del passaggio è una scelta irrazionale, ingiusta per lo straniero e soprattutto inefficiente per lo Stato, che sarebbe costretto a spendere enormi risorse in una attività di reiterata autorizzazione priva di effetti pratici rilevanti ai fini della gestione del fenomeno immigrazione: da questo punto di vista, cinque anni di esperienza della legge Bossi-Fini — che si è mossa appunto nella prospettiva di incrementare l’attività «autorizzativa», riducendo la durata dei permessi e innalzando i requisiti per il rinnovo, con il risultato di intasare gli uffici e di far passare nella clandestinità un elevato numero di ex «regolari» — deve ben insegnarci qualcosa.
Va aggiunto che la nostra immigrazione — che il legislatore continua a concepire come un fenomeno strettamente correlato alla domanda e all’offerta di lavoro — si va connotando in maniera sempre meno «lavoristica» per la forte presenza di figli e genitori dell’emigrante, di casalinghe, lavoratori autonomi ecc. (tanto che su 3.035.000 immigrati regolari solo 1.750.000 sono lavoratori subordinati1): e per coloro che sono qui in modo non strettamente funzionale ad un rapporto lavoro, è ancora più naturale che il momento della «stabilizzazione» debba avvenire quanto prima possibile.
La «carta di soggiorno»
Una prima spinta a legiferare in ordine al momento del «passaggio» è venuta dall’Europa — sino ad oggi restia a intervenire direttamente in materia di immigrazione — che, con la direttiva 2003/109 del 25 novembre 2003, ha imposto agli Stati membri di mettere mano alla figura del «soggiornante di lungo periodo» cioè di colui che acquisisce un diritto di soggiorno a tempo indeterminato, non più soggetto a periodico rinnovo. In realtà l’Italia già dal varo della normativa del 1998 conosceva una figura analoga (il titolare di «carta di soggiorno»), che poi la Bossi Fini aveva assoggettato ad alcune restrizioni. Ora il Decreto legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007 ha recepito la direttiva, cancellando quelle restrizioni e precisando meglio i contorni della figura: il permesso di soggiorno in questione è a tempo indeterminato, si acquisisce dopo 5 anni di residenza continuativa in Italia, a condizione di avere un reddito annuo pari all’assegno sociale (cioè meno di 5.000 euro), può essere revocato solo per motivi di ordine pubblico e garantisce parità di trattamento assoluta con i cittadini italiani nell’accesso al lavoro, ai servizi pubblici, all’alloggio, alle prestazioni previdenziali.
Siamo dunque ad una figura di «cittadino senza cittadinanza», quantomeno per quanto riguarda il pieno esercizio dei diritti sociali e civili. Quanto ai diritti politici la norma garantisce al soggiornante di lungo periodo il diritto a «partecipare alla vita pubblica locale» senza nulla specificare; ma è poi il progetto di riforma del testo unico sull’immigrazione che concretizza tale indicazione, prevedendo per i soggiornanti di lungo periodo il diritto di voto alle elezioni amministrative.
E la cittadinanza?
Il vero problema si pone tuttavia dopo questo primo gradino. Il passo successivo — per lo straniero che lo vuole compiere — è infatti, inevitabilmente, quello della cittadinanza. Qui ovviamente la questione non è né meramente giuridica, né solamente burocratica. La cittadinanza è molto più di un permesso di soggiorno stabile; è piuttosto l’adesione al patto sociale che regola la vita di una comunità e al nucleo di valori che la sorregge. Aprire le maglie per l’accesso degli immigrati alla cittadinanza significa muoversi verso la famosa «società plurale», crogiuolo di valori diversi uniti dal reciproco rispetto e da un minimo comun denominatore.
Attribuire alla cittadinanza questa funzione costituirebbe una novità assoluta in un paese come l’Italia ove la cittadinanza è stata storicamente vista come il segno di un vincolo di sangue che legava le generazioni nate sull’italico suolo, sul presupposto che fosse proprio il legame di sangue a fare da tramite per la creazione della identità di valori. Come noto infatti, la legge sulla cittadinanza oggi vigente è nata «a scoppio ritardato» per rispondere alle rivendicazioni degli emigrati italiani, proprio negli anni in cui l’Italia usciva definitivamente dalla condizione di paese di emigranti e ed entrava in quello di paese a forte immigrazione. Coerentemente con la sua genesi la normativa vigente ha come concetto-base una cittadinanza «ereditaria» che si acquista per legame di sangue (basta avere la madre o il padre italiani) e che prescinde totalmente dai legami con il territorio e con la comunità; una normativa il cui effetto pratico è stato un vorticoso incremento — tuttora in corso — nella acquisizione della cittadinanza da parte di residenti (e spesso nati) all’estero; i quali poi (stranezze della sorte) hanno addirittura determinato con il loro voto gli attuali assetti politici.
Vi è ovviamente, anche nella normativa attuale, una seconda strada di acquisizione della cittadinanza, a seguito della residenza continuativa in Italia per almeno dieci anni, ma trattasi di acquisizione condizionata ad una valutazione discrezionale da parte del ministero dell’Interno e ad una successiva «concessione» che si basa su criteri scarsamente oggettivi e verificabili (ancora oggi si riscontrano talvolta provvedimenti di diniego motivati con uno «scarso senso di italianità» del richiedente!).
Entrambe le strade si mostrano ormai del tutto insufficienti e in parte anche irrazionali: la prima dà luogo agli effetti paradossali da più parti rimarcati («cittadini» geograficamente e culturalmente estranei all’Italia e «stranieri» nati e vissuti in Italia, che tali restano solo perchè figli di genitori stranieri) con ciò in nulla garantendo la «omogeneità» e coesione della nazione; la seconda risponde ad una logica premiale e unilaterale (la cittadinanza come beneficio reale, data a chi se la merita) piuttosto che non a quella — più razionale e laica — di un atto dovuto al fine di garantire i diritti essenziali, perseguire la omogeneità nei trattamenti tra coloro che vivono sullo stesso suolo e con essa la riduzione dei conflitti sociali.
Le novità legislative
Il testo unificato del centro sinistra che, a quanto sembra, giungerà a breve all’esame delle aule parlamentari — sintesi di proposte formulate da diversi gruppi parlamentari — sembra dare risposte adeguate a questi problemi. Il passaggio è ovviamente alla cittadinanza (anche) per ius soli: è cittadino chi nasce sul suolo italiano. Il passaggio era atteso e inevitabile. La discussione era semmai quale requisito aggiungere in capo ai genitori al fine di evitare il fenomeno della «turista partoriente»: anche una normativa fondata sullo ius soli deve cioè prevedere che la cittadinanza si acquisti non in qualunque caso di parto occasionale sul territorio nazionale, ma solo se i genitori risiedono con un certo grado di «stabilità» in Italia. Il disegno di legge omette saggiamente qualsiasi riferimento ad una presenza in Italia assistita da un livello minimo di reddito (sarebbe infatti stato assurdo condizionare lo status di cittadino al reddito del genitore, come pure qualcuno aveva richiesto) e, quanto alla durata, fissa il requisito minimo della residenza legale di almeno uno dei genitori in tre anni, fermandosi così a metà strada tra chi premeva per i cinque anni (proposta Amato) e chi chiedeva di limitarsi alla normale durata di un permesso di soggiorno (due anni); lasciando tuttavia aperto il problema di coloro che pur trovandosi in Italia non riuscissero a dimostrare la «residenza legale» o perchè entrati clandestinamente e poi regolarizzati o perchè — caso abbastanza frequente — non riescano ad ottenere la relativa dichiarazione dal Comune non disponendo di un alloggio idoneo a dimostrare l’effettiva continuità di presenza nell’ambito del Comune stesso.
Il requisito della «stabilità» dei genitori sparisce poi se almeno uno di essi è uno straniero nato in Italia, garantendo così l’acquisizione automatica della cittadinanza in capo agli immigrati «di terza generazione». La forte attenzione alla questione dei minori emerge poi in una ulteriore previsione che li riguarda: anche se nato all’estero, il minore ha pieno diritto di divenire cittadino italiano se almeno uno dei genitori risiede in Italia da almeno cinque anni e dopo che anch’egli ha mantenuto la residenza continuativa sul territorio per almeno cinque anni, a condizione che abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso professionale o abbia lavorato per almeno un anno: è insomma il caso classico del bimbo che giunge in Italia assieme alla madre dopo che il padre ha trovato una collocazione relativamente stabile, che si iscrive e si inserisce a scuola, ma che — con la normativa attuale — non potrebbe mai acquisire la cittadinanza italiana (se non a mezzo della citata «concessione» discrezionale e dopo dieci anni).
Quanto al matrimonio, era inevitabile che, conformemente alla perdita di rilevanza del legame matrimoniale nel contesto sociale, anche nella vicenda in questione perdesse qualche punto.
Così oggi bastano sei mesi di residenza in Italia per diventare cittadini italiani se si sposa un italiano o un’italiana, mentre con la nuova legge saranno necessari due anni di residenza successivi al matrimonio. Infine resta anche la possibilità per qualunque straniero di accedere alla cittadinanza per «residenza continuativa», ma i dieci anni di cui si è detto vengono ridotti a cinque e viene ridotta la possibilità di valutazione discrezionale da parte del Ministero dell’Interno.
Quali condizioni per la cittadinanza?
Ma la questione che certamente più scalderà il dibattito è se, a prescindere dai requisiti oggettivi qui sommariamente descritti, l’accesso alla cittadinanza possa essere assoggettato ad altri requisiti di ordine ideale e culturale: la condivisione di valori, la conoscenza della lingua o altro ancora. Qui avranno buon gioco i sedicenti cultori della «identità», pronti ad accampare la necessità di opinabili test di conoscenza della Costituzione e della cultura italiana che probabilmente gran parte dei «normali» cittadini italiani non sarebbe in grado di superare.
Al di là di simili prevedibili forzature — che affondano sempre le loro radici nelle paure e nei preconcetti che sempre fanno da sfondo al tema immigrazione e che troveranno inevitabilmente qualche sponda governativa — la questione non è affatto semplice. Una eccessiva «laicizzazione» del tema cittadinanza non gioverebbe né alla coesione del nostro tessuto sociale, né a quel serio dialogo tra culture differenti che presuppone sempre un reciproco riconoscimento: ed è sotto gli occhi di tutti quanto l’una e l’altro siano oggi di estrema necessità.
Sul versante opposto, un’eccessiva «ideologizzazione» finirebbe per collocare la concessione della cittadinanza (ancor più di quanto avvenga con la normativa attuale) tra i poteri di uno stato «etico» che si erge a censore — inevitabilmente arbitrario — delle convinzioni personali. Su questo punto, il disegno di legge si muove saggiamente in una prospettiva «minimalista»: ad evitare qualsiasi arbitrio, assume l’unico requisito di integrazione oggettivamente «misurabile» che è la conoscenza della lingua italiana e lo richiede (in termini di «equivalenza al livello del terzo anno della scuola primaria») non per la generalità dei canali di accesso alla cittadinanza, ma nelle sole due ipotesi di acquisto per matrimonio e per «residenza continuativa».
Erano circolate in precedenza anche ipotesi diverse, come quella di una sorta di «giuramento» o di dichiarazione di adesione ai valori della Costituzione. Coi tempi che corrono, è facile prevedere che simili proposte resteranno appannaggio di quanti dalle colonne dei giornali terrorizzano l’opinione pubblica con la prospettiva di un’orda di «cittadini» dediti alla poligamia e al culto della Jihad. Sarebbe davvero un peccato, perchè in un’ improbabile Italia purificata da simili furori, anche un tema di questo genere potrebbe diventare l’occasione per recuperare il senso di una «ritualità civile» oggi così povera : così forse il «giuramento» potrebbe diventare una festa nella casa comunale, il sindaco con la fascia tricolore, il neo cittadino con la galabeja o con il turbante, ciascuno lì a riconoscere le reciproche diversità e pronto a stringere — sulla base di quel nucleo essenziale di valori universali che la nostra Costituzione contiene — un patto definitivo di stabile convivenza che da tale diversità si alimenti. Ma una festa di questo genere, probabilmente, fa parte di un’Italia che non c’è.