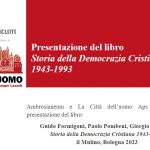Appunti 1_2007
Partito democratico: unidici anni di parole
Giorgio Ferri
Un fiume carsico. È la metafora che meglio rappresenta l’apparire e lo scomparire di un nuovo soggetto politico che per molti è un sogno e per altri un incubo. Il contesto nel quale l’idea prende corpo è quello successivo alla caduta del muro di Berlino e alla crisi di tangentopoli. La Democrazia cristiana e il Partito socialista italiano non ci sono più; il Partito comunista italiano si contorce, con Occhetto, in Partito democratico (eccolo che compare!) della sinistra, subendo la scissione di Rifondazione comunista. Berlusconi e Bossi occupano con Forza Italia e con la Lega il vuoto che si sono trovati davanti e nel 1994 vincono tutto, alleati all’ex Movimento sociale italiano, diventato Alleanza nazionale e ad un pezzo di Dc, diventato Centro cristiano-democratico (progenitore dell’attuale Udc).
1995-2001, L’Ulivo coalizione elettorale
Sollecitato e convinto da Andreatta contrastare il centrodestra trionfante, Romano Prodi si dichiara disponibile a entrare in politica per guidare una coalizione di partiti di centro sinistra. È il 2 febbraio 1995. Dieci mesi dopo, il 13 dicembre, Romano Prodi e Walter Veltroni presentano il simbolo dell’Ulivo col quale la coalizione (Pds, Ppi, Rinnovamento italiano del premier Dini, Unione democratica, Verdi) parteciperà alle elezioni politiche del 21 aprile 1996, vincendole (grazie alla divisione della destra e alla desistenza con Rifondazione comunista). Si capisce subito che l’Ulivo non ha la forza di innovare: la composizione del governo viene fatta con l’aurea regola del «questo a me, quello a te, questo a me»; la nascita della commissione bicamerale (per fare le riforme) significa una cosa molto semplice: lasciamo Prodi, che è un tecnico, a sbrogliarsela coi problemi economici e l’ingresso nell’euro e affidiamo le riforme a quelli che di politica ci capiscono. Sappiamo come è andata. D’altro canto, è una divisione di compiti consensuale: Prodi preferisce lungamente l’azione di governo alla snervante e dura costruzione di un nuovo soggetto politico capillarmente presente nel paese. L’Ulivo non inizia nemmeno la sua corsa come soggetto politico nuovo, abbandonato a sé stesso, mentre i partiti detengono ogni sovranità. Il governo ci prova a innovare, con le leggi Bassanini di riforma dello Stato e con la riforma della sanità e dell’istruzione, fino a cadere nell’ottobre 1998 durante l’approvazione della finanziaria. Si discuterà a lungo dei motivi: Rc si sottrae (ma una parte del partito appoggia Prodi, facendo nascere il Pdci), alcuni partiti della coalizione non sopportano Prodi e mirano a sostituirlo, i conti della fiducia sono mal riposti per un voto.È qui che si vede il maggior limite dell’Ulivo come coalizione: va bene per vincere la sfida elettorale, ma non è abbastanza forte da gestire il successo. Soprattutto, Prodi partecipa alla coalizione come persona non come capo di un partito ed emarginarlo, per i professionisti della politica, non ha conseguenze immediatamente misurabili. L’unico modo per rimediare a questa debolezza è… fare un altro partito.27 febbraio 1999: Prodi fonda un nuovo movimento politico per far nascere in Italia un partito riformatore che abbia delle analogie col partito democratico statunitense. Il simbolo è un asinello (copiato un po’ disneyanamente dagli States), il contesto è ancora quello dell’Ulivo coalizione, ma il progetto ora ha un orizzonte più vasto: fondere in un unico soggetto trasversale le forze riformiste e trasformare la coalizione in un partito unico. Da questo momento il partito unico diventa un incredibile tormentone, di volta in volta evocato, allontanato nel tempo, negato, limitato a una federazione di partiti, riproposto con la variante dell’apertura alla società civile. Si apre anche una interminabile discussione sulle forze riformiste. Quali sono? a che titolo un soggetto (partito o persona) può essere definito riformista?Per ora, l’Ulivo diventa un obiettivo e l’idea si stempera in un «Movimento per l’Ulivo». Il presidente dei Democratici è Arturo Parisi (Prodi nel frattempo sta per diventare presidente della Commissione europea). Al progetto aderiscono i sindaci ulivisti del movimento Centocittà, Italia dei Valori (Antonio di Pietro), La Rete (Leoluca Orlando), Unione Democratica (Antonio Maccanico), alcuni esponenti del PPI (Franco Monaco e Albertina Soliani) e di Rinnovamento Italiano (Augusto Fantozzi e Gianni Rivera).Alle elezioni europee del 1999 il nuovo partito raccoglie il 7,7% dei voti: è il secondo partito del centro-sinistra. La coalizione del 1996 comunque sopravvive col governo D’Alema e col governo Amato, e arriva anche a fare la riforma del titolo quinto della Costituzione, ma perde il consenso degli elettori, come si vede nelle elezioni del 2001 (complice la ritrovata unità di tutte le destre e la frattura con Rifondazione).
2001-2004: la lunga marcia all’opposizione
A partire dal 2002 l’Ulivo all’opposizione entra in una nuova fase, di grande incertezza e competizione interna. Gli attori principali sono due: i Ds e la Margherita-Democrazia è Libertà (Dl). I primi vengono dal Pds che ha cambiato nome nel 1998 e lavorano per una unificazione a dominanza socialdemocratica. I secondi sono uno strano soggetto, composto da partiti sciolti per fondersi ma poco fusi, e lavorano per una unificazione a dominanza centrista.Sulla nascita della Margherita vale la pena di ricordare alcuni passaggi, perché più volte il processo che l’ha preceduta verrà poi richiamato come esempio del processo che dovrebbe condurre al Partito democratico. L’11 ottobre 2000, i Democratici rendono pubblica una «proposta al paese» con un documento che viene firmato anche dal Ppi, da Rinnovamento italiano e da Udeur di Mastella. «L’Italia ha bisogno di continuare sulla strada del rinnovamento e delle riforme. L’Italia ha bisogno allo stesso tempo di un nuovo inizio… Questa iniziativa intende mettere insieme le tradizioni politiche cattolico-democratica, liberal-democratica e laico-riformista con le migliori energie della società civile e dare vita ad una solida e forte area centrale dell’Ulivo». Un anno dopo, il 24 marzo 2002, a Parma, nasce il nuovo soggetto politico: è un partito nuovo nel quale confluiscono e si sciolgono i partiti fondatori. Con modalità differenti e un’eccezione. Il Ppi mentre si scioglie dà vita ad una associazione «con lo scopo di mantenere, preservare e aggiornare la tradizione popolare e cattolica democratica all’interno della Margherita e dell’Ulivo» (presidente è Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario Ppi). L’eccezione è l’Udeur: la componente guidata da Carra entra, quella guidata da Clemente Mastella rimane fuori. Proprio al momento della nascita si apre un solco tra la componente dei Popolari e la componente dei Democratici. La questione è sempre la stessa: quanto sono stati superati i vecchi partiti? A sette anni dalla nascita l’Ulivo coalizione contiene due partiti in evidente competizione tra loro (e ciascuno affaticato dallo sforzo di contenere le contraddizioni interne); ha un padre fondatore (Prodi) che fa tutt’altro e ogni tanto manda dall’esterno messaggi che invitano all’unità. Questo strano contenitore dovrebbe fare opposizione al governo Berlusconi e preparare la rivincita alle elezioni politiche del 2006.Compare per la prima volta un soggetto che lavora per un «nuovo Ulivo», pur non appartenendo ad alcun partito: l’associazione dei Citttadini per l’Ulivo. Nel mese di giugno del 2002 un gruppo di persone di origini politiche diverse (comitati, movimenti, associazioni e tutte le realtà associative di base per l’Ulivo), apre la riflessione sulla possibilità di imprimere una spinta dal basso alla discussione sull’Ulivo. La prima assemblea nazionale (Roma, 30 novembre 2002) che approva un progetto di manifesto politico, una campagna di promozione/adesione sotto il simbolo della «formichina per l’Ulivo» e la convocazione di una seconda assemblea nazionale per marzo 2003. «L’obiettivo principale dei «cittadini per l’Ulivo» è la convocazione della costituente dell’Ulivo… un soggetto politico federativo, che operi unitariamente». I Ds sono i primi a registrare questi stimoli per un partito «nuovo» e «aperto» e organizzano, a Milano, una Convenzione programmatica per il programma dell’Ulivo. Fassino il 4 aprile 2003 parla quindi dell’Ulivo come «nuova alleanza per il governo dell’Italia». Lo schema è questo: un’alleanza solida, un collegamento ad altri partiti (Idv, Rc), ma «dentro un Ulivo grande, serve una sinistra di chiaro profilo innovatore, parte integrante del socialismo europeo, solida nelle sue radici occidentali, forte dei suoi valori, pluralista nella sua dialettica interna». La risposta del neo coordinatore della Margherita Rutelli è speculare: capacità di coesione politica, attenzione alla competizione, piena dignità di tutti i partiti.
2004-2005: coalizione allargata e/o lista unica dell’Ulivo?
A questo punto della maturazione di un Ulivo diverso, molto di più di una semplice coalizione di partiti, arriva la bomba tirata da Prodi: la proposta di una lista unitaria alle europee del 2004. Dal suo punto di vista (di presidente della Commissione europea in scadenza) è una comune visione dell’Europa che deve produrre una lista unitaria. Ma la discussione fra i partiti va molto più in là. Anche perché è evidente che la lista unitaria potrebbe essere il primo passo di un percorso verso un partito unico. Alla vigilia delle elezioni Prodi incassa un successo: aderiscono alla lista unitaria quattro partiti (Ds e Margherita, oltre ai più piccoli Socialisti democratici italiani e Repubblicani). Però non si accontenta e dice di avere un progetto più vasto: tutti capiscono che ha in mente un partito unico, anche perché se ne parla come ipotesi da nove anni, ma cautamente le parole non escono ancora. Alle elezioni europee del 10-13 giugno 2004 «Uniti nell’Ulivo» ha un certo successo (31,1%) e supera Forza Italia di dieci punti percentuali. E allora che si fa? Il primo passo è dividersi al Parlamento Europeo: Margherita da una parte, Ds da un’altra: esito ampiamente annunciato, peraltro, perché le collocazioni europee sono ancora divisive.Una settimana dopo le elezioni, come previsto, si apre la discussione sul che fare. I risultati sembrano aver rafforzato la posizione di chi voleva andare avanti nel processo unitario, anche se vi sono diverse opzioni sul come procedere. Romano Prodi propone subito una corsa in avanti. Il 15 giugno 2004, in una lettera pubblica lancia un appello per la convocazione «entro il prossimo autunno l’Assemblea Costituente dell’Ulivo sotto la guida di un apposito Comitato nazionale» e perché «si sviluppi una larga mobilitazione dei cittadini per la formazione degli Albi degli Elettori dell’Ulivo che raccolgano tutte le donne e gli uomini che si riconoscono nel progetto di un’Italia democratica, di pace, di libertà e giustizia». Ai partiti questa idea di rifondare l’Ulivo, aprendolo ai cittadini, crea qualche problema. D’Alema e Rutelli si limitano a contro-proporre un «patto federativo». Boselli (Sdi), Pecoraro Scanio (Verdi) e Di Pietro (Italia dei Valori) derubricano a una semplice coalizione che però sia anche capace di dialogare con la sinistra «radicale» di Bertinotti e di Diliberto.Prodi apre un secondo fronte, dopo la costituente per rilanciare l’Ulivo, le elezioni primarie per consolidare la sua leadership (su cui peraltro s’era già manifestata ampia convergenza dei partiti della coalizione). Sulla proposta si apre in luglio una manfrina di parecchi mesi. Al contempo, Rutelli anticipa l’intenzione della Margherita di partecipare da sola — almeno in alcune regioni — alle elezioni regionali del 2005. Prodi chiede una decisione ultimativa sul «nocciolo duro della coalizione», la Federazione dell’Ulivo. Fassino e Rutelli rilasciano una dichiarazione congiunta «è pieno e convinto il nostro impegno a lavorare con lui per dare corso alla Federazione dell’Ulivo come perno di una grande Alleanza democratica». L’11 ottobre 2004, Prodi partecipa a un vertice di tutti i leader del centrosinistra, al termine del quale si presenta a una conferenza stampa. «Oggi è partita la grande alleanza democratica (Gad) e parte dunque la grande sfida… Entro febbraio 2005, elezioni primarie per scegliere il candidato premier della grande alleanza democratica… entro dicembre 2005 la coalizione terrà una grande convenzione per presentare il programma di governo… La grande alleanza democratica si presenterà unita in tutte le regioni in cui si voterà nella primavera del 2005 con un unico candidato presidente». Il chiarimento sui nomi è ancora provvisorio: il nocciolo duro della coalizione, formato da Ds, Margherita, Sdi e Repubblicani, non si chiamerà più «lista unitaria» ma Federazione dell’Ulivo (o Ulivo), mentre l’intero schieramento — quello che da Bertinotti arriva a Mastella — risponderà al nome di Grande alleanza democratica. Siamo a un punto fermo? Nemmeno per sogno: Il processo di formazione delle alleanze e delle liste per le regionali del 2005 è ulteriormente teso e frammentato. A metà gennaio 2005 si arriva a una sorta di accordo, che appare un mezzo passo indietro. Saranno nove le regioni in cui l´Ulivo si presenterà con una sola lista: Liguria, Lombardia, Lazio, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Basilicata, Veneto. Cinque quelle in cui i partiti si presenteranno divisi. Una sola al Nord, il Piemonte, quattro al Sud: Abruzzo, Calabria, Puglia, Campania. Anche i Ds hanno sottoscritto l´intesa. Definito come partecipare alle regionali, si conclude (apparentemente) il tormentone delle primarie con una dichiarazione congiunta sul fatto che si terranno nel mese di maggio dopo le amministrative. Dal 10 febbraio 2005 compare un nuovo soggetto: l’Unione. È il nuovo nome della grande alleanza (Gad), in vista delle elezioni regionali dell’aprile 2005 e delle politiche 2006. Ne fanno parte nove partiti: l’Ulivo (Ds, Margherita, Repubblicani europei), lo Sdi di Boselli, uscito dall’Ulivo ma disponibile a far parte dell’Unione, Rifondazione comunista, i Verdi, l’Italia dei valori, i Comunisti italiani e l’Udeur. Un appoggio esterno è fornito dalla Lista consumatori e addirittura dallo Psdi-socialdemocrazia (alcuni esponenti del vecchio Psdi che fino al gennaio 2004 hanno militato all’interno dello Sdi).Le elezioni di aprile sono un successo per la coalizione di centro-sinistra: su 14 regioni, 12 vittorie. Di nuovo, come nel 1996-1998, il successo complica le cose. La Margherita sembra aver raggiunto una sorta di equilibrio con i Ds, considera quindi fugato il timore di fare un partito egemonizzato dalla componente di sinistra, ritiene che questo sia dovuto alla decisione di correre da sola in alcune regioni e quindi ripropone uno schema analogo per le politiche del 2006: parteciperà col suo simbolo alla quota proporzionale del 25%. A Prodi questo non piace affatto e, di nuovo, userà espressioni molto forti.Nel frattempo è ricomparso il tema del partito unico. Nessuno dice di volerlo: Prodi nega di averne mai parlato. Il tema però è inevitabile: se si va uniti alle politiche del 2006 e questa tensione verso l’unità viene premiata dagli elettori, poi che si fa? Ancora i tira e molla del post-elezioni 2004 e 2005, oppure si imbocca seriamente la strada che porta a un partito riformista o democratico che sia?Mastella è uno di quelli che sognano un partito unico, ma lui non ha in mente un partito di centrosinistra, ma solo di centro, almeno nel Sud. Aspetta gli ex Dc e rivendica per i «Popolari-Udeur il fatto di essere il terzo partito del Sud e che ormai gli amici e i nemici non possono più considerarci una forza secondaria».
2005-2006: ricompare il partito unico
Il 16 ottobre si svolgono le elezioni primarie in tutta Italia. Vincitore della competizione (un po’ squilibrata, naturalmente) è Romano Prodi (74,1% dei voti), che riceve così l’investitura ufficiale, anche «dal basso» di candidato presidente del Consiglio per le elezioni politiche del 2006. Il dato più rilevante è però l’affluenza: le primarie sono definite una grande prova di coinvolgimento democratico degli elettori: 4.311.149 persone, compresi gli immigrati regolari (prima volta in Italia) e i ragazzi che compieranno i 18 anni entro il 13 maggio 2006. Tutti gli elettori hanno versato un contributo (almeno 1 euro) e sottoscritto il manifesto dell’Unione. La sorpresa dei leader dei partiti è stata grande e, da quel momento, si vedranno costretti a riprendere ancora una volta il tema del partito democratico. Sia nei Dl che nei Ds ricompaiono voci in questo senso, subito stoppate dai sostenitori interni dell’autonomia dei diversi partiti. Prodi a questo punto, nell’ottobre 2005 parla apertamente della prospettiva di far convergere le forze verso un «partito democratico», anche per contrastare la tendenza che si apre con le riforma della legge elettorale in senso proporzionale, cucinata nel frattempo dal centro-destra al governo.Comincia un nuovo anno, un anno importantissimo perché in aprile, con le elezioni politiche, c’è la possibilità per l’Italia di chiudere col berlusconismo. Le speranze che questo accada sono tutte riposte nella capacità del centro-sinistra di presentarsi unito all’appuntamento. Non sembra vero, ma questo non è per nulla scontato. Nel gennaio 2006 Prodi rilancia la pressione per una convergenza. Marini della Margherita (ma non è il solo), pensa che Prodi abbia intenzione di rompere gli accordi e di presentarsi alle politiche con una lista propria, e avverte quindi: «Chi accelera troppo rischia di andare a sbattere». E Fassino precisa: «Il partito democratico si farà dopo le elezioni. Intanto, nulla impedisce che al Senato ci possa essere nei simboli dei Ds e della Margherita un comune riferimento all’Ulivo o a Prodi». Alla fine la mediazione è risicata: lista unica solo al Senato e liste diverse alla Camera «per sfruttare meglio il richiamo proporzionalistico». Una coalizione arcobaleno converge nell’Unione ma il «nocciolo duro» è ancora tutt’altro che solido. I risultati elettorali sono però indicativi: la lista unitaria dell’Ulivo al Senato si comporta molto meglio delle liste distinte alla Camera. Che sia la pressione decisiva che mancava? L’elettorato vuole l’unione?Dalle elezioni del 9 aprile 2006 il centrosinistra esce con una minuscola maggioranza, che gli assegna Palazzo Chigi, un sufficiente controllo della Camera e un situazione di quasi parità al Senato. Romano Prodi torna a immergersi nell’azione di governo, con tutte le due difficoltà e le sue tensioni: l’idea iniziale era che al governo partecipassero anche i segretari dei partiti, per rafforzarlo, ma il dibattito interno ai Ds ha deciso diversamente: c’è Rutelli ma non Fassino (c’è comunque D’Alema presidente dei Ds). Questo sul piano di una coalizione di governo ancora poco coesa, che cerca però di non ripetere gli errori del 1996-1998. Sul piano delle forze politiche, ora quasi tutti i leader di partito parlano di un Partito democratico dietro l’angolo: un partito nuovo, aperto alla società e al «popolo delle primarie». Pochi però specificano due aspetti: con quale modalità si realizzerà questa «apertura« e «per fare che cosa» nascerà il nuovo partito. Va poi rilevata una differenza terminologica: i Dl parlano di Partito democratico, i Ds di Partito democratico e riformista. Ancora una tensione sull’indirizzo di fondo da assumere?Dal convegno di Orvieto dei rappresentanti istituzionali dei diversi partiti (7-8 ottobre 2006) arriva la decisione di fare il Partito democratico, con alcune indicazioni sui modi e sui tempi. E siamo all’altroieri. Resta da capire come riusciranno i partiti tradizionali a dare vita a un partito la cui novità dovrebbe consistere proprio nel ridisegnare la mappa del potere dei partiti tradizionali. La storia insegna che innovazioni radicali hanno successo quando non esiste alternativa (o innovare o morire) e quando emerge un leader fortissimo. Abbiamo almeno una delle condizioni o ambedue disponibili?