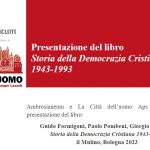Appunti 1_2007
Cristianesimo e modernità
Massimo Cacciari
Una riflessione sulla modernità, sull’Europa, sui rapporti tra cristianesimo e organizzazione politica e sui valori immanenti delle società contemporanee. Un pensatore non credente riflette sul punto di vista cristiano: il problema non è rivendicare «radici cristiane» dell’Europa, ma pensare l’Europa attuale nella luce di un rapporto con il cristianesimo che non può essere che contemporaneamente di contraddizione e di compromesso. Il testo nasce da una conversazione tenuta nel collegio Augustinianum dell’Università Cattolica di Milano.
La storia europea ruota da circa duemila anni attorno a una relazione essenziale, al «compromesso» tra cristianesimo e forme dell’organizzazione politica. Questo termine non va inteso come pasticcio o come mediazione al ribasso ma come la capacità di due diverse potenze di promettere qualcosa in comune, com-promissio. Di promettere assieme un fine comune. Non stiamo dunque ragionando di una relazione tra le tante, ma ragioniamo della relazione che costituisce l’Europa come problema. Perché l’Europa è un problema: non è qualcosa di definibile in senso geografico, non è qualcosa di definibile nel senso di una stabile, certa e ben fondabile tradizione culturale; l’Europa si definisce mediante compromessi, nel senso suddetto, ed è dunque costantemente un problema. Da oltre un secolo si discute della possibilità del compromesso, e non del vivacchiare insieme, tra cristianesimo e mondo moderno. Ma quali sono le caratteristiche del mondo moderno? Il mondo moderno nasce nella forma socio-economica del capitalismo ed è con questa forma che il cristianesimo cerca il compromesso.
La forma del moderno in Europa
Una prima caratteristica riguarda il modo in cui le grandi idee, i grandi valori (pulchrum, verum, bonum) diventano immanenti. Fino a Goethe e poco oltre quelle idee, quei valori, pur non avendo di per sé un significato propriamente teologico, apparivano come criteri fondanti rispetto all’agire. È nel rapporto di produzione che quei valori diventano immanenti: bello è questo oggetto perché è un possibile oggetto di scambio; buono è quanto rientra in determinate regole di comportamento; vero è quanto corrisponde all’oggetto, in quanto proposizione adeguata. Per dirlo in termini ancora diversi: occorre cercare il compromesso tra cristianesimo e un’epoca dominata da una «razionalità allo scopo», come diceva Max Weber. La razionalità allo scopo come unica forma efficace di razionalità, che dilaga dall’organizzazione burocratico-amministrativa propria dello Stato moderno ad ogni forma del fare.
Una seconda caratteristica è il crollo di quello che è proprio dell’Europa medioevale: la ricerca di un finalismo comune di tutte le espressioni culturali. Per circa un millennio, l’assillo dell’intelligentia europea è la costruzione di una gerarchia, nel senso di un ordine comune che sovrintendesse e fondasse tutte le diverse espressioni culturali. Questo finalismo comune viene rovesciato nel mondo moderno: noi oggi ricerchiamo e professiamo esattamente l’opposto, l’autonomia e la specializzazione della ricerca scientifica e di quella intellettuale. Questa autonomia ha avuto due tipi di conseguenze: la grande produttività ed efficienza della scienza e della tecnica e la grande incomunicabilità tra i diversi saperi. Linguisticamente, cioè, non c’è più comunicazione tra i saperi, ma questo è sia causa che effetto della specializzazione, senza la quale noi non potremmo più esistere. Una terza caratteristica, parallela alla precedente, è il venir meno anche del finalismo teologico: l’ordo amoris, come veniva definito da Agostino e da Tommaso. Tutte le discipline potevano costituire un’architettura comune in base ad un’idea di ordine fondato sull’amore, in cui i diversi gradi di amore coesistevano e si realizzavano fino all’amor Dei, apice e completamento di tutta l’architettura. Al finalismo comune culturale corrispondeva una visione ordinata e gerarchica di amore. C’era una perfetta analogia. L’autonomia moderna delle discipline scientifiche porta invece all’orizzontalità dei saperi: non viene più riconosciuto nulla al di sopra di essi, non esiste più un finalismo teologico. Un’ulteriore conseguenza è che non viene più riconosciuta nemmeno l’idea di gerarchia — idea cardine non solo della comune architettura delle discipline scientifiche nel Medioevo ma anche della organizzazione politica. Venuto meno il finalismo comune, la gerarchia oggi si fonda solo sull’occasionalità di rapporti di potenza. Che per definizione, in quanto occasionali, possono essere rovesciati.
È possibile un «compromesso» col moderno?
Se queste sono le caratteristiche del mondo moderno, quale compromesso è possibile col cristianesimo? Questa è la domanda drammatica anche di papa Giovanni Paolo II, quando affrontava il tema delle radici da indicare nella Costituzione europea. Il problema non è quello della «radice cristiana», che è evidente che ci sia, è una banale evidenza; il problema invece è se sia possibile un compromesso tra cristianesimo e modernità (radicalmente intesa).
Una prima risposta, negativa, viene da autori come Auerbach, teorico e storico dei dogmi della Chiesa e amico di Nietzsche, che già alla fine dell’800 diceva che il cristianesimo non può mai trasformarsi in cultura, in guida etica della comunità, essendo il suo ruolo quello di affermare la verità, non quello di essere un semplice sostegno del sentimento religioso.
Una seconda risposta prende le mosse dal termine kàtekon (colui che trattiene, mantiene), usato da Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi (a lui attribuita). Si può anche tradurre con «la forza che mantiene» e «trattiene» e impedisce quindi allo spirito della anomìa di diffondersi in modo prepotente. Le potenze che tendono a dissolvere l’Europa e la cristianità vengono trattenute da questa potenza. Il compromesso nel mondo moderno può ritrovarsi su questa base? Forse un cristianesimo che svolga una funzione «ritardante» rispetto alle potenze prepotenti della tecnica, della scienza, dell’economia, della cultura, della civiltà moderna così come descritta finora? A tale ruolo del kàtekon va ridotto il cristianesimo? Questa domanda è centrale, giacché spesso pare proprio che sia questa la funzione che il cristiano si assegna: guida etica, sostegno del sentimento religioso. Io ritengo questo, come anche Auerbach o Barth, un ruolo assolutamente contingente che non può essere in alcun modo quel compromesso che va ricercato.
Una terza prospettiva è quella tratteggiata da Scheler, verso il quale anche Woityla è debitore, secondo la quale il compromesso odierno va ricercato nell’affermazione di una scala di valori, nell’aggiornamento del discorso di ordine e di gerarchia del pensiero medioevale e scolastico. Questa scala però non è fondata su una base teologica trascendentale, i valori sono fondati culturalmente. Ne deriva che i valori non compresi nella scala sono non-valori, da trattare come nemici. L’idea fondamentale dell’universalismo cristiano è unum sumus: la pluralità è pluralità delle personalità, delle civiltà e delle culture, ed essa è escatologicamente unum. La proprietà essenziale del messaggio cristiano è che «molti» siano «uno» e che «uno» sia «molti». L’uno può essere anche un trascendens ineffabile, ma l’essenziale è concepire i molti in relazione all’uno. L’universalismo «illuministico» concepisce invece i «molti come molti» e, all’interno della sua scala, fa rientrare solo alcuni molti, ponendosi poi polemicamente verso i molti che non rientrano in quell’ordine. L’atteggiamento di giudizio è chiarissimo già in Kant e in tutto l’illuminismo: con i valori che non rientrano nella mia scala o mi pongo su un piano di scontro aggressivo e polemico oppure mi costituisco come giudice. La nostra scala di valori è il tribunale dei valori. Anche qui il compromesso cristiano non mi sembra possibile.
Contraddizione e compromesso stanno insieme
Allora, per concludere, come può essere tentato? Teniamo fermo che il compromesso implica sempre una forte dialetticità: esso non è affatto una stretta di mano! Basta guardare alla storia dell’Europa e della cristianità. Il compromesso matura con la tensione, e dunque il problema non è sedersi intorno a un tavolo e vedere un po’ la situazione. Intanto, per avere un compromesso occorre salvare un’idea, e questo non è affatto semplice. Il modernismo ci aveva rinunciato. Quale idea? L’assolutezza del cristianesimo! Se si rinuncia a questa idea allora il compromesso non sono altro che i Patti Lateranensi. Intendiamoci anche sul termine assolutezza: se significa la pretesa di regnare assolutamente sulle anime allora il compromesso non è possibile. Inoltre il cristianesimo dalla pretesa di assolutezza intesa in questo modo scivolerebbe inevitabilmente verso la dimensione della cultura, dell’etica, delle regole di comportamento. E questa è proprio la catastrofe che a mio avviso sta avvenendo. Come allora custodire l’idea di assolutezza, ma senza rinunce, perché ogni rinuncia è un arretramento che riproduce di nuovo l’idea del kàtekon, ritirarsi per resistere, ritardare?
Forse sulla linea di Kierkegaard e di Barth si può dare una risposta a questa questione. Solo vedendo il cristianesimo come segno di contraddizione si può rispondere a questa domanda. L’assolutezza del cristianesimo come segno irrinunciabile di contraddizione nel mondo moderno, un positivo segno di contraddizione. Non negare la contraddizione, ma mostrare una figura che porta in alto la contraddizione contro la coazione a sistema, ad un «uno» gnostico, a sistema che domina nel mondo contemporaneo in tutte le forme della sua globalizzazione. L’assolutezza del cristianesimo, lungi dall’essere la negazione della contraddizione e la pacificazione, è quell’agonia che dura fino alla fine dei tempi. Nessuna immanenza, nessuna negazione dell’ulteriorità, né nel senso dell’orizzontalità storica, né nel senso verticale di Abramo. Non accettare in alcun modo i presupposti dell’ermeneutica dello storicismo contemporaneo, cioè il mondo come connessione casuale di eventi, teatro di ogni possibile evento, eliminazione di ogni irruzione del trascendente. E questo lo si può dire in termini credenti o non credenti.
Il cristianesimo è assoluto, cioè non relativo. Da un lato il segno dell’anticristo: fare la grande pace, fare uno, fare sistema globale. Dall’altro la contraddizione, il segno dell’agonia. Questo segno è assoluto. Non può essere divorato in nessun processo storico e nello stesso tempo è profondamente storico, si rappresenta sempre storicamente. Quindi assolutezza e compromesso col mondo. Questo compromesso non è quello che si limita a negare la validità dell’organizzazione politica mondana, ma è ciò che si compromette con tale organizzazione per cercare di darle senso, di donarle senso. Ma cercare in questa direzione vuol dire essere segno di contraddizione e pretendere di esserlo, fino alla fine dei giorni, assolutamente, non localmente. Contemporaneamente vuol dire anche segno di contraddizione che vive nel mondo e non vi rifugge, né cerca di vederlo gnosticamente come male, cioè di vedere come sarebbe bello se non ci fosse. Questo richiede l’essere chiari e radicali: liberare il campo da ogni tentativo di compromesso sul piano puramente culturale ed etico, dalle ricerche di compromesso quotidiano, che sono proprio quelle che a mio avviso si stanno praticando. Perché io, che non sono credente, sono così vitalmente interessato a questo? Perché veramente, e lo confesso, non vedo altra energia oggi in grado di essere segno di contraddizione rispetto a quel moderno che è sempre più liberale e, per usare un’espressione di Max Weber, sta sempre più assomigliando a una gabbia d’acciaio.
La storia europea ruota da circa duemila anni attorno a una relazione essenziale, al «compromesso» tra cristianesimo e forme dell’organizzazione politica. Questo termine non va inteso come pasticcio o come mediazione al ribasso ma come la capacità di due diverse potenze di promettere qualcosa in comune, com-promissio. Di promettere assieme un fine comune. Non stiamo dunque ragionando di una relazione tra le tante, ma ragioniamo della relazione che costituisce l’Europa come problema. Perché l’Europa è un problema: non è qualcosa di definibile in senso geografico, non è qualcosa di definibile nel senso di una stabile, certa e ben fondabile tradizione culturale; l’Europa si definisce mediante compromessi, nel senso suddetto, ed è dunque costantemente un problema. Da oltre un secolo si discute della possibilità del compromesso, e non del vivacchiare insieme, tra cristianesimo e mondo moderno. Ma quali sono le caratteristiche del mondo moderno? Il mondo moderno nasce nella forma socio-economica del capitalismo ed è con questa forma che il cristianesimo cerca il compromesso.
La forma del moderno in Europa
Una prima caratteristica riguarda il modo in cui le grandi idee, i grandi valori (pulchrum, verum, bonum) diventano immanenti. Fino a Goethe e poco oltre quelle idee, quei valori, pur non avendo di per sé un significato propriamente teologico, apparivano come criteri fondanti rispetto all’agire. È nel rapporto di produzione che quei valori diventano immanenti: bello è questo oggetto perché è un possibile oggetto di scambio; buono è quanto rientra in determinate regole di comportamento; vero è quanto corrisponde all’oggetto, in quanto proposizione adeguata. Per dirlo in termini ancora diversi: occorre cercare il compromesso tra cristianesimo e un’epoca dominata da una «razionalità allo scopo», come diceva Max Weber. La razionalità allo scopo come unica forma efficace di razionalità, che dilaga dall’organizzazione burocratico-amministrativa propria dello Stato moderno ad ogni forma del fare.
Una seconda caratteristica è il crollo di quello che è proprio dell’Europa medioevale: la ricerca di un finalismo comune di tutte le espressioni culturali. Per circa un millennio, l’assillo dell’intelligentia europea è la costruzione di una gerarchia, nel senso di un ordine comune che sovrintendesse e fondasse tutte le diverse espressioni culturali. Questo finalismo comune viene rovesciato nel mondo moderno: noi oggi ricerchiamo e professiamo esattamente l’opposto, l’autonomia e la specializzazione della ricerca scientifica e di quella intellettuale. Questa autonomia ha avuto due tipi di conseguenze: la grande produttività ed efficienza della scienza e della tecnica e la grande incomunicabilità tra i diversi saperi. Linguisticamente, cioè, non c’è più comunicazione tra i saperi, ma questo è sia causa che effetto della specializzazione, senza la quale noi non potremmo più esistere. Una terza caratteristica, parallela alla precedente, è il venir meno anche del finalismo teologico: l’ordo amoris, come veniva definito da Agostino e da Tommaso. Tutte le discipline potevano costituire un’architettura comune in base ad un’idea di ordine fondato sull’amore, in cui i diversi gradi di amore coesistevano e si realizzavano fino all’amor Dei, apice e completamento di tutta l’architettura. Al finalismo comune culturale corrispondeva una visione ordinata e gerarchica di amore. C’era una perfetta analogia. L’autonomia moderna delle discipline scientifiche porta invece all’orizzontalità dei saperi: non viene più riconosciuto nulla al di sopra di essi, non esiste più un finalismo teologico. Un’ulteriore conseguenza è che non viene più riconosciuta nemmeno l’idea di gerarchia — idea cardine non solo della comune architettura delle discipline scientifiche nel Medioevo ma anche della organizzazione politica. Venuto meno il finalismo comune, la gerarchia oggi si fonda solo sull’occasionalità di rapporti di potenza. Che per definizione, in quanto occasionali, possono essere rovesciati.
È possibile un «compromesso» col moderno?
Se queste sono le caratteristiche del mondo moderno, quale compromesso è possibile col cristianesimo? Questa è la domanda drammatica anche di papa Giovanni Paolo II, quando affrontava il tema delle radici da indicare nella Costituzione europea. Il problema non è quello della «radice cristiana», che è evidente che ci sia, è una banale evidenza; il problema invece è se sia possibile un compromesso tra cristianesimo e modernità (radicalmente intesa).
Una prima risposta, negativa, viene da autori come Auerbach, teorico e storico dei dogmi della Chiesa e amico di Nietzsche, che già alla fine dell’800 diceva che il cristianesimo non può mai trasformarsi in cultura, in guida etica della comunità, essendo il suo ruolo quello di affermare la verità, non quello di essere un semplice sostegno del sentimento religioso.
Una seconda risposta prende le mosse dal termine kàtekon (colui che trattiene, mantiene), usato da Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi (a lui attribuita). Si può anche tradurre con «la forza che mantiene» e «trattiene» e impedisce quindi allo spirito della anomìa di diffondersi in modo prepotente. Le potenze che tendono a dissolvere l’Europa e la cristianità vengono trattenute da questa potenza. Il compromesso nel mondo moderno può ritrovarsi su questa base? Forse un cristianesimo che svolga una funzione «ritardante» rispetto alle potenze prepotenti della tecnica, della scienza, dell’economia, della cultura, della civiltà moderna così come descritta finora? A tale ruolo del kàtekon va ridotto il cristianesimo? Questa domanda è centrale, giacché spesso pare proprio che sia questa la funzione che il cristiano si assegna: guida etica, sostegno del sentimento religioso. Io ritengo questo, come anche Auerbach o Barth, un ruolo assolutamente contingente che non può essere in alcun modo quel compromesso che va ricercato.
Una terza prospettiva è quella tratteggiata da Scheler, verso il quale anche Woityla è debitore, secondo la quale il compromesso odierno va ricercato nell’affermazione di una scala di valori, nell’aggiornamento del discorso di ordine e di gerarchia del pensiero medioevale e scolastico. Questa scala però non è fondata su una base teologica trascendentale, i valori sono fondati culturalmente. Ne deriva che i valori non compresi nella scala sono non-valori, da trattare come nemici. L’idea fondamentale dell’universalismo cristiano è unum sumus: la pluralità è pluralità delle personalità, delle civiltà e delle culture, ed essa è escatologicamente unum. La proprietà essenziale del messaggio cristiano è che «molti» siano «uno» e che «uno» sia «molti». L’uno può essere anche un trascendens ineffabile, ma l’essenziale è concepire i molti in relazione all’uno. L’universalismo «illuministico» concepisce invece i «molti come molti» e, all’interno della sua scala, fa rientrare solo alcuni molti, ponendosi poi polemicamente verso i molti che non rientrano in quell’ordine. L’atteggiamento di giudizio è chiarissimo già in Kant e in tutto l’illuminismo: con i valori che non rientrano nella mia scala o mi pongo su un piano di scontro aggressivo e polemico oppure mi costituisco come giudice. La nostra scala di valori è il tribunale dei valori. Anche qui il compromesso cristiano non mi sembra possibile.
Contraddizione e compromesso stanno insieme
Allora, per concludere, come può essere tentato? Teniamo fermo che il compromesso implica sempre una forte dialetticità: esso non è affatto una stretta di mano! Basta guardare alla storia dell’Europa e della cristianità. Il compromesso matura con la tensione, e dunque il problema non è sedersi intorno a un tavolo e vedere un po’ la situazione. Intanto, per avere un compromesso occorre salvare un’idea, e questo non è affatto semplice. Il modernismo ci aveva rinunciato. Quale idea? L’assolutezza del cristianesimo! Se si rinuncia a questa idea allora il compromesso non sono altro che i Patti Lateranensi. Intendiamoci anche sul termine assolutezza: se significa la pretesa di regnare assolutamente sulle anime allora il compromesso non è possibile. Inoltre il cristianesimo dalla pretesa di assolutezza intesa in questo modo scivolerebbe inevitabilmente verso la dimensione della cultura, dell’etica, delle regole di comportamento. E questa è proprio la catastrofe che a mio avviso sta avvenendo. Come allora custodire l’idea di assolutezza, ma senza rinunce, perché ogni rinuncia è un arretramento che riproduce di nuovo l’idea del kàtekon, ritirarsi per resistere, ritardare?
Forse sulla linea di Kierkegaard e di Barth si può dare una risposta a questa questione. Solo vedendo il cristianesimo come segno di contraddizione si può rispondere a questa domanda. L’assolutezza del cristianesimo come segno irrinunciabile di contraddizione nel mondo moderno, un positivo segno di contraddizione. Non negare la contraddizione, ma mostrare una figura che porta in alto la contraddizione contro la coazione a sistema, ad un «uno» gnostico, a sistema che domina nel mondo contemporaneo in tutte le forme della sua globalizzazione. L’assolutezza del cristianesimo, lungi dall’essere la negazione della contraddizione e la pacificazione, è quell’agonia che dura fino alla fine dei tempi. Nessuna immanenza, nessuna negazione dell’ulteriorità, né nel senso dell’orizzontalità storica, né nel senso verticale di Abramo. Non accettare in alcun modo i presupposti dell’ermeneutica dello storicismo contemporaneo, cioè il mondo come connessione casuale di eventi, teatro di ogni possibile evento, eliminazione di ogni irruzione del trascendente. E questo lo si può dire in termini credenti o non credenti.
Il cristianesimo è assoluto, cioè non relativo. Da un lato il segno dell’anticristo: fare la grande pace, fare uno, fare sistema globale. Dall’altro la contraddizione, il segno dell’agonia. Questo segno è assoluto. Non può essere divorato in nessun processo storico e nello stesso tempo è profondamente storico, si rappresenta sempre storicamente. Quindi assolutezza e compromesso col mondo. Questo compromesso non è quello che si limita a negare la validità dell’organizzazione politica mondana, ma è ciò che si compromette con tale organizzazione per cercare di darle senso, di donarle senso. Ma cercare in questa direzione vuol dire essere segno di contraddizione e pretendere di esserlo, fino alla fine dei giorni, assolutamente, non localmente. Contemporaneamente vuol dire anche segno di contraddizione che vive nel mondo e non vi rifugge, né cerca di vederlo gnosticamente come male, cioè di vedere come sarebbe bello se non ci fosse. Questo richiede l’essere chiari e radicali: liberare il campo da ogni tentativo di compromesso sul piano puramente culturale ed etico, dalle ricerche di compromesso quotidiano, che sono proprio quelle che a mio avviso si stanno praticando. Perché io, che non sono credente, sono così vitalmente interessato a questo? Perché veramente, e lo confesso, non vedo altra energia oggi in grado di essere segno di contraddizione rispetto a quel moderno che è sempre più liberale e, per usare un’espressione di Max Weber, sta sempre più assomigliando a una gabbia d’acciaio.