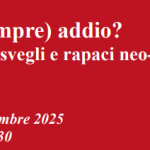Una riforma costituzionale sbagliata e molto rischiosa (20 novembre 2004)
Il centro-destra al governo ha infine varato la «sua» riforma della Costituzione. Il progetto di legge costituzionale approvato dalla Camera il 15 ottobre scorso, in prima lettura (il che vuol dire che dovrebbe passare ancora due volte al Senato e, infine, un’ulteriore approvazione alla Camera, prima di entrare in vigore), chiude provvisoriamente un lungo periodo di discussioni accese e sembra rappresentare un punto d’incontro tra le diverse anime della maggioranza, che si sono trovate più volte ed aspramente divise su questi problemi. Naturalmente, per l’importanza dell’occasione e per la radicalità di alcuni ritocchi apportati al testo della Costituzione del 1948 (nella sua seconda parte ordinamentale), tale riforma merita una valutazione complessiva.
1. Un problema di metodo: lo «spirito costituente».
Il primo problema è di metodo. Esiste oggi un «clima costituente» nel paese e nelle istituzioni? C’è una maturazione progressiva dell’esigenza di cambiare gli assetti consolidati? Sono state rispettate le procedure e le attenzioni necessarie per un passaggio di tale rilevanza? E’ difficile dare una risposta positiva a queste domande. Infatti, che il tema della riforma della nostra costituzione fosse all’ordine del giorno da anni è ovvio, ma non basta la lunga attesa del cambiamento per legittimare ogni decisione. Non occorre infatti essere conservatori per condividere una visione della costituzione come armonico intreccio di valori, principi e regole che stanno al di sopra della normale dialettica politica e sono patrimonio di un paese nella sua sostanziale globalità, se non proprio nella sua aritmetica interezza. Tale piattaforma solida ha senso nella misura in cui è stabile e riconosciuta, non se insegue improbabili continue modernizzazioni. Ora, tale patrimonio può senz’altro essere adeguato e aggiornato progressivamente al mutare del consenso sociale su obiettivi e regole della convivenza, ma non è bene che sia esposto alle bufere della polemica politica, o peggio sia considerato come semplice parte delle spoglie del vincitore della competizione elettorale, diventando oggetto di cambiamento partigiano ad ogni tornata elettorale, attraverso veri e propri Diktat di maggioranza. In realtà, questa riforma introduce soluzioni altamente controverse su punti decisivi delle regole democratiche, tramite plurimi compromessi raggiunti con fatica all’interno della stessa maggioranza parlamentare e tagliando invece fuori del tutto l’opposizione. E’ quindi arduo dire che la ponderatezza del dibattito abbia configurato un vero «clima costituente».
Ora, è senz’altro vero che l’attuale maggioranza può rivendicare un precedente: la riforma del titolo V della costituzione (riguardante le autonomie regionali e locali), approvata dalla precedente maggioranza di centro sinistra in modo bloccato e con un margine ristretto alla fine dell’ultima legislatura. Quella, a nostro parere, fu una forzatura, dal punto di vista della corretta prassi costituzionale, anche se aveva due attenuanti non irrilevanti: le riforme introdotte erano simili a quelle su cui era stato trovato un accordo trasversale nella vecchia commissione bicamerale per le riforme e tra i c.d. governatori delle regioni, molti dei quali eletti dall’allora opposizione, e inoltre il centro-destra vi si opponeva accusandole di troppa timidezza, non di radicalità o di squilibrio. Per cui la maggioranza di centro-sinistra ebbe buon gioco (e qualche ragione) nel sostenere di non aver fatto nessuno «sbrego» al tessuto costituzionale condiviso, ma di aver semmai solo iniziato un percorso, per non lasciare insoddisfatto il bisogno di riforme, su un punto che non era controverso nella sostanza e nella direzione (anche se magari era discutibile nella forma e nell’estensione). Oggi palesemente non è più così: si apre un conflitto aspro attorno a regole duramente controverse.
2. La questione basilare del federalismo.
Il primo carattere dell’attuale riforma è stata l’ulteriore modifica del suddetto titolo V, rivendicata a gran voce soprattutto dalla Lega Nord come realizzazione alfine raggiunta del «federalismo», al di là appunto dei limitati interventi della precedente riforma. Non è mistero che intorno alla «devoluzione» (anglicismo a cui abbiamo dovuto abituarci) alle Regioni delle competenze legislative in alcuni campi, il partito di Bossi abbia condotto una battaglia identitaria senza esclusione di colpi. In termini specifici, la modificazione non è stata radicale, in quanto la ridefinizione delle competenze legislative era appunto già stata il perno dell’innovazione del 2001: essa fissava alcune materie di competenza esclusiva dello Stato e alcune di competenza concorrente, lasciando alle Regioni tutto il rimanente campo legislativo (e rovesciando così in senso federale l’impostazione costituzionale originaria). La riforma attuale si limita in quest’ottica ad aggiungere alle materie «esclusivamente regionali» alcuni capitoli, non secondari ma nemmeno rivoluzionari: «a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale». Si aggiunga il fatto che vengono riconfermate le norme sulla possibilità del governo di sostituire le strutture amministrative locali quando siano in gioco questioni generali di equilibrio finanziario o di rispetto di accordi internazionali, e che si introduce un ulteriore articolo che prevede che il governo possa far abrogare dal parlamento una legge regionale giudicata in contrasto con «l'interesse nazionale della Repubblica». Insomma, gli spazi delle autonomie locali non sono drasticamente modificati o ampliati rispetto alla riforma targata centro/sinistra. Certo sollevano qualche dubbio le competenze esclusive regionali in materia di sanità (potremo avere una sanità arlecchino con disparità di trattamenti a seconda delle Regioni), mentre la vaghezza del riferimento alla parte dei programmi scolastici di interesse regionale lascia prevedere che ci saranno infinite controversie. Tra l’altro, merita notare che si è citata con grande enfasi la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà: sia la sussidiarietà tra gli enti della Repubblica che il favore verso le libere iniziative dei cittadini erano già fissate a chiare (anche se dal nostro punto di vista tutt’altro che convincenti) lettere nella riforma del 2001.
3. Il nuovo bicameralismo.
Collegata al modesto ampliamento del federalismo è la ristrutturazione del tradizionale bicameralismo perfetto della nostra costituzione: due Camere parallele, con funzioni legislative sovrapposte e paritarie. Si sono invece modificate profondamente sia la formazione del Senato che le competenze legislative dei due rami del Parlamento. In realtà il Senato che risulta dalla riforma è «federale» solo di nome, in quanto non rappresenta direttamente le autonomie locali e i loro interessi, come nei modelli federali classici. Viene infatti eletto a suffragio universale, su base regionale, in tempi però concomitanti all’elezione dei rispettivi consigli regionali. Su questa base, dovrebbe rispecchiare più direttamente le opinioni locali. Avrebbe poi competenze diverse da quelle della Camera, che resta l’unica Camera «politica» (implicata nella fiducia al governo, come vedremo in seguito). Inoltre, la Camera legifererà sulle materie di esclusiva competenza statale, il Senato su quelle concorrenti (e su ogni legge di questo tipo, l’altra Camera potrà solo chiedere modifiche senza possibilità di veto). Esiste però un tipo di leggi, quelle relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oppure la legislazione elettorale locale, su cui Senato e Camera legiferano alla pari. Ma se non trovano l'accordo su testo entra in campo una terza assemblea «derivata», i cui 60 componenti sono indicati dai presidenti delle due Camere: questa Camera di compensazione avrà il compito di scrivere un testo unificato dal sottoporre al voto di Senato e Camera. Insomma, la modifica del bicameralismo perfetto, auspicata da più parti, è intervenuta, ma i processi di formazione delle leggi rischiano ancora di essere farraginosi e complessi.
4. Il primo ministro e i suoi poteri.
Il punto più delicato della riforma è sicuramente la nuova normativa sul governo e sul suo capo, il primo ministro. Questa figura è innanzitutto nuova nel nostro ordinamento costituzionale e risulta fortemente accresciuta nei suoi poteri, tanto da suscitare aperte perplessità per la forzatura della classica forma di governo parlamentare. Intanto, il primo ministro è di fatto eletto direttamente, in quanto ogni candidato o lista di candidati alla Camera (la cui legge elettorale è previsto agevoli la formazione di una maggioranza), si collegherà a un candidato alla guida del governo. Sulla base del risultato elettorale il Presidente della Repubblica nomina primo ministro il candidato della coalizione vincente. La Camera non deve più votare la fiducia, ma si esprime solo con un voto sul programma. Il primo ministro è un vero capo del governo, determina (e non più soltanto «dirige») la politica dell'esecutivo, ha il potere di nomina e revoca dei ministri e di chiedere sempre la fiducia della Camera e la priorità sulle cosiddette leggi di programma. Il primo ministro può chiedere quando voglia e senza limiti al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera. Se egli venisse sfiduciato, invece, la Camera stessa sarebbe sciolta e si andrebbe a nuove elezioni: questo vincolo naturalmente indebolisce di molto l’autonomia del parlamento e dei singoli deputati (il paragone con i consigli regionali, in nome della stabilità dell’esecutivo, appare molto forzato). Unica eccezione a questa regola del simul stabunt, simul cadent si verificherebbe se la Camera votasse la fiducia a un nuovo primo ministro, peraltro con voti provenienti dalla sola e medesima maggioranza elettorale: si tratta di una versione assai limitata e orientata della cosiddetta «sfiducia costruttiva». In parallelo, la mozione di sfiducia al primo ministro non può essere respinta con il voto determinante di membri dell’opposizione (è la cosiddetta norma «antiribaltone»): nel qual caso, la Camera verrebbe ugualmente sciolta. In sintesi: il primo ministro può essere sostituito solo dalla concordanza della quasi totalità della maggioranza politica uscita dalle elezioni. Gli basterebbe conservare il sostegno di un piccolo manipolo di fedeli della sua vecchia maggioranza per «tirare a campare» anche in palese conflitto con la propria coalizione elettorale. Si può veramente parlare di «premierato assoluto», come è stato definito da Leopoldo Elia, in una formulazione tutt’altro che consueta nei paesi di solida tradizione democratica. L’aspetto più problematico di queste norme appare poi la svalutazione totale del Parlamento, a partire dal fatto che, per principio, fin dal momento delle elezioni, si configurerebbe una distinzione dei parlamentari tra maggioranza e opposizione, tale da privare il secondo gruppo di ogni potere reale di controllo e orientamento.
5. Una riforma ad effetti ritardati.
E’ interessante notare che la riforma prevede un meccanismo dilazionato di entrata in vigore, certamente introdotto per superare le resistenze del ceto politico a misure percepite come punitive. Ad esempio, il numero di deputati e senatori si riduce, sia pure moderatamente (i deputati scendono da 630 a 500, i senatori da 315 a 252), ma la norma entrerà in vigore solo nella seconda legislatura dopo l’eventuale approvazione del referendum e dunque non prima del 2011. La stessa elezione del Senato federale slitterà alla legislatura successiva all’approvazione, così come il procedimento di formazione delle leggi. Insomma, una clausola di salvaguardia che mira a ammorbidire le resistenze dell’attuale composizione della rappresentanza, la quale teme fortemente di essere colpita dalla riduzione dei propri organici.
6. Gli organi di garanzia mortificati.
L’altro punto critico della riforma è quello relativo agli organi di garanzia. In complesso, c’è una tendenza alla riduzione dei contrappesi rispetto alla funzione di guida politica, che non può che apparire problematica. Unica norma che riteniamo positiva in questo caso, la previsione di affidare a membri dell’opposizione la presidenza delle commissioni parlamentari di controllo o di inchiesta. Il Presidente della Repubblica esce invece fortemente ridotto nei suoi poteri, essendo stato espropriato delle funzioni di garanzia della forma parlamentare di governo, con la sottrazione del potere di scioglimento e di quello della nomina del primo ministro. Tra l’altro i quorum per la sua elezione restano alti solo nelle prime votazioni e lo stesso accade per i Presidenti dei due rami del Parlamento. E’ quindi molto facile che tutti e tre le alte cariche rispecchino fedelmente l’orientamento della maggioranza politica. E questo rende più discutibile il fatto che al Presidente della Repubblica sia attribuito il compito di nominare il vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura, che non sarebbe più elettivo. Altre gravi problematiche sollevano le previsioni per la Corte costituzionale, i cui quindici membri sarebbero molto più politicizzati, in quanto ben sette di loro sarebbero di nomina politica (quattro dal Senato federale e tre dalla Camera), contro gli attuali cinque su quindici.
Concludendo, si tratta di una riforma fortemente criticabile e rischiosa su molti dei suoi aspetti fondamentali. Troppo contrassegnata dalla volontà dell’attuale maggioranza politica, essa si presenta a tratti come la semplice giustapposizione e sistemazione delle richieste delle singole forze che la compongono, in un collage politico dal dubbio spessore complessivo. Dove più marcato è l’orientamento riformatore, il risultato appare problematico, se non pericoloso, soprattutto là dove enfatizza la figura del primo ministro, con una concentrazione di poteri non riscontrabile in altri modelli democratici e parlamentari, e con la parallela restrizione delle attribuzioni e del ruolo che spettano agli organismi di controllo e garanzia.
20 novembre 2004