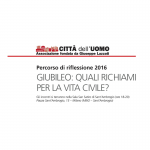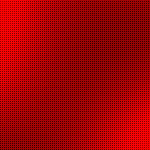Il ritorno della questione pensionistica (8 dicembre 1999)
L’autunno incombe, la legge finanziaria è alle porte e importanti scadenze di politica economica attendono l’Italia all’indomani dell’ingresso nella moneta unica europea. In questo contesto, si è ricominciato a discutere con molta enfasi di pensioni, come se rappresentassero la più importante emergenza italiana. Più di una voce, sia all’interno del paese (non ultimo lo stesso Governatore della Banca d’Italia) che in autorevoli organismi internazionali, dal Fondo monetario internazionale all’Ocse, ha invocato nuovi interventi strutturali di riforma. Il susseguirsi di appelli e mosse tattiche porta con sé forti incertezze. La questione delle pensioni negli ultimi anni è stata spesso al centro della vita economica e politica italiana e coinvolge molti altri problemi. In questo senso ce ne occupiamo, per chiarire alcune impostazioni di fondo.
1. Le pressioni finanziarie sul sistema previdenziale
Il nostro paese negli ultimi anni ha compiuto sacrifici per il risanamento finanziario, accelerati dalla necessità di rispettare i parametri di convergenza imposti dal Trattato di Maastricht e figurare tra i soci fondatori della moneta europea. Le esigenze europee hanno imposto una logica dei due tempi (prima il risanamento, poi lo sviluppo). L’Italia non ha però risolto tutti i suoi problemi di equilibrio. Ciò, per un verso, impone di continuare a migliorare i conti pubblici, ma per l’altro sottrae risorse allo sviluppo, in quanto una parte delle entrate dovrà essere destinata alla riduzione dell’enorme debito pubblico accumulato. Le politiche di bilancio finalizzate a realizzare forti avanzi primari, al netto degli interessi sul debito, non possono non avere conseguenze sulla spesa sociale.
Non si può ignorare che la spesa sociale italiana, in rapporto al prodotto interno lordo, è tra le più basse in Europa (quattro punti percentuali in meno rispetto alla media). D’altro canto, la previdenza ne rappresenta una parte consistente: attorno al 60% secondo stime europee (che andrebbero però corrette al ribasso per i metodi di calcolo non omogenei usati nei diversi paesi). Per tale motivo, la manovra sulle pensioni torna al centro dell’attenzione politica. Appare come una possibilità unica di liberare risorse. Siamo di fronte a una vicenda emblematica: il diffuso clima di «realismo» che avvolge ormai la politica condiziona ogni scelta, richiamandosi sempre a vincoli di natura economica e finanziaria. Anche le scelte più delicate, come la riforma dello Stato sociale, malgrado evochino temi decisivi per la qualità della convivenza, si appiattiscono su questi soli parametri.
2. Oltre l’aspetto finanziario: le pensioni sono già state riformate
Va invece riaffermato che gli aspetti finanziari, se costituiscono oggettivi vincoli di una politica economica generale, non possono essere considerati in termini asettici. Ogni scelta di tagli e sacrifici è politicamente e socialmente non neutrale e, quindi, va discussa in un quadro strutturale più generale. Da questo punto di vista, va ricordato che il nostro sistema previdenziale pubblico è stato oggetto di diverse riforme negli anni ʼ90, che hanno mirato a riportarlo in equilibrio sia sul piano finanziario che su quello dell’equità sociale, pur restando purtroppo sganciate da un ridisegno generale del Welfare.
La svolta della previdenza italiana è arrivata nel ʼ95 con la riforma Dini, che con l’introduzione del metodo di calcolo contributivo – che commisura la prestazione pensionistica alla contribuzione effettivamente versata nella vita lavorativa – almeno per i lavoratori che avevano meno di 18 anni di contributi, ha teso a razionalizzare la spesa pensionistica pubblica. Ha fissato quindi per tutti i lavoratori un unico criterio di calcolo delle pensioni, introducendo inoltre un criterio flessibile nel determinare i tempi dell’uscita dal lavoro. Il metodo contributivo scoraggia l’evasione contributiva (che era in precedenza una pratica clamorosamente diffusa) e sottrae la spesa previdenziale alle incursioni politiche e sindacali su base particolaristica, patologia non ultima responsabile degli squilibri passati, dato che si erano andati moltiplicando, con il precedente sistema retributivo, diversi regimi pensionistici e una serie di privilegi.
Ora, non tutto è sanato. Ci sono fondi pensionistici settoriali in grave squilibrio, proprio per i deficit accumulati nel tempo. In termini finanziari globali, occorre la verifica della tenuta del sistema previdenziale pubblico nel medio periodo, visto che negli anni 2005-2015, come affermano alcuni esperti, l’uscita contemporanea dal lavoro delle generazioni del baby boom potrebbe portare a una certa difficoltà (si è parlato di una «gobba» nella curva della spesa pensionistica prevista rispetto alla ricchezza del paese). Sebbene importanti, tali aspetti non richiedono tuttavia alcun approccio allarmistico e, perciò, ogni ipotesi di intervento urgente sulle pensioni non può che risultare sospetto, oltreché iniquo. Infatti lo Stato deve rispettare i patti con i cittadini, che prevedevano una verifica del sistema non prima del 2001: non si può pensare a una grossa riforma sulle pensioni a ogni piè sospinto, che creerebbe tra l’altro contraccolpi di natura sociale, aprendo anche la strada a nuove e non desiderabili rincorse salariali.
3. Il falso problema delle pensioni di anzianità
Malgrado riforme così radicali, si ritorna ciclicamente a parlare del superamento dell’istituto delle pensioni «di anzianità». Va ricordato che i casi più eclatanti in materia – presenti soprattutto nel sistema pubblico con le famose pensioni baby, erogate dopo soli quindici o vent’anni di lavoro – sono stati di fatto ormai cancellati, ma l’istituto è ancora criticato. Da un lato, infatti, le pensioni di anzianità vengono considerate un onere insostenibile per la collettività – soprattutto a motivo dell’allungamento della vita media della popolazione –, dall’altro configurano un privilegio non disponibile per le nuove generazioni, che dovranno lavorare di più per maturare il diritto alla pensione. Non dimentichiamo però che in molti casi questa formula risponde a problemi reali («se 35 anni di fonderia vi sembrano pochi…»). Inoltre, va considerato che le pensioni di anzianità tendono ormai a scomparire fisiologicamente, data la sempre più elevata età d’ingresso dei lavoratori giovani nel sistema produttivo.
Ma il problema è più generale: siamo qui in presenza di un aspetto specifico del sistema di Welfare italiano. Sulla previdenza si è infatti caricata nel tempo una notevole serie di ragioni assistenziali, a beneficio del patto sociale complessivo. In moltissimi casi, in particolare nel settore industriale, pensioni di anzianità e prepensionamenti hanno funzionato come un vero e proprio ammortizzatore sociale, favorendo l’uscita delle persone dal lavoro e agevolando le imprese nei processi di ristrutturazione. Allo stesso modo, il sistema pensionistico è stato un formidabile strumento di redistribuzione del reddito nelle aree svantaggiate a favore delle famiglie e dei giovani sia attraverso le pensioni di anzianità di genitori e nonni sia attraverso le pensioni di invalidità, che, come è stato detto, hanno rappresentato per anni il più grande programma di lotta alla povertà nel nostro paese. Appare logico perciò, anche se non sembra politicamente scontato, che qualsiasi ulteriore riforma di questo istituto debba venire dopo un riassetto complessivo delle politiche sociali, che configuri modelli diversi di sostegno alle persone in difficoltà in diversi momenti del ciclo vitale e lavorativo.
4. Efficienza ed equità tra le generazioni: il futuro della previdenza pubblica obbligatoria
Viene però il sospetto che il continuo ritorno del problema pensionistico nel dibattito pubblico voglia in realtà mirare ad altro: screditare allarmisticamente il sistema previdenziale pubblico obbligatorio, in nome di una visione drasticamente neoliberista. Si aprirebbe così la strada a una previdenza sostanzialmente e totalmente privata, impostata sulla capitalizzazione dei liberi versamenti dei singoli lavoratori. Il leader democristiano tedesco Schäuble ha parlato, ad esempio, delle pensioni come di un «sistema collettivo di coercizione». Siamo del parere che occorra invece difendere l’impianto a ripartizione tipico del sistema pubblico, soprattutto per confermare un legame di solidarietà tra le generazioni: una parte della ricchezza prodotta dai lavoratori attivi dovrebbe continuare a essere trasferita ai pensionati, che a loro tempo hanno fornito lo stesso contributo. E lo Stato non può abdicare al compito di essere garante di questo patto. Certo, su questa base pubblica è giusto innestare meccanismi complementari volontari o addirittura individuali, ma non pare accettabile azzerare tutto in nome della libertà del singolo lavoratore.
Una difesa intelligente del sistema non può però dimenticare che restano alcune grosse questioni da affrontarsi. L’eliminazione dei restanti privilegi non è solo una questione moralistica: esistono le cosiddette «pensioni d’oro», cioè trattamenti altissimi che sono frutto di artifici legislativi e non di un rapporto effettivo alla contribuzione versata (cosa che sarebbe ovviamente accettabile). Tali situazioni sono sempre più insopportabili a fronte dei sacrifici di molti redditi bassi e medi. Oggi si discute solo di un modesto «contributo di solidarietà» e non di un vero e proprio «tetto» quantitativo alle pensioni, come sarebbe auspicabile. Regimi particolari, sopravvissuti per alcune categorie forti, sono incoerenti con gli appelli al rigore. Occorre poi introdurre misure di solidarietà a favore di quei lavoratori con carriere discontinue e frammentate, che con il sistema contributivo non potranno godere di pensioni adeguate. Ci sono ancora problemi burocratici di attuazione senza ritardi del diritto maturato alla pensione per molte persone tra le più svantaggiate (ritardi e complicazioni non sono purtroppo affatto scomparsi).
Sono soprattutto necessari interventi correttivi volti a realizzare una maggiore equità intergenerazionale, dato che la transizione dal vecchio al nuovo sistema darà alle nuove generazioni – quelle che nel 1995 non avevano ancora maturato 18 anni di contribuzione – pensioni meno alte per contributi analoghi versati. In compenso, viene loro offerta la possibilità della previdenza complementare, che è però a carattere volontario (e proprio i lavoratori più giovani hanno fin qui scarsamente praticato tale opportunità, perché più interessati a investire nel presente il non elevato reddito disponibile). In questo senso, per altro, il discorso non può risolversi solo nel quadro previdenziale. Si deve necessariamente allargare all’insieme delle politiche sociali: i «figli» reclamano giustamente la loro parte di benefici collettivi. Togliere ai «padri», nel senso di ridurre la spesa pensionistica totale, è già stata un’operazione compiuta: una chiara contropartita va però ora prevista per le giovani generazioni. Su questo punto, in particolare, il sindacato sarebbe chiamato a maggiore inventiva e creatività, superando la semplice posizione difensiva che troppe volte assume nei dibattiti sulla riforma del Welfare.
5. Non assistenzialismo ma promozione della cittadinanza: riprogettare le politiche sociali
Indubbiamente, lo Stato sociale, così come l’abbiamo conosciuto, non è più sostenibile, soprattutto sul piano dell’efficacia delle tutele, in quanto risponde a una domanda di cittadinanza nata in un altro contesto storico e modellata su figure sociali omogenee – maschio adulto e capofamiglia – tipiche della cosiddetta società fordista. Le trasformazioni strutturali dell’economia, la mutazione del mercato del lavoro (afflusso delle donne, sensibile aumento delle figure professionali atipiche e del lavoro indipendente), l’evoluzione della famiglia, le dinamiche demografiche negative e l’aumento della vita media della popolazione hanno modificato la stratificazione sociale e creato nuovi squilibri. Gli antichi schemi della sicurezza sociale sono messi alla prova anche da una povertà «di ritorno» nelle società industrializzate, alle prese con la competizione globale.
Nella società del benessere, dove crescono l’instabilità e l’insicurezza, ma aumentano anche le soggettività e le capacità di autonomia delle persone, il diritto di cittadinanza si gioca su due poli: la garanzia del reddito e l’accesso reale alle opportunità. In questa prospettiva, lo Stato sociale è chiamato a svolgere altri compiti rispetto al passato, agendo a monte dei processi economici per prevenire l’esclusione sociale e offrendo una serie di servizi a tutela del cittadino in quanto tale e non solo del lavoratore. Ciò vuol dire rafforzare il sistema dell’istruzione e della formazione continua, per rendere più forti i lavoratori sul mercato (di fronte all’invocata flessibilità), ma anche estendere a tutti i settori produttivi gli ammortizzatori sociali, sperimentare il reddito minimo di inserimento (a fronte di una responsabilizzazione di chi lo percepisce) e supportare con servizi di assistenza domiciliare e territoriale la famiglia nei lavori di cura, che oggi rappresentano un onere faticoso e crescente e spesso un ostacolo per le donne nell’accesso al lavoro. In questo quadro, la selettività degli interventi sociali rispetto al reddito familiare sarà criterio decisivo. Una riforma di tale portata universalistica vedrà comunque allargata la platea dei beneficiari e non potrà essere realizzata senza aumentare l’attuale spesa sociale. Perciò se l’economia ristagna e contestualmente si lascia invariata o viene ridotta la pressione fiscale (come si invoca da più parti), la riforma dello stato sociale si può realizzare solo redistribuendo le risorse fra i diversi settori, riducendo quindi le tutele ad alcuni per darne anche ad altri. E qui si spiega perché qualcuno torna a insistere sulle pensioni. A nostro parere invece il discorso va allargato alle politiche economiche generali.
6. Dalle pensioni all’occupazione: cambiare l’obiettivo politico
La logica di breve periodo, sulla quale è sincronizzata oggi la politica, mostra nel caso del dibattito pensionistico tutta la sua perversità. Solo la crescita e l’aumento dell’occupazione, collegati ovviamente all’emersione dell’enorme quota della ricchezza sommersa «in nero» del paese, darebbero nel medio periodo anche una boccata d’ossigeno al fisco, allo stato sociale e in particolare alle casse della previdenza pubblica. Senza la crescita dell’economia, infatti, nessuna riforma del mercato del lavoro – ancorché necessaria – né la riduzione delle imposte potranno da sole creare nuova occupazione. I governi europei, ossessionati dal monetaristico patto di stabilità che è stato varato assieme all’Euro, insistono invece sulle politiche di liberalizzazione dei mercati del lavoro e di tagli al Welfare. Si affannano a offrire alle imprese condizioni sempre più favorevoli in termini di flessibilità e di riduzione del costo del denaro e del lavoro e sul piano delle agevolazioni contrattuali e fiscali. L’incidenza sempre minore del sostegno pubblico all’economia trasferisce le aspettative di un rilancio della crescita sui capitali privati, che tuttavia spesso prendono la strada dei mercati finanziari piuttosto che degli investimenti e del rilancio produttivo. E quindi i governi si trovano poi ancora una volta di fronte a esigenze di tagli della spesa per favorire la competitività internazionale del sistema produttivo, rassegnandosi quindi semplicemente a mettere in guardia i giovani dalla ricerca del «posto fisso»!
Il segno conservatore delle scelte politiche fin qui adottate dice che i governi europei hanno sostanzialmente abbandonato l’obiettivo della piena occupazione. Solo in questa chiave, infatti, si può comprendere perché l’Europa, un sistema economico integrato scarsamente influenzato dagli scambi con l’estero, nonostante la retorica della globalizzazione (le esportazioni «fuori area» rappresentano mediamente il 10-15% della produzione), non scelga una politica economica espansiva. Per modificare l’attuale trend dello sviluppo non si vedono altre strade, se non quella di adottare politiche fiscali mirate e politiche di investimento pubblico a livello comunitario, come sollecitava lucidamente Jacques Delors nel suo Libro Bianco, alcuni anni orsono.
7. Investimenti pubblici di tipo nuovo
Una prospettiva di tal genere avrebbe effetti positivi in un paese come l’Italia. In particolare nel Mezzogiorno, un’area che, a fronte dell’endemica assenza di investimenti privati, ha pagato più di altre regioni il ritiro dello Stato dall’economia e la stretta finanziaria, in termini di disoccupazione e di povertà. Il Sud è la vera emergenza politica ed economica del nostro paese, rispetto alla quale ben altra attenzione pubblica e privata ci si attenderebbe. Non si tratta di reintrodurre vecchie quanto dannose logiche assistenzialistiche, ma di attuare un nuovo intervento pubblico nell’economia che sia in grado di realizzare le condizioni sociali nel quale il mercato possa operare, favorendo l’ampliamento strutturale della base produttiva e quindi dell’occupazione. Non solo accrescendo l’irrisoria spesa per «ricerca e sviluppo», ripristinando un clima di legalità con l’attiva presenza delle istituzioni sul territorio e creando una serie di infrastrutture e servizi alle imprese: obiettivi che sarebbero già rilevanti. Soprattutto, occorrerebbe favorire selettivamente nelle imprese private l’azione di quei settori tecnologicamente innovativi e ad alta intensità di lavoro che giocano la propria competitività su fattori di qualità e non solo su quelli di prezzo. Lo stesso Welfare State può rappresentare uno dei terreni decisivi di rilancio della domanda pubblica e dei consumi collettivi, con la conseguente creazione di nuovo lavoro, soprattutto nel settore strategico della formazione professionale e dei servizi all’impiego e nel campo dei servizi di cura per i soggetti più deboli (anziani, bambini, handicappati ecc.).
Creare direttamente o indirettamente nuovo lavoro – prendendo sul serio la parte che tocca allo Stato in questo senso – è per altro l’unica strada per redistribuire in maniera non assistenzialistica reddito e opportunità e trasferire risorse a favore delle nuove generazioni. Costituisce anche la garanzia della sostenibilità finanziaria e sociale del nuovo Welfare e anche del sistema pensionistico. Il «dividendo» ottenuto dal risanamento dei conti pubblici deve quindi andare in questa direzione. Progettare lo sviluppo e la cittadinanza, coinvolgendo e incentivando le migliori forze della imprenditoria e della società civile, è compito strategico che solo lo Stato può assumere, sia pure con modalità nuove. Non è un compito semplice, di fronte al trend culturale impregnato di crescenti spinte leghiste e corporative e di tendenze neoliberiste, che hanno creato una vera e propria «sindrome da statalismo». Ma è l’unico modo per rilanciare un discorso riformatore all’altezza della sfida dei tempi.
8 novembre 1999