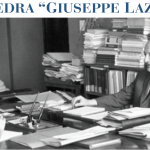Globalizzazione, antiglobalizzazione e violenza terroristica (15 ottobre 2001)
Le grandi manifestazioni e i disordini che si sono verificati in occasione dell’incontro del G8 di Genova, nel luglio scorso, hanno fatto esplodere sui media un problema di orientamento dello sviluppo complessivo del mondo, che covava sotto la cenere già almeno da un decennio. Al contempo, la tragedia degli attentati negli Stati Uniti dell’11 settembre ha rilanciato con forza un clima di scontro mondiale, facendo addirittura parlare impropriamente di una guerra in atto, di cui la successiva reazione militare americana costituisce il primo gesto di estensione. Le due vicende hanno numerosi punti di contatto: ci chiedono di prendere sul serio una nuova discussione radicale sugli orizzonti mondiali in cui ci troviamo. La caduta del muro di Berlino aveva inaugurato un’epoca in cui il sistema occidentale vincente sembrava senza discussioni, tanto che improvvidamente era stata lanciata l’immagine della “fine della storia”. Da più parti si è denunciata l’esistenza di una sorta di “pensiero unico” che, come una cappa narcotizzante, celebrava la vittoria senza limiti di una economia capitalistica estesa a tutto il globo. Il quadro appare ora improvvisamente più controverso. Mentre da una parte è apparsa una critica alle dinamiche fondamentali del mondo contemporaneo, che apre un dibattito importante, dall’altra si erge il nuovo spettro di uno scontro di civiltà, dai contorni anch’essi pericolosamente globali. Ed intanto la violenza torna a dominare drammaticamente la scena del mondo. Le nostre categorie di comprensione e di azione sono così sfidate nel profondo, chiedendo un soprassalto di analisi e di coscienza.
1. Il salto di qualità del terrorismo
Nessuno aveva mai pensato prima di trasformare i dirottamenti aerei nell’uso dei velivoli stessi come vere e proprie bombe con cui colpire obiettivi simbolici. Devastante è poi l’impressione di semplicità del fatto, che non ha richiesto affatto tecnologia complicata, ma solo una ferrea organizzazione e la disponibilità a sacrificare la propria vita, con una radicalità sconosciuta nella cultura attuale. L’impatto mediatico del gesto, studiato attentamente in modo sofisticato, ha fatto il resto. La responsabilità sembra ormai senza molti dubbi da ricercare negli ambienti dell’estremismo islamico, il che ha dato l’immagine di un nemico ispirato da un fanatismo non negoziabile. Il terrorismo ha colpito al cuore un paese come gli Stati Uniti che viveva sull’onda di un’invulnerabilità sostanziale. Ha mirato a provocare un riflesso di insicurezza e di vulnerabilità psicologica, in quel mondo ricco e potente che non può sconfiggere con le armi. Ha messo nel conto anche ampie ripercussioni economiche, di cui stiamo sperimentando alcune tetre avvisaglie in queste prime settimane dopo i fatti. Non solo i cittadini americani, ma di riflesso noi tutti abitanti del Nord sviluppato del mondo, siamo più incerti e insicuri dall’11 settembre. C’è insomma una sfida globale che si è aperta ad opera di una rete del terrore che si percepisce ramificata e ben attrezzata. Si tratta quindi, a lunga scadenza, di valutare come reagire a questa insicurezza di fondo: se pretendere di scardinare il male, identificando un capro espiatorio, oppure individuarne pazientemente le cause politiche, sociali ed economiche e quindi cercare di superarle.
2. L’esigenza della giustizia e il linguaggio della guerra
La psicosi e il linguaggio della “guerra” che si sono subito levati in risposta a questo atto sono largamente problematici: come si può fare la guerra a un nemico sottile e senza volto, che non coincide con uno Stato o con un’alleanza? Il mondo occidentale e – anzi ancor più – la grande coalizione antiterroristica che si sta delineando, possono usare semplicemente i mezzi della ritorsione contro alcuni paesi sospettati di coprire i terroristi? Evidentemente no: per ragioni di realismo ancor prima che per ragioni etiche che pure sussistono, che chiedono di uscire dalla logica della rappresaglia e non colpire popolazioni civili innocenti. Saremmo invece di fronte alla vera e propria necessità di rispondere al delitto con una grande operazione di “polizia internazionale”, se avessimo gli strumenti giuridici ed operativi per condurla. Ma in realtà non esiste nessuna struttura adatta, anche perché il tribunale penale internazionale sotto l’egida dell’Onu, su cui è stato raggiunto un accordo di principio, non è operativo per la mancata ratifica di molti paesi tra cui gli Usa stessi. La reazione è quindi affidata alla potenza americana, sotto l’egida di risoluzioni favorevoli del Consiglio di sicurezza dell’Onu e con l’appoggio politico di estese solidarietà internazionali: l’avvio delle operazioni militari in Afghanistan indica questa strada. Ma occorrerà mobilitare tutte le risorse politiche perché la risposta al terrorismo sia accorta e prudente nell’immediato e lungimirante nel futuro. Bush e i suoi consiglieri non possono non rendersi conto che il loro successo dipende propriamente dalla capacità di isolare gli obiettivi da colpire: i terroristi e i loro mandanti. Se la lunga campagna “bellica” di cui si parla provocasse gli effetti politici di rinsaldare tutte le simpatie di cui l’estremismo gode, in un unico fronte anti-americano e anti-occidentale, non farebbe che il gioco dei terroristi.
3. Rifiutare la logica dello scontro di civiltà
Molti commentatori hanno riportato l’accento sulla deriva del mondo post-ideologico verso uno scontro di “civiltà”, fortemente connotate sul piano religioso. La visione sembra però largamente lontana dalla realtà. L’estremismo islamico ha le sue organizzazioni internazionali che godono certo di complicità e sostegni più o meno ufficiali e gode di un alone di simpatie e di sostegno, che si allarga a macchia d’olio soprattutto nel mondo arabo, ma anche nell’islam in genere. Ma non coincide certo con la comunità dei credenti islamici. E’ assurdo sul piano religioso un giudizio di pericolosità rispetto all’islam, che ha prodotto semi di una civiltà ben più ricca e sfaccettata rispetto alle sue componenti oscurantiste. Al tempo stesso, lascia molto da meditare un certo fondamentalismo occidentalista che in questi giorni ci accompagna: siamo proprio sicuri che l’Occidente esprima solo la volontà di diffondere democrazia e diritti, oppure si ispira talvolta anche a semplici logiche di potere? O ancora, non ci sono profonde differenze tra modello di vita americano e modello europeo su vari piani, mentre pure le due parti dell’Atlantico convivono in uno scambio fecondo? La logica dello scontro di civiltà non corrisponde quindi alla realtà, oltre che condurre ad esiti potenzialmente perversi. Qualsiasi civiltà porta infatti con sé valori e limiti, che devono crescere e confrontarsi nel processo della storia, senza per questo un relativismo che metta tutti sullo stesso piano. Accettare questa impostazione sembra inoltre far passare surrettiziamente una equazione tra fede religiosa, fanatismo irrazionale e antimodernità che pare largamente preoccupante proprio a noi che intendiamo la fede cristiana genuina come anima della modernità, e al contempo come principio di critica radicale dall’interno di ogni forma di civilizzazione storica.
4. L’ “impero” americano potrà estendersi ulteriormente?
Il colpo per gli Stati Uniti è stato durissimo, rivelando una volontà di lotta totale al gigante americano che non può che colpire per determinazione, durezza, concentrazione di odio. Questa scelta di aggressione apre scenari radicali, al di là della relativa minoritarietà delle organizzazioni che hanno direttamente agito. Si tratta infatti di ragionare sui limiti che il grande paese americano incontra nell’interpretare il ruolo di unica superpotenza mondiale, sul piano politico, economico e anche militare. La legittimazione dell’”impero americano” nell’ultimo cinquantennio è stata infatti basata sulla grande capacità di includere altri paesi, altri popoli, altre culture, offrendo loro non solo il giogo dell’indiscussa potenza materiale, ma un discorso ideologico convincente e soprattutto l’impressione tangibile di poter far parte di un benessere condiviso in via di progressiva crescita. Tale approccio aveva funzionato contro gli sconfitti della seconda guerra mondiale e forse comincia anche a funzionare contro gli sconfitti della guerra fredda. Si ha però l’impressione di una notevole difficoltà ad estendersi ulteriormente. Il Terzo Mondo è ormai diviso: mentre pochi paesi sono entrati faticosamente nella spirale dello sviluppo, alcuni sono ormai del tutto emarginati e dimenticati. Il mondo islamico è percorso da contraddizioni laceranti tra ricchezza e miseria, crollo dei sogni di emancipazione laici e ritorno di diffusi fondamentalismi nutriti dal sottosviluppo, filo-occidentalismo di alcuni politici autoritari e diffuso orgoglio anti-occidentale, concentrazioni di potere finanziario e incapacità di innescare processi di democratizzazione politica e sociale. La responsabilità americana in tutto questo intreccio è centrale. Se la capacità politica dei vertici dell’impero di innescare il circolo virtuoso di sviluppo e democrazia si arresta ai confini del Nord del mondo e l’inclusione non procede, scattano infatti le resistenze contro un imperialismo percepito come lontano e arrogante. Occorre chiedersi se queste difficoltà dipendano dal fatto che sia diventato impossibile estendere all’infinito il metodo “inclusivo” del passato, che di fatto aveva portato con sé quello che oggi chiamiamo globalizzazione, oppure più limitatamente se esista una qualche incapacità progettuale e creativa delle classi dirigenti della superpotenza nel periodo più recente.
5. Si può invece rilanciare un dibattito critico sulla globalizzazione?
Il terrorismo si è scatenato proprio mentre si apriva un dibattito critico sulla globalizzazione attuale, che non va affatto soffocato per l’emergenza semi-bellica che si è creata. Certo, occorre impostare correttamente il confronto. Non ha senso pretendere di tornare indietro rispetto a una serie di fenomeni reali di integrazione tra le economie (informazioni e decisioni rapide che circolano, proprietà di beni e imprese che attraversano le frontiere, merci che vengono scambiate sullo sfondo di un mercato unificato). La stessa diffusione di una cultura e sensibilità “mondializzata” – spesso a matrice americana, come la gran parte dell’industria culturale – non sembra reversibile, ma solo controllabile. Altre dimensioni sono invece molto meno marcate, anche se spesso vengono citate ad esempio dei mutamenti indotti dalla globalizzazione: ad esempio si parla di industrie e impianti produttivi che si delocalizzano (ma la misura di questi fatti è modesta), e di libertà di movimento delle persone (che in realtà è modestissima e spesso ulteriormente limitata con ragioni che appaiono contraddittorie alle dinamiche della liberalizzazione dei “fattori della produzione”). Ancora, ulteriori fenomeni sono largamente indicati come problematici dagli stessi alfieri della globalizzazione, come la sterminata quantità di capitali che si muovono istantaneamente in flussi rilevantissimi. Il punto però più importante è il collegamento di questi fatti con un’ideologia neoliberista che ha preso spunto dalle tendenze all’integrazione economica per teorizzare una totale liberazione delle forze del capitale da vincoli esterni, quasi che esistesse la pressione di un campo di forze incontrollabili, cui ci si deve soltanto arrendere. Ha quindi condotto ad ampliare notevolmente l’area di intervento delle leggi di mercato e a ridurre l’influsso delle istituzioni e della politica sull’economia, eliminando progressivamente regole e garanzie che erano accusate di avere ingessato gli “spiriti animali” della competizione. Insomma, si tratta di una ideologia che ha forzato quella sorta di “compromesso” tra capitalismo e democrazie che aveva retto per circa trenta-trentacinque anni all’interno degli Stati nazionali dell’Occidente.
E’ curioso, ma molto indicativo, il fatto che in questi giorni siano proprio i nuovi problemi della sicurezza interna dei paesi avanzati a scatenare un’ondata di ripensamento attorno alle dimensioni più esteriormente evidenti della globalizzazione. Si torna a parlare di controllo dei flussi finanziari, di lotta agli scandalosi “paradisi fiscali”, di verifiche sulle proprietà delle aziende, di intervento dei pubblici poteri in funzione di regolazione del ciclo economico, di sostegni ai rami produttivi in difficoltà. E’ una smentita significativa a coloro che parlavano dell’ineluttabilità di certi processi. Occorrerà quindi allargare il fronte della critica e del ripensamento, coinvolgendo i fondamentali problemi del rispetto universale dei diritti umani e della necessità di condividere realmente le risorse del pianeta da parte di tutta l’umanità.
6. Un movimento alternativo in crescita, con luci e ombre
Questi complessi problemi sono al centro dell’interesse di un composito insieme di forze critiche, che per unificarsi ed emergere agli occhi dell’opinione pubblica ha scelto il metodo della contestazione frontale di alcuni incontri al vertice di istituzioni economiche e politiche internazionali. Quello che sta emergendo non è ancora un movimento, ma un magma critico abbastanza articolato.
La stessa etichetta di “anti-global” (che è stata appiccicata dai media, ma che molti esponenti del movimento non respingono) è sostanzialmente fuorviante. Ci sono contraddizioni evidenti di obiettivi (ambientalisti-sindacati, agricoltori protetti del primo mondo e produttori del terzo). C’è un mondo dei diseredati che stenta a prendere la parola in prima persona. C’è una certa carenza sul fronte progettuale e una cultura politica che preferisce le grandi affermazioni morali ed ideali alla faticosa e spassionata valutazione delle misure di cambiamento possibile. La concentrazione stessa sui grandi eventi internazionali è ambivalente e le critiche sono talvolta ingenerose: la regolazione politica della globalizzazione non potrà infatti che avvenire attraverso organismi internazionali. Caso mai occorrerà criticare le politiche o riformare le strutture, ma abolire molti di questi organismi non pare condurrebbe lontano. La questione della violenza è poi emersa con forza all’interno delle fragili strutture del movimento, che non sempre hanno saputo controllare le pulsioni di una parte organizzata dei manifestanti (anche se bisogna riconoscere che alcuni dei manifestanti violenti di Genova sono stati veri e propri provocatori sfruttati per demonizzare il movimento).
In positivo, c’è però in questa rete di variegate esperienze una nuova volontà di protagonismo, espressa anche da una giovane generazione che appariva a torto molto individualista. C’è un indubbio sfondo di concretezza, che vuole incidere sul presente e non si accontenta delle parole d’ordine ideologiche su un indistinto futuro, come magari tendevano a fare i contestatori di qualche decennio or sono. C’è una serie di organismi e gruppi che agiscono da anni su mille progetti specifici e fattivi, prima di andare in piazza. Appare un senso forte dell’unità del genere umano e della necessità che i diritti siano effettivi per ogni uomo e ogni donna. Si potrebbe anche citare un’acuta consapevolezza attorno alle dimensioni cruciali di una nuova forma dello sviluppo che sia compatibile con la giustizia e la salvaguardia dell’ambiente. Insomma, linee di tendenza significative e potenzialmente ricche, che vanno tutelate e valorizzate.
7. Una politica in difficoltà a governare il problema
I movimenti critici sono nati e vivono al di fuori della politica tradizionale, e in genere esprimono nei suoi confronti una forte carica polemica. Del resto, da parte dell’attuale maggioranza politica e da parte del governo, la gestione dell’incontro del G8 e delle relative manifestazioni è stata politicamente disastrosa. Dopo un dialogo parziale e ambiguo, si è scelta la via della mano libera ai violenti e della repressione dei nonviolenti, con una pericolosa tendenza alla criminalizzazione di tutto il movimento.
Ma anche l’opposizione ha mostrato i suoi grossi limiti. Ha stentato a fare i conti positivamente con quanto sta emergendo nel magma dei movimenti critici. Con tutta la responsabilità e la moderazione del caso, se le strade della politica “ufficiale” riformatrice e quelle del movimento non si incroceranno, appare difficile fare passi avanti. Un centro-sinistra di governo, infatti, non può trascurare che quelli avanzati dai “popoli di Seattle” sono temi decisivi per il futuro immediato del globo, che non possono essere aggirati per mero senso delle compatibilità con gli apparati economici dominanti. Dal canto suo, gli spezzoni migliori del movimento non possono che essere consapevoli della necessità di trovare un interlocutore culturale che li aiuti a impostare meglio il problema della costruzione di una prospettiva alternativa, ma anche una sponda politica che conduca alla mediazione e alla capacità di influire nel governo delle contraddizioni del sistema.
15 ottobre 2001