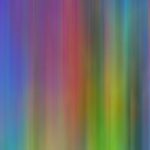Il cattolicesimo democratico
La tradizione del «cattolicesimo democratico»
A nostro parere il cattolicesimo democratico ha costituito un esile «filo rosso» di minoranza, a partire dall’incontro positivo di alcuni credenti con i princìpi rivoluzionari del 1789, dotato di forza dirompente e costruttiva. Un percorso in cui i due poli di riferimento essenziali sono sempre stati il rigoroso concetto di laicità della politica e una progettualità politicamente avanzata, nel senso della giustizia e dell’uguaglianza. Si potrebbe approfondire su questa pista una tipologia storica che porti a distinguere le posizioni del cattolicesimo democratico da altre (rispettabili ma diverse) forme di cattolicesimo politico.
- La riflessione sull’impossibilità di un «cattolicesimo senza aggettivi» nel suo risvolto pubblico ha condotto a focalizzare la necessaria aconfessionalità della presenza cattolica in politica, senza pretese di rappresentanza globale della verità: in questo modo si è andati oltre il «cattolicesimo intransigente» e i suoi equivoci, pur valorizzandone gli apporti di fedeltà alla Chiesa e di lotta per la visibilità sociale della fede e del contributo dei credenti alle lotte storiche e civili di un popolo. Scelta inverata definitivamente dal magistero del Concilio Vaticano II.
- Il rapporto storico-critico con la modernità ha poi reso capaci di innestare nelle dinamiche positive delle «rivoluzioni contemporanee» (non a caso lontanamente evangeliche) quei portati del patrimonio ideale tradizionale del movimento cattolico (primato della società; autonomia dei corpi intermedi; concezione veritativa della politica, non ristretta al principio di maggioranza…), in quanto depurati dell’involucro antimoderno e antistatalista, riuscendo così a impedire le chiusure verticistiche e statalistiche della stessa democrazia storica: in questo senso il cattolicesimo democratico si è sempre distinto da ogni cedimento o assunzione acritica della modernità, secondo tentazioni che invece sono state più presenti nell’ambito religioso riformato.
- La scelta decisa per l’allargamento delle basi dello Stato nazionale e liberale alle masse popolari ha quindi condotto a considerare necessario l’ampliamento dei compiti dello Stato, sul piano della redistribuzione del reddito e dell’uguaglianza sociale: su questa discriminante si è verificata la distinzione netta dal «cattolicesimo liberale», che tendeva ad accettare dal liberalismo il discorso sulle diseguaglianze strutturali tra uomini e donne (di qui la battaglia per l’ampliamento del diritto di voto; la rappresentanza proporzionale, per favorire le formazioni a base sociale forte e non i meri partiti notabiliari…).
- L’affermazione del valore positivo della politica moderna ha fatto nascere un senso dell’impegno politico sviluppato sul terreno partitico, ma anche sul piano delle responsabilità nelle istituzioni, della dialettica costruttiva con le altre forze ed eventualmente della gestione del potere: su questo terreno si è superata ogni demonizzazione intransigente o svalutazione «clerico-moderata» della politica partitica, ma si è andati anche radicalmente oltre il «cattolicesimo sociale», che si è sempre illuso di potere ricondurre la politica alla società senza residui.
Questi quattro terreni fondamentali di distinzione (che certo chiedono una continua rimodulazione storica) sono ancora capisaldi di un’identità possibile del cattolicesimo democratico? La risposta a tale domanda chiede di prendere sul serio il carattere articolato di questo percorso, che non assunse mai i caratteri dell’ideologia, dell’identità statica, mentre ha sempre rappresentato piuttosto un riferimento elastico ma solido, che identifica le scelte, le istanze, i metodi, i contenuti. Non ha quindi molto senso chiedersi «chi» è stato o chi sia oggi cattolico-democratico, ma quali tendenze e quali posizioni hanno avuto e hanno un segno cattolico-democratico, collocandosi su questa scia. Ciò vuole dire anche rifiutare ogni scontata «galleria degli antenati»: molti dei padri nobili di questo percorso hanno avuto posizioni storicamente non sempre lineari rispetto a quei cespiti di riferimento.
La dialettica di queste posizioni con le altre correnti del cattolicesimo contemporaneo è stata continua. Si è trattato di una storia complessa, condotta tra una minoritarietà fondamentale ed effimere occasioni di leadership. Si è vissuta l’illusione di una vittoria storica nel dopoguerra, nel ventennio che si collocò tra il momento maritainiano-democratico della fondazione dei partiti democristiani e il momento conciliare dell’autoriforma ecclesiale. Ma sappiamo che di vittoria tutt’altro che definitiva e consolidata si è trattato e, soprattutto, di vittoria tradotta in modo molto limitato e condizionato nella politica. Che questo filo abbia quindi vissuto nella Dc o fuori della Dc, è stato comunque minoranza fuori e dentro, come nella Chiesa italiana nel suo complesso. Per non parlare della sensazione drammatica che la riforma del Vaticano II sia tutt’altro che scontata e acquisita nella nostra Chiesa…