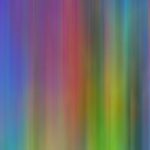Appunti 5_2006
Il sistema multilaterale al bivio
Massimo De Giuseppe
Con la fine del 2006 si chiude anche il ciclo del doppio mandato di Kofi Annan come segretario generale delle Nazioni unite. Un decennio difficile, presentatosi inizialmente come una stagione che avrebbe dovuto traghettare l’istituto centrale del sistema di organizzazioni internazionali verso nuovi lidi, sul fronte dello sviluppo sociale, del mantenimento della pace e della costruzione di una cultura politica multilaterale. In tal senso si pensava che il momento più difficile fosse toccato al suo predecessore, l’egiziano Boutros-Ghali (1992-1996); la fine del bipolarismo e le contraddizioni della prima guerra del Golfo, avevano messo a nudo limiti e fragilità del «sistema Onu» ma anche aperto inedite prospettive. Al dramma ruandese e iugoslavo, al fallimento della missione Restore Hope in Somalia, aveva fatto da contraltare il timido successo nelle operazioni integrate, tra peace-keeping e monitoraggio elettorale, in Centroamerica che avevano segnato un passo avanti rispetto alle incertezze mostrate dieci anni prima in Libano. Il permanere di una sola superpotenza, il crescente policentrismo del pianeta, nel decennio della globalizzazione dei mercati, delle nuove migrazioni ed epidemie (il boom dell’Aids), del lavoro flessibile e degli aggiustamenti strutturali, aveva infatti spalancato un vaso di Pandora ricolmo di incognite, geo-politiche, strategiche e sociali. Al tempo stesso aveva però rilanciato l’opzione di un approccio multilaterale ai problemi del mondo. Il dibattito ricostruttivo maturato in più sedi intorno alla metà degli anni ’90, sulla governance (termine all’epoca in gran voga), sul rinnovamento degli istituti finanziari e sul riequilibrio tra «sistema Onu» e luoghi di potere non formalmente istituzionalizzati (come il G7 e il «club di Parigi»), appariva come un segnale di vitalità di un contesto internazionale che si faceva sempre più radicalmente policentrico.
In quella fase entrarono in scena anche nuovi attori istituzionali, a cominciare dall’Organizzazione mondiale del commercio, partorita ufficialmente il 1° gennaio 1995 dopo un decennio di negoziati in seno all’Uruguay Round ma con una gestazione che rimandava indietro fino alla nascita del Gatt e alle contraddizioni del dopo Bretton Woods. Un parto difficile anche per le mobilitazioni sociali che lo accompagnarono e che segnarono, da Seattle a Doha, l’esplodere di un nuovo movimentismo politico-culturale, catalogato sotto l’etichetta no (poi new) global. Una stagione in cui, grazie anche all’impegno dell’amministrazione Clinton e dei governi europei, rivitalizzati dagli effetti del dopo-Maastricht, si rilanciò l’attenzione per il diritto internazionale; un processo testimoniato dalla comparsa dei primi tribunali penali internazionali: quello per la ex Iugoslavia, costituitosi già nel maggio 1993 in base alla risoluzione 827 del Consiglio di sicurezza e quello per i crimini in Ruanda, nel novembre dell’anno successivo con la risoluzione 995.
Il segnale più incoraggiante che completò quella stagione venne però dal World Social Forum di Copenaghen del marzo 19951. In quell’occasione si richiamarono alla piena collaborazione tutte le istituzioni (a cominciare da Banca mondiale e Fondo monetario internazionale) e agenzie poste sotto l’ombrello Onu, per riportare l’azione sociale al centro dell’agenda politica ed economica2. La lotta alla povertà veniva indicata come la vera sfida del XXI secolo e per questo si invitavano gli Stati a ripensare in modo strutturale il loro contributo non solo alle politiche di cooperazione ma più in generale all’intero sistema. Si allacciavano poi inediti canali di dialogo con la società civile (per la prima volta un alto numero di ong furono accreditate e coinvolte, seppur a livello consultivo, nei lavori), auspicando un rapido sforzo di democratizzazione degli istituti multilaterali.
Tra occasioni mancate e attacchi programmatici
Meno di due anni dopo, il 1° gennaio 1997, il primo mandato di Kofi Annan si apriva con un’agenda quanto mai ambiziosa. Il nuovo segretario, già pochi mesi dopo il suo insediamento, si sbilanciò sul fronte delle riforme, presentando il documento Renewing UN che prospettava un urgente ridefinizione dell’intero «sistema Onu», per rilanciarne prerogative e capacità di azione3.
Da allora la storia è tristemente nota; con la svolta del millennio gli scenari sono radicalmente mutati: l’esplosione del terrorismo globalizzato, l’11 settembre, il ritorno all’unilateralismo statunitense, le operazioni militari in Afghanistan ed Iraq, Guantanamo, la nuova crisi mediorientale, fino alla guerra libanese. Un clima che è riverberato, spesso in modo assordante, nel dibattito sullo scontro di civiltà, alimentato dai neo-cons statunitensi e dai loro fiancheggiatori locali, impegnati nel delegittimare chirurgicamente (con più precisione dei missili terra-aria) non solo le spinte multilaterali ma anche tutti i progetti di riforma politica abbozzati. Le reticenze mediatiche intorno alla nascita del Tribunale penale internazionale sono segnali dello stesso scenario. L’Onu è così divenuto un obiettivo della pamphlettistica più disparata, salvo essere poi schizofrenicamente evocato, quando necessario. Il più emblematico in assoluto resta il tentativo di coinvolgimento nella guerra preventiva messo in atto da Bush e Blair, con il sostegno di Aznar e, in maniera più defilata, di Berlusconi, nei mesi che precedettero l’operazione Iraqi Freedom; un atto concluso con la Coalitions of the Willings (parodia di un consesso democratico) e con un prolungato attacco mediatico contro gli ispettori dell’Aiea e lo stesso segretario generale. La concezione dell’Onu come parafulmine delle situazioni più scomode e obbligatoria via d’uscita per tutti i cul de sac strategico-politici tradiva scarso rispetto per le visioni multilaterali del mondo. Questo ha fatto sì che anche i timidi successi riscossi dall’Onu negli ultimi anni (dalla mediazione Etiopia-Eritrea all’indipendenza di Timor Est, fino alla dichiarazione sui popoli indigeni del 2006), siano stati offuscati dalle critiche d’inefficenza, dallo scandalo Oil for food e dagli ostruzionismi diplomatici, a cominciare dai 700 emendamenti presentati nell’Assemblea del 60° dallo statunitense John Bolton, che hanno fatto slittare i progetti di riforma del Consiglio di sicurezza.
Segnali di vita dal pianeta silenzioso
Eppure, in qualche modo, pur sballottati dagli eventi, i principi fondativi del sistema Onu (l’eredità dell’internazionalismo wilsoniano nel suo incrocio storico con altre culture) in qualche modo sono sopravvissuti alle tempeste; il sistema ha infatti resistito all’assalto frontale dell’amministrazione Bush, giacché proprio la vicenda irachena, come notato da molti osservatori, ha manifestato un’insospettabile solidità dell’Onu a fronte di un’accresciuta fragilità del colosso statunitense, sempre più dipendente dagli umori dell’industria bellica. Pur in presenza di altri fattori, la maggior collegialità diplomatica emersa nella gestione della vicenda del nucleare iraniano ne sembrerebbe una conferma. Inoltre le riforme non sono scomparse dall’agenda (sebbene ridimensionate) e la prospettiva multilaterale ha mantenuto una sua attrattiva, rinvigorita dalla ripresa dei processi di integrazione regionali e dall’emergere di nuovi attori internazionali in un mondo sempre più complesso e interconnesso. In tal senso è indubbiamente cresciuta la consapevolezza che, dopo anni di incontrastati dogmatismi neoliberisti, un ruolo cruciale per il futuro del sistema multilaterale debba passare dalla ridefinizione del rapporto tra istituti politici ed enti economico-finanziari specializzati.
Alla fine del 2000 l’Onu pubblicò un documento intitolato We, the peoples: the role of Un during the 21 century, frutto dei lavori del cosiddetto «summit del millennio». In quell’occasione l’Assemblea approvò una serie di obiettivi ambiziosi che dovevano concretizzare le istanze di Copenaghen, attraverso otto impegni ufficiali: 1) eradicare la povertà estrema (dimezzando la popolazione sotto la soglia del dollaro giornaliero), 2) garantire a livello globale l’educazione primaria, 3) eliminare le disparità di genere 4) ridurre di due terzi la mortalità infantile 5) migliorare la salute materna 6) combattere aids, malaria ed altre malattie epidemiche 7) assicurare la sostenibilità ambientale 8) sviluppare una partnership globale per lo sviluppo. Quest’ultimo punto con un range operativo piuttosto ampio, in cui rientrano i meccanismi di prestito e microcredito, la gestione di politiche migratorie, l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, l’introduzione di reti di protezione sociale e la cooperazione tra istituzioni internazionali, governi, enti pubblici e privati.
Cinque anni dopo, quello che emerge è un quadro piuttosto sconfortante. Basta prendere in mano l’ultimo documento Onu in materia o il rapporto sullo sviluppo umano dell’Undp4. Pur a fronte di qualche risultato incoraggiante, specie in Asia (ma anche per effetto del boom economico cinese e indiano), e al di là del dramma dell’Africa sub-sahariana (dove la soglia di povertà è addirittura cresciuta dal 44,6% del 1990 al 46,1% del 2001), quella che emerge è la sensazione di un generalizzato consolidarsi delle diseguaglianze. Molti degli obiettivi che erano stati giudicati realizzabili entro il 2005 sono stati mestamente posticipati al 2015 o addirittura al 2020.
L’aumento della marginalità e il conseguente ritardo delle politiche di sviluppo sono da considerarsi un fallimento del sistema Onu o qualcosa di più complesso? Anche qui emerge un dato insospettabilmente ricostruttivo: le diseguaglianze restano uno snodo cruciale e la loro riduzione non può passare solo attraverso una ridefinizione delle politiche di aiuti e dai programmi di finanziamento multilaterale. Il deficit, verrebbe da dire, è quindi ancora una volta profondamente politico. Negli ultimi due anni il relatore speciale dell’Onu per l’alimentazione, lo svizzero Jean Ziegler, è tornato più volte sul tema, criticando in particolare il disinteresse dei «paesi ricchi» per la lotta alla povertà e correlando il disimpegno nelle politiche di cooperazione multilaterale al grande boom dell’industria bellica (tema che interessa direttamente anche l’Italia, tra le prime esportatrici di armi leggere).
Meritocrazia o discrezionalità
Risulta paradossale allora la linea sostenuta da Paul Wolfowitz, ex «falco» della Casa Bianca, tra gli ideatori della tesi della guerra preventiva, subentrato lo scorso anno all’australiano Wolfensohn alla guida della Banca mondiale. Ridefinito radicalmente il progetto di riforma dell’istituto abbozzato dal suo predecessore (che richiedeva una maggiore collegialità decisionale e collaborazione con altri enti), Wolfowitz ha traslato la sua visione unilateralista all’interno del Development commitee della Bm, dove si costruiscono le politiche di sviluppo per i paesi poveri, associando l’idea della concessione di aiuti ad una campagna morale contro la corruzione. Che questo sia uno dei problemi irrisolti di buona parte dei paesi in via di sviluppo è indubbio. Ma questa idea non può stare in piedi da sola, se estrapolata da un sistema strutturale di lotta alla povertà, quasi si trattasse di una riedizione globale del metodo Giuliani per «ripulire» New York, slegato oltretutto dai criteri invasivi e ben poco «democratizzanti», delle Policy Reduction and Growth Facility dettate da Bm e Fmi. Il problema sembra derivare semmai da una campagna ideologica che rischia di offuscare i già esistenti progetti di riforma dell’istituto per convogliare l’attenzione su una parte del problema. Dietro a questa vicenda si ripresenta inoltre la distanza tra Washington, l’Ue e paesi come Cina e Brasile. Al recente summit di Singapore, anche il governatore della Banca d’Italia, Draghi, è intervenuto sul tema, sostenendo che non si possono abbandonare i paesi più poveri solo sulla base del parametro corruzione5.
Nonostante tutto quindi, anche su questo fronte, il sistema multilaterale sembra in qualche modo reggere alle spinte unilaterali e «compassionevoli». C’è insomma la consapevolezza sempre più diffusa che il progetto di riforma debba essere il più ampio possibile, non limitandosi a introdurre estemporanei strumenti di monitoraggio o aulici codici etici ma puntando a una revisione generale del sistema e delle sue politiche di lungo periodo. Un processo che dovrebbe tener conto innanzi tutto del lavoro «oscuro» svolto da molte agenzie e programmi permanenti dell’Onu, a cominciare dall’Undp, che potrebbe contribuire a ridefinire la sostanza e la percezione del sistema multilaterale a livello periferico. Bisognerebbe forse ripartire da qui, da politiche più integrate e aperte, e dai risultati ottenuti sul campo, per ricostruire in senso progettuale collegamenti verticali e orizzontali del sistema, superare i cinismi di facciata e costruire una cultura multilaterale che ridefinisca in modo serio il rapporto globalità-località.
Oltre la sicurezza
«Le Nazioni unite non servono a niente?» si chiedeva recentemente lo storico Paul Kennedy; «Il modo più semplice è quello di ricordare le molte cose che hanno saputo fare bene… Ma ai molti osservatori che si concentrano sui conflitti al confine israeliano e sulla guerra al terrorismo questo potrebbe sembrare un modo per aggirare la questione. Per loro la domanda fondamentale è: cosa può fare l’Onu per risolvere la crisi in Libano e favorire il processo di pace tra Palestina e Israele? E se la risposta è non molto, quei critici si sentiranno giustificati a mettere in discussione l’utilità delle istituzioni internazionali in generale. Perciò chiunque voglia difendere l’Onu dovrà cercare di spiegare quello che può e non può fare… i successi dell’Onu possono essere misurati solo in base alle sue possibilità, alla sua autorità reale, non in base a un potere mitico e inesistente»6.
Il tema della mitizzazione o della demonizzazione dell’Onu resta cruciale per il futuro del sistema multilaterale. In questi ultimi anni, segnati dal ritorno dei conflitti convenzionali a fianco delle «nuove guerre» postbipolari, l’Onu è stata schizofrenicamente invocata o sbeffeggiata, a seconda delle convenienze politico-strategiche del momento. Ha funzionato, come ricorda ancora Kennedy da «capro espiatorio dell’incapacità dei governi di trovare soluzioni». La recente guerra libanese ha riportato emblematicamente alla luce questi nodi irrisolti e se anche l’intervento in extremis dei caschi blu potrebbe aprire qualche prospettiva nuova per la regione, la crisi mediorientale dipende ancora palesemente da logiche politico-strategiche che manifestano la profonda debolezza del sistema multilaterale. La questione parte da un presupposto essenziale: riportare la crisi a una soluzione politica multilaterale. La questione parte da un presupposto essenziale: riportare la crisi a una soluzione politica multilaterale. In Medio Oriente ci aveva timidamente provato il «gruppo del quartetto» (escamotage che riduceva l’Onu a un semplice attore diplomatico a fianco di Usa, Russia e Uk, per non scontentare troppo la diffidenza israeliana), prima di essere travolta dall’unilateralismo di Sharon e dalla debolezza di Arafat.
Il sistema Onu è vivo, nonostante tutto, le istanze politico-diplomatiche si sono moltiplicate ma il deficit di multilateralismo è ancora profondo, a livello culturale ancor prima che politico e diplomatico. Lo si è visto recentemente nell’esperienza europea. Lo si percepisce anche dalla rimozione dall’immaginario di questioni aperte come quella del disarmo o dal fatto che con la «guerra al terrorismo» si sia tollerato un accantonamento della Convenzione di Ginevra. E’ stato lo stesso Annan a sottolinearlo, in occasione della «giornata della memoria», nel gennaio 2005, ricordando che negli ultimi sessant’anni l’Onu ha fallito più volte nel suo compito di portare pace ai paesi in guerra, invitando però gli Stati a farsene corresponsabili e a svolgere un lavoro culturale, ancor prima che operativo. Bisognerebbe ricordare che il concetto di sicurezza globale non si esaurisce nella lotta al terrorismo ma dipende da una molteplicità di fattori: dal buon funzionamento del sistema di aiuti internazionali, dal ridimensionamento dell’industria bellica, dal riequilibrio tra crescita economica e tutela sociale, infine da una maggiore coerenza della politica estera tout court.
Un serio progetto di riforme dovrebbe quindi impegnare gli Stati e i cittadini, evidenziando il legame profondo esistente tra sistema multilaterale e interesse nazionale; solo per questa via partecipativa si può infondere una nuova progettualità alla politica estera, superare gli egoismi nazionali (riverberati in quasi tutti i progetti di riforma del Consiglio) e contribuire alla costruzione di un costituzionalismo globale, che non sia un semplice artificio giuridico ma diventi un «traduzione reciproca delle diverse esperienze culturali»7. Serve quindi innanzi tutto un profondo sforzo di democratizzazione delle istanze multilaterali che permetta di costruire anche «dal basso» le fondamenta di quello che La Pira amava chiamare l’«Onu integrale» o «Onu dei popoli». Il processo non è semplice e dovrà arrivare prima o poi a toccare anche gli istituti meno democratici dell’impianto: Fmi, Wto e Bm. Solo così le riforme potranno assumere carattere progettuale e uscire dal limbo nel quale sembrano intrappolate.
1 Un World Summit for Social Development, documents, in
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/documents/index.html.
2 Unrisd, States of Disarray. The Social Effects of Globalizations, Unrisd, Geneva 1995.
3 A. Polsi, Storia dell’Onu, Laterza, Roma-Bari 2006.
4 The Millenium Development Goals Report 2005, www.unstats.un.org/unsd/mi/pdf/MDG%20Book.pdf; Undp, Lo Sviluppo umano. Rapporto 2005. La cooperazione internazionale a un bivio, tr. it., Rosenberg & Sellier, Roma 2005.
5 E. Polidori, Draghi e la Ue contro gli Usa, in «La Repubblica», 19 settembre 2006, p. 6.
6 P. Kennedy, L’Onu, caprio espiatorio, in «Internazionale», XIII, 657, 2006, p. 17.
7 G. Marramao, Il mondo e l’Occidente oggi. Il problema di una sfera pubblica globale, in C. Pasquinelli (a cura di), Occidentalismi, Carocci, Roma 2005, p. 41.