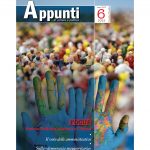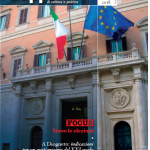Appunti 4_2006
Il lume della luna: donne, politica, cambiamento
Eugenia Montagnini e Maria Grazia Tanara
La nostra rivista vorrebbe incalzare programmaticamente il governo del centro-sinistra nei prossimi numeri, riprendendo i capitoli di un progetto per una «altra» Italia. La questione femminile è uno di questi: trascurata da tutta la politica, oppure ridotta a questione della «rappresentanza» e quindi delle «quote rosa», rischia di immiserirsi. Se riletta in termini organici ha qualcosa da dire a tutta la politica, in termini di uguaglianza, ma anche di differenza.
È dell’inizio di luglio la notizia, aggiornata agli esiti delle elezioni politiche dell’aprile 2006, che l’Italia si colloca al quarantottesimo posto nella classifica mondiale per quanto riguarda la percentuale di donne presenti in parlamento: preceduta non soltanto da numerosi paesi europei quali Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria e Germania, ma anche da alcuni paesi africani, come Rwanda e Mozambico, o centro-americani, come Costa Rica e Nicaragua. La classifica è frutto del monitoraggio realizzato dall’Università di Stoccolma e dall’Istituto internazionale per la democrazia e l’assistenza elettorale1 e assegna al nostro paese una percentuale di presenza femminile pari al 17,3% fra gli eletti della Camera e del 13,7% fra gli eletti del Senato. Dati decisamente poco incoraggianti se si pensa che i paesi ai primi posti registrano percentuali che oscillano tra il 48,8% del Rwanda e il 37,7% della Norvegia e che le medie dell’Africa subsahariana e dell’Asia si attestano rispettivamente al 16,5% e 16,3%. E dire che rispetto al 2001 abbiamo guadagnato ben dodici posizioni, passando dal sessantaseiesimo al quarantottesimo posto!
E le percentuali non sono migliori — almeno in termini di media nazionale — se guardiamo alla presenza delle donne nelle istituzioni locali: 12,6% a livello regionale, 10,8% a livello provinciale, 15,9% a livello comunale, secondo i dati rilevati nel novembre 2005 dall’Osservatorio di genere di Arcidonna2, peraltro con un incremento medio di quasi 3 punti percentuali a seguito delle elezioni amministrative dell’aprile 2005. Se però andiamo a vedere i dati disaggregati delle singole regioni le differenze sono impressionanti: si va dalle Giunte regionali di Sardegna, Piemonte e Lazio con percentuali comprese tra il 50 e il 29,4% e Giunte regionali totalmente prive di rappresentanza femminile come Basilicata, Molise e Sicilia.
Un quadro decisamente drammatico, in termini quantitativi, che ci porta ad interrogarci seriamente su quella che potrebbe e dovrebbe essere una reale rappresentanza femminile all’interno delle istituzioni politiche italiane, nazionali o locali che siano.
Uguaglianza, differenza, potere
Se i numeri ci parlano di una debole presenza delle donne nella politica italiana, i programmi elettorali presentati in occasione delle ultime elezioni politiche — in particolare quello dell’Unione, su cui desideriamo porre attenzione — mostrano uno scarso o nullo interesse alle questioni femminili: non vengono considerate né le istanze di cui le donne si fanno interpreti nei nostri contesti sociali quotidianamente (il carico famigliare, i tempi del lavoro…) né il capitale sociale e culturale di cui sono espressione.
Insomma, se si passa da una lettura quantitativa ad una lettura qualitativa, la situazione non appare certo migliore: le donne, spesso subendo la cultura dominante, vivono la politica come uno spazio maschile, all’interno del quale viene negata ogni rilevanza a tutti gli aspetti simbolicamente femminili collegati alla riproduzione della vita, alle relazioni e alla cura. Così, mancando una reale disponibilità a mettere in discussione quell’universale neutro-maschile su cui si basa l’esercizio della politica, la partecipazione femminile rischia di diventare una semplice inclusione, con l’implicita richiesta di assunzione del «punto di vista maschile» come universale. Operazione certamente possibile e concretamente praticata in maniera più o meno consapevole da diverse donne, ma poco convincente per la coscienza femminile contemporanea, attraversata da quel riconoscimento della differenza che ha significativamente caratterizzato la riflessione del secondo femminismo degli anni Settanta.
Del resto sottolineare la centralità della differenza non significa in alcun modo tralasciare come superate le questioni dell’uguaglianza, intesa come reale possibilità di accesso, senza discriminazioni, agli spazi della politica, e dell’esercizio del potere. Non è difficile constatare che a tutt’oggi nel nostro paese alle donne si concedono ruoli marginali (ministeri senza portafoglio), nei quali la gestione reale del potere è molto limitata.
Il caso di Casimira Rodríguez, indigena boliviana, leader del movimento indigeno del suo paese, nominata ministro del Tesoro nell’attuale governo, è un esempio curioso per un paese come l’Italia e lo è per due motivi, che riguardano sia il versante dell’uguaglianza sia quello della differenza. Il primo è che la Rodríguez è a capo di un ministero centrale per la gestione politica di un paese, ministero tipicamente maschile; il secondo è che la sua immagine di donna è veramente diversa dall’immagine di altre donne politicamente «potenti»: si pensi, per esempio, a Condoleezza Rice o ad Angela Merkel, e, ancor prima, a Madeleine Albright, a Margaret Thatcher, veri e propri simboli di una defemminilizzazione della politica piuttosto che di una politica delle donne.
Certamente la situazione italiana attuale non sembra esprimere segnali positivi al riguardo: il dibattito pubblico sulla presenza delle donne in politica appare debole o comunque relegato ai circuiti delle associazioni femministe e femminili che trovano scarsissima visibilità a livello di comunicazione, mentre l’effetto lungo del femminismo degli anni Settanta, che aveva prodotto una significativa presenza delle donne nelle istituzioni politiche durante gli anni Ottanta, pare concluso. Si è ritornati a una normalizzazione di tale presenza, come se la riflessione culturale non fosse stata assimilata, non si fosse trasformata in prassi, o come se il dibattito si fosse interrotto. O forse, più semplicemente, ci troviamo in una fase in cui ci si è rese conto che l’obiettivo della rappresentanza femminile, inteso in termini puramente quantitativi e per così dire formali, non è sufficiente: la questione, insomma, non è soltanto quella di una par condicio di seggi parlamentari maschili e femminili, ma anche e soprattutto quella di creare spazi in cui le donne possano essere espressione di una politica differente. Una politica che, proprio a partire dalla differenza sessuale, metta in questione l’universale, non per contrapporre un potere femminile ad un potere maschile, ma per spezzare l’unicità fuorviante del neutro universale, facendo dello spazio pubblico il luogo del confronto di una realtà che è fatta di pluralità e diversità.
Le resistenze al cambiamento
Secondo il sociologo francese Alain Touraine — che ha dedicato il suo ultimo libro alle donne3 — l’inclusione, e nel nostro caso l’inclusione delle donne nella politica (che deve essere necessariamente inclusione promossa e agita dalle donne in primis), è il reale riconoscimento delle diversità. Le donne, dunque, non sono incluse nella politica forse perché non è tematizzata la loro diversità e, in parte, anche perché per molti anni si è vincolato il dibattito al tema — senza dubbio fondamentale — dell’uguaglianza dei diritti uomo-donna e si è elusa la questione della diversità.
Le donne hanno dei tempi che sono altri rispetto ai tempi di vita degli uomini (tempi biologici ma anche tempi sociali); questo però non vuol dire che i tempi delle donne siano altro rispetto ai tempi della politica. Se per politica intendiamo solo ed esclusivamente la gestione, culturalmente maschile, del potere, allora i tempi delle donne sono ridotti, ma se per politica intendiamo la passione e la cura della polis e di chi in essa abita, allora i tempi e gli spazi delle donne si dilatano. I tempi e gli spazi dell’accoglienza, dell’accudimento e della cura, antropologicamente femminili, possono (e in qualche caso già lo sono anche all’interno del nostro paese) diventare spazi e tempi della politica. La presenza delle donne nella politica dovrebbe produrre un cambiamento, una sorta di «femminilizzazione» dell’agenda politica: in alcuni casi un’inversione di priorità, un ribaltamento di tempi, una propositività e un’attenzione ai mutamenti sociali che spesso passa direttamente dalla quotidianità delle donne, prima ancora che da quella degli uomini. È infatti nella gestione degli ambiti quotidiani (la famiglia e il lavoro) che le donne, al di là di ogni retorica, vivono la reale distanza dalla politica. Una distanza che diventa facilmente disaffezione e che, nonostante un certo tipo di legislazione, l’agenda politica attuale non riesce a individuare e colmare.
Le istituzioni politiche, per esempio, sono lontane dal riconoscere, come sostiene Martha Nussbaum, che il lavoro non retribuito delle donne debba rientrare nel calcolo nazionale della ricchezza. Così come nel nostro paese viene taciuto che il forte impulso all’economia italiana degli ultimi vent’anni è stato possibile grazie al massiccio ingresso delle donne nel mondo del lavoro, come bene hanno dimostrato diverse indagini in merito.
Lo scorso anno, all’interno della V Conferenza Mondiale delle Donne — chiamata Pechino + 10, proprio per riaffermare e rafforzare i valori e le posizioni emerse a Pechino nel 1995 — l’Onu ha ribadito la tesi secondo la quale la vita politica di un paese è lo specchio della condizione femminile. In quella sede l’Italia è stata criticata ufficialmente dal Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne. Il Comitato — organismo dell’Onu che deve vigilare sull’attuazione della Convenzione del 1979 sulle pari opportunità — ha espresso «forti preoccupazioni» per la condizione delle donne italiane. Donne ancora concepite come madri e come oggetti sessuali, soprattutto attraverso i messaggi veicolati dalla pubblicità e dalla televisione, inserite marginalmente nella vita politica e spesso vittime di discriminazioni sul lavoro.
Naturalmente non è soltanto una questione di numeri ma anche e soprattutto una questione culturale e politica, dal momento che in questi ultimi anni ogni tentativo istituzionale di creare un reale riconoscimento del ruolo delle donne è stato congelato. Così come è avvenuto nel 1997 con la direttiva Prodi-Finocchiaro che, riprendendo il mainstreaming della prospettiva di genere dell’Unione europea, si proponeva di ricollocare la questione femminile al centro del dibattito culturale e delle politiche istituzionali. Purtroppo l’emendamento non è mai divenuto legge attuativa. Potrebbe essere proprio questo governo a scongelarlo e a riprendere un processo embrionale che, se pure deve essere ulteriormente sviluppato, indica comunque già una strada percorribile.
Alcuni nodi critici
A fronte delle situazioni di crisi che caratterizzano a livello economico, sociale e politico il contesto italiano attuale e che incidono in maniera rilevante sulla condizione femminile, crediamo che la politica delle donne possa dare un contributo originale e significativo ad uscirne e uscirne insieme, con una crescita di democrazia per tutti. Ci limiteremo qui ad indicare solo alcuni di questi nodi critici, ciascuno dei quali meriterebbe un approfondimento specifico.
1. La flessibilizzazione del lavoro, spesso divenuta precarizzazione, insieme alla crisi e allo svuotamento del Welfare, anziché offrire opportunità nuove di conciliazione tra lavoro e vita familiare, hanno reso questa conciliazione sempre più difficile, provocando un allontanamento delle donne dal mercato del lavoro e concentrando il lavoro femminile in settori caratterizzati da prestazioni dequalificate o a basso reddito. Secondo l’ultimo rapporto Isfol4 circa il 13,5% delle lavoratrici esce dal mercato del lavoro dopo la nascita del primo figlio e gli aiuti alle neo-mamme arrivano per il 50% dai nonni e soltanto per il 17% dai nidi pubblici (il resto delle donne si avvalgono in parte di nidi privati e in parte di baby sitter); soltanto il 40% inoltre percepisce una certa solidarietà dal proprio partner, che partecipa comunque al carico domestico e familiare spesso in modo saltuario.
2. La questione della selezione della classe politica è uno degli aspetti della crisi della rappresentanza che affligge la nostra democrazia: purtroppo la recente vicenda delle candidature alle elezioni politiche non ha fatto che confermare l’immagine di una politica verticalizzata e oligarchica che penalizza donne e giovani. Per mutare direzione non basta cambiare la legge elettorale, non basta introdurre le quote rosa, occorre affrontare la questione, ben più radicale, di un rapporto vitale tra società civile e forme istituzionali della politica, troppo spesso autoreferenziali e impermeabili al cambiamento.
3. Un terzo nodo critico è rappresentato dal rapporto tra politica ed etica nelle questioni legate alla sessualità e alla riproduzione della vita: un ambito in cui troppo spesso viene ignorata la centralità delle donne, in cui solitamente prevale lo scontro rigido fra visioni che si presentano autosufficienti e compatte piuttosto che la ricerca di un ascolto e di un confronto serio con le ragioni dell’altro. Categorie di riferimento come la responsabilità e il senso del limite che hanno caratterizzato in questi anni il pensiero delle donne possono contribuire a far ritrovare alla politica la sua funzione di garanzia delle condizioni di una convivenza tra diversi. E il vissuto femminile può smascherare l’ipocrisia di una politica che, mentre discute di bioetica, sembra ignorare le conseguenze pesantemente negative che precarietà economica e povertà hanno oggi sulle scelte di maternità delle donne (italiane e immigrate).
4. Il problema della legalità calpestata riemerge continuamente nella vita del nostro paese, vuoi nel potere drammaticamente violento della criminalità organizzata, vuoi nell’avvilente e ricorrente intreccio tra affari e politica, vuoi nelle recentissime vicende tragicomiche legate al mondo dello spettacolo e del calcio. Ridare alla legalità il suo significato più profondo di rispetto delle regole come fondamento di una convivenza capace di tutelare i diritti di tutti crediamo sia oggi compito imprescindibile e primario della politica al quale le donne, proprio per la loro sostanziale estraneità alla gestione del potere, possono dare un contributo importante. Particolarmente significativa in questo senso, al di là dell’esito elettorale, è stata la candidatura siciliana di Rita Borsellino: una candidatura nata dal basso, dalle reti che in questi anni si sono venute a creare intorno alla sua persona e intorno alla lotta contro le mafie, di cui è una delle anime più autorevoli e visibili.
5. In un contesto internazionale in cui il ricorso alla guerra è pratica diffusa e ricorrente, vuoi per risolvere i conflitti, vuoi per esportare una democrazia che non può che trasformarsi nel dominio del più forte, il potere femminile, che Elena Pulcini definisce «potere di pace e di cura, [che] tiene tutto unito in un armonico equilibrio»5, potrebbe contribuire ad introdurre quegli elementi di discontinuità e di decostruzione necessari a rimettersi in ricerca delle vie per una convivenza pacifica tra diversi.
Vorremmo concludere richiamando la suggestiva immagine di una grande mistica carmelitana, Maria Maddalena de’ Pazzi, che oltre quattro secoli fa, rivolgendo al suo arcivescovo un accorato appello per il rinnovamento della Chiesa, scriveva: «gli huomini si servono e del lume della luna e di quel del sole, massimo si servon di quel della luna nel tempo della notte». Forse, per la politica, è venuto il tempo di servirsi del lume della luna.
1 Cfr. www.quotaproject.org .
2 Cfr. www.arcidonna.org .
3 A. Touraine, Le monde des femmes, Fayard, Paris 2006.
4 Isfol, Maternità, lavoro, discriminazioni, Rubattino, Roma 2006.
5 Elena Pulcini, Il potere di unire. Femminile, desiderio, cura, Bollati Boringhieri, Torino 2003.