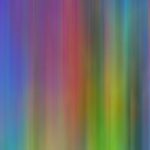Appunti 3_2006
Alfredo Carlo Moro,
un uomo di parola
Romolo Pietrobelli
La scomparsa di Alfredo Carlo Moro, illustre giurista, fratello di Aldo, alla fine dello scorso anno è stata una perdita significativa per la comunità nazionale e anche pr questa rivista, che l’aveva tra i suoi fondatori. E’ l’occasione per riflettere sull’impegno di un uomo schivo che ha fatto della valorizzazione della questione sociale, dell’impegno laicale e del nesso inscindibile «giustizia-carità-cultura», punti fermi della sua vita e del suo articolato percorso: alla guida della Fuci, nel Movimento laureati, come magistrato, docente, esperto internazionale di diritto dei minori e animatore della Lega democratica.
Il corso dell’esistenza di Alfredo Carlo Moro si è fermato dopo brevissima malattia, quasi improvvisamente, il 18 novembre scorso, compiuti da poco gli ottanta anni. Una vita molto impegnata, sino all’ultimo giorno, che lascia segnali forti, anche se vissuta nella discrezione. Volendo tentarne una lettura riassuntiva, certamente non sufficiente, mi rifaccio ai tre precisi impegni che egli stesso ha scelto di affrontare, in sequenza strettissima, investendo in essi gli ultimi mesi quando non poteva sapere di essere vicinissimo all’estremo passaggio. Se letti contestualmente, i tre impegni da lui assolti offrono un messaggio, sono la chiave della sua giornata terrena in tutte le fasi in cui essa si è svolta, danno realmente il senso della sua vita, ne sono forse il «compendio» esemplare, come egli stesso fa intravedere in uno dei suoi ultimi scritti.
Mi riferisco alla relazione per celebrare Vittorio Bachelet, da lui svolta in ottobre, un mese prima di morire, a venticinque anni dalla morte tragica del grande amico, in occasione di un convegno promosso dall’Azione Cattolica. E ancora alla riflessione radicale da lui compiuta sul tema: Il futuro è nelle nostre mani: appunti in un mondo in trasformazione pronunciata in settembre e pubblicata postuma in «Studi Zancan»1. E infine alla ricerca da lui ideata, coordinata, conclusa in ottobre, pubblicata in volume anch’essa postuma (nel marzo 2006), sotto il titolo: Minori stranieri in carcere per conto della Fondazione Ozanam-Vincenzo De Paoli2.
Cerco di percorrere la esistenza di Carlo sulla linea unitaria di questi tre «eventi» che egli ci consegna contemporaneamente e che diventano il suo testamento intellettuale, morale, religioso. Nulla, infatti, di quanto si verifica nella vita dei singoli e della storia umana alla luce della fede di Cristo è casuale e scollegato, ma anzi ha profonde se pur misteriose connessioni e «coincidenze» guidate da una Provvidenza più alta. Penso alla «storiografia del profondo» di lapiriana memoria…
Ricordando Bachelet.
Gli anni formativi
Nell’introdurre il ricordo degli scritti religiosi e civili di Vittorio Bachelet, Carlo invita a «riflettere sul suo insegnamento, ancora straordinariamente attuale» capace di «aiutarci a comprendere meglio problemi di sempre», a risuscitare responsabilità a cui «in qualche modo si è abdicato». «Cercherò di far parlare lui attraverso le citazioni che ho scelto», dice Carlo…; «selezione molto soggettiva», annota, «ma ho cercato principalmente risposta ai miei problemi, che penso siano anche i problemi di tutti voi in un momento difficile come quello attuale».
Non è arbitrario affermare, per chi ha conosciuto le due vite… parallele, che Carlo assuma come proprie, oggi, le parole pronunciate ieri da Vittorio. Carlo cita Vittorio quando invita «ad amare la vita, ad avere fiducia nella vita»; «in tutti i tempi la vita vale la pena di essere vissuta» (1947 e 1970) quando sottolinea che «la vita non solo va amata ma va anche continuamente sviluppata in sé e negli altri» e che «bisogna costruirsi in pienezza di umanità…in modo graduale ma continuo» (1966). E a proposito delle riflessioni di Vittorio sulla politica, Carlo fa proprio per intero il suo insegnamento aggiungendo: «tanto più in una stagione in cui la politica stessa, intesa come strumento privilegiato per assicurare la buona vita umana di tutti, per sviluppare la solidarietà tra i consociati, per ampliare i diritti fondamentali della persona ma anche per saperli coniugare con i corrispettivi doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, è stata sostituita da una politica che cede alla tentazione di risolversi in un mero spettacolo teso a catturare consenso più che a risolvere problemi, che si riduce a pubblicità e perlopiù ad una pubblicità ingannevole in cui il carisma dell’immagine è a tutto scapito del carisma delle idee, che tende a sviluppare perennemente lo scontro, che tutela prevalentemente interessi di gruppo contrabbandandoli come interesse di tutti e si radica sullo scambio tra consenso e privilegi, che è incurante di realizzare, attraverso la legalità, l’effettiva uguaglianza di “tutti i cittadini”».
Il discorso che Carlo Moro svolge nell’ottobre del 2005 per ricordare la testimonianza di Vittorio Bachelet di venticinque anni prima sottintende e si rifà ai temi, agli obiettivi, alle scelte di vita degli anni in cui Carlo è stato presidente nazionale della Fuci, lavorando insieme a Vittorio: dal novembre 1946 al novembre 1949. Anni dell’immediato dopoguerra e della ripresa della vita universitaria e democratica dopo il lungo periodo della dittatura fascista. Va ricordato che è Carlo che introduce Vittorio nella Fuci nel 1946, proprio quando la Fuci ambisce ad essere «la Chiesa nell’università» ed è in quel clima di fervore per la ricostruzione del paese che si creano intorno a «Ricerca», il quindicinale della Fuci, nuclei importanti di giovani che hanno coscienza di «lavorare per il domani», di «dover studiare a fondo i problemi, di sentire la responsabilità delle proprie azioni, di avere finalmente una vera, profonda coscienza morale» (parole forti dall’editoriale di Carlo Moro, giugno 1945, ancor prima di diventare presidente, scritte in un clima di crisi totale).
Dalla fine del ’45 sino a tutto il ’49, gli anni della giovinezza fucina di Carlo, è un susseguirsi instancabile di riflessioni e di progetti che, da presidente e da direttore del quindicinale, trovano espressione sulle pagine di «Ricerca». Sono moltissimi e ricchi di una sapienza precoce gli interventi di Carlo, nel triennio ’46-’49, che rivelano una rara maturità, provvidenziale per la Fuci e per gli universitari italiani. Dopo gli anni della prima fase di Romolo Murri e di don Pini, dopo la seconda fase, di Montini e di Righetti, la Fuci supera di slancio i suoi primi cinquant’anni (1896-1946) e diventa il laboratorio fertile che recupera la migliore tradizione e la arricchisce. Carlo Moro, dopo il biennio di Ivo Murgia (’45-’46), è il protagonista di questo recupero e anzi di questa rinascita, fase storica che si accompagna alla ricostruzione del paese, in cui intere generazioni di universitari vengono educati al servizio della cultura, nelle professioni, nell’università e nella Chiesa in applicazione di quella esigente pedagogia montiniana che ha avuto i suoi albori felici nel decennio ‘25-‘35 ma che è stata troncata dall’invadenza del predominio fascista. E’ stato scritto autorevolmente da Vittore Branca che non si potrà scrivere la storia completa dell’Italia del dopoguerra senza riferimento all’opera di tre grandi sacerdoti: Emilio Guano, Franco Costa, Enrico Bartoletti. Ma mi pare di dover osservare, alla luce dell’esame degli anni di presidenza Fuci di Carlo Moro, che dietro a questi grandi educatori, vanno riconosciuti i preziosi apporti e le decisive testimonianze di una schiera di «uomini nuovi» — come ci esortava ad essere Carlo — di laici cristiani che con metodo e organicità hanno risposto ad una vocazione intellettuale e di servizio di forte impegno: costruttori anch’essi di un’Italia nuova sull’orma dei tre grandi sacerdoti.
E’ impossibile in questa sede approfondire questi cenni che si rifanno alla storia ormai lontana; è dimostrabile peraltro, come si è cominciato a fare in sede di ricerca storica da parte degli studiosi, che i gruppi di universitari e di professionisti che si riunirono in quel laboratorio dei primi lustri del dopoguerra hanno saputo offrire una solida piattaforma di idee e di metodo culturale e morale per la ricostruzione del paese3. Fondamentale quel Siamo tornati a studiare, editoriale del gennaio ’47, appena nominato presidente, a commento del convegno dirigenti di Assisi. «Avevamo dimenticato tutti la sete inesausta dell’uomo di sapere, di conoscere…, volevamo ignorare — travolti dalla guerra e da un regime politico negatore della personalità — che solo nello studio vigile e acuto, in una vita intellettuale piena e assoluta potevamo avvicinarci a Dio-Verità… La cultura la sentiamo di nuovo mezzo di vita, fonte di vita…; essa ci fa sentire uomini interi, essere pensanti, creature di un Dio»…; «con serenità, con umiltà, con l’aiuto fecondo della preghiera, la Fuci ha saputo ritrovare il suo inconfondibile spirito che le ha permesso per cinquant’anni di donare alla università, alla società, alla Chiesa uomini preparati e idee feconde»; e aggiunge, in un articolo intitolato Vita nuova: «sono gli ideali grandi e belli quelli che ora ci affascinano e per cui ci sentiamo di voler vivere», concludendo: «nulla può fermarci sulla via dell’eroismo e della santità».
Qualcuno che ha conosciuto e frequentato il sobrio magistrato negli anni della maturità, sempre nemico di ogni trionfalismo, non può non riflettere su questi propositi che egli ha coltivato nella sua interiorità, perseguendoli senza alcuna caduta nella esibizione. E’ il medesimo Carlo che negli anni giovanili esortava i fucini ad uno «studio serio, che è fatto di raccoglimento e di analisi interiore, di ricerca paziente e di lenta assimilazione» e che poi, proponendo una sintesi di vita difficile, afferma «se vogliamo essere sinceri con noi stessi dobbiamo apertamente riconoscere che abbiamo bandito dal mondo la legge dell’amore…, non ci accorgiamo che la vita dovrebbe essere tutta impostata sulla donazione di sé agli altri». E più avanti: «il porci noi a servizio degli altri, umilmente, con amore, con senso di cristiana fraternità, può voler dire proprio il “come” noi vogliamo che la società futura venga organizzata».
Il ventenne Carlo Moro vedeva il nesso di cultura e carità, come sintesi necessaria per il servizio all’uomo. Sotto il profilo della sua maturità spirituale è significativo uno degli ultimi moniti: «la sofferenza è necessaria all’uomo quanto la gioia». Quando nel novembre 1949 lascia la presidenza della Fuci, «Ricerca» lo saluta e lo ringrazia, sottolineando «l’ansia di costruzione integrale della tua vita». Mentre prospettava con rigore inesauribile questa linea di formazione ai giovani coetanei, mostrava idee chiare sui problemi sociali e politici emergenti nel periodo; scrive infatti nel 1948 A proposito di un equivoco (in risposta a un giovane che si professava cattolico e fascista): «senza sottintesi: siamo antifascisti per lo meno nella stessa misura in cui siamo anticomunisti. E aggiungiamo che la Chiesa non ha bisogno di difensori che possono solo screditarla nell’intenzione di asservirla». Nel quadro inoltre della sua responsabilità di presidente della Fuci prendeva posizione insieme al Movimento Laureati, contro l’utilizzo dei Comitati Civici (anni 1948-1949) come strumenti di intervento nella politica e di pressione sulla Democrazia cristiana – scelta propugnata invece dalla presidenza geddiana con appoggi vaticani – e ciò per il rispetto delle distinzioni necessarie tra azione cattolica e azione politica. Posizione scomoda, questa, all’interno del «mondo cattolico» organizzato che procurava difficoltà e sospetti ai due movimenti. Ma che indicava una preziosa linea di educazione alla democrazia e di rispetto delle competenze, caratteristica costante dei due «movimenti intellettuali».
L’esperienza di magistrato
Dopo la laurea vince il concorso in magistratura, si sposa con Emilia Gentili — «Mimmi» per gli amici — diventa padre di quattro figli, continua a dare la sua partecipazione attiva all’associazionismo cattolico attraverso un'intensa collaborazione nel Movimento laureati, ove dirige «Coscienza» dal 1954 al 1968 e dove diventa vice presidente nazionale dal 1963 al ’67. Nel 1963 viene designato membro della Commissione per la riforma dell’Ordinamento giudiziario nominata dal ministero di Grazia e giustizia. Nel 1968 gli viene affidato l’incarico di costituire l’Ufficio studi, documentazione e stampa del Consiglio superiore della magistratura, con il compito di supportare la Commissione speciale per la riforma giudiziaria e l’amministrazione della giustizia. In quest’ambito comincia ad interessarsi dei problemi della magistratura per i minori, coordinando una ricerca sull’organico e sul funzionamento dei tribunali per i minorenni. Nel 1969 è nominato presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, ove resterà sino al 1979. Nel 1970 ottiene dal ministro guardasigilli l’istituzione di una Commissione per un organico progetto di riforma dei tribunali dei minori. Collabora alla redazione di un progetto di riforma del diritto di famiglia, quasi integralmente recepito dal Parlamento e alla revisione della legge sull’adozione speciale del 1969. Nel 1970 pubblica un volume dal titolo: Valori della famiglia e riforma della legislazione vigente4. Nel 1973 viene eletto Presidente dell’Associazione giudici per i minorenni, della quale era stato tra i promotori. È tra i promotori anche dell’Associazione italiana per la prevenzione dell’abuso all’infanzia. Nel 1976 pubblica da Giuffrè L’adozione speciale ove per la prima volta si parla apertamente di diritto alla famiglia, in forte anticipo sulla legge 149 del 2001.
Nel 1984 fonda, e dirige per dodici anni, la rivista interdisciplinare «Il bambino incompiuto. Per una nuova cultura dell’infanzia e dell’adolescenza». L’approccio innovativo su questo tema, commenta il magistrato Luigi Fadiga che gli è succeduto alla presidenza del tribunale dei minori a Roma, è basato sulla centralità del minore, sulla sua dignità di persona, sul suo diritto a un pieno e completo svolgimento del processo educativo e socializzatore. Il medesimo Fadiga sottolinea l’ampiezza dell’angolo visuale di Carlo Moro. La sua opera e la sua attività scientifica non si sono limitate al campo pur così fecondo della giustizia minorile, ma si sono allargate a tutto l’arco del rapporto tra minori e ordinamento giuridico, riuscendo a dare organicità e dignità scientifica a un insieme di norme giuridiche prima sparso e incoerente. Il suo Manuale di diritto minorile, giunto ormai alla terza edizione, rappresenta l’apice di questo percorso5. Nel 1979 passa alla Corte di Cassazione VI sezione penale prima come Consigliere e poi come Presidente, spesso anche come presidente delle sezioni unite. Nel 1981, in previsione dell’Anno internazionale del bambino, gli viene richiesto dall’Unitar, istituto delle Nazioni unite, di compiere un’indagine sulla legislazione esistente in Italia a protezione del minore. Scrive I diritti del minore in Italia, pubblicato come contributo italiano dal Ministero dell’Interno. Nel 1982 viene chiamato dal Ministero di Grazia e Giustizia a progettare un’organica e completa riforma dell’intero sistema della giustizia. Da ricordare, tra le tante altre opere, volumi, articoli specialistici sul tema della tutela dei minori, il libro Erode tra noi, la violenza sui minori6, uscito in tre edizioni e tradotto in francese sotto il titolo L’enfant sans droits (Fayard, Paris).
Nel 1992 va in pensione ma non cessa l’attività, utilizza anzi in una continua opera di servizio nell’area del volontariato la competenza straordinaria acquisita. Dal 1976 sino all’ultimo giorno avvia un’intensa collaborazione con la Fondazione Zancan di Padova guidata da don Giovanni Nervo, partecipando a seminari di studio, ricerca e formazione e coordinando una commissione di studio per la riforma del diritto minorile. I risultati delle numerose collaborazioni con la Fondazione Zancan e le successive pubblicazioni saranno presto raccolte in volume. Su sua proposta nel 1995 il ministero per gli Affari sociali ha costituito due organismi: un Osservatorio, costituito da esperti e rappresentanti dei vari ministeri e delle associazioni, per coordinare l’azione in materia minorile; un Centro nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza, costituito presso l’istituto degli Innocenti di Firenze, del quale è stato presidente fino al 2001. In quegli anni il Centro ha realizzato la prima banca dati esistente in Italia, una serie di studi e rapporti per il parlamento e l’Onu, ha promosso una cultura diffusa sull’infanzia e l’adolescenza con due riviste («Rassegna bibliografica» e «Cittadini in crescita») e una numerosa serie di quaderni monotematici, con rapporti internazionali, in particolare con i Paesi dell’Est Europa, per aiutarli a organizzare un sistema più efficace di protezione e promozione dei diritti dei minori. È opera sua il codice deontologico per tutti gli operatori radiofonici e televisivi predisposto su incarico del direttore generale della Rai e adottato dall’azienda. E determinante è la sua collaborazione nel 1995, assieme a Telefono Azzurro e all’Ordine dei giornalisti, per la Carta dei diritti dei minori nella stampa («Carta di Treviso»), recepita poi nella legge che disciplinava l’Ordine.
Nel 1996 il ministro per gli Affari sociali gli ha affidato l’incarico di preparare con alcuni colleghi un disegno di legge per una riforma della legislazione in materia di adozione internazionale. In seguito ha fatto inserire nel piano di azione del governo l’impegno per una riforma dell’ordinamento giudiziario minorile e ha predisposto un disegno di legge per l’istituzione di un difensore civico per l’infanzia, entrambi però mai realizzati. È certamente insufficiente il rapido excursus che ho compiuto sull’opera di Carlo Moro circa il diritto minorile e la conseguente tutela del minore, cioè del soggetto più debole spesso offeso nella sua dignità di persona, al quale egli ha dedicato la vita, nell’esercizio dell’attività di giudice, come in quella di docente, di consulente, di scrittore. Ci si deve perciò augurare che sull’argomento, in cui egli è stato pioniere e capo scuola, le competenze più preparate si riuniscano per raccogliere e descrivere la ricchezza del contributo scientifico che egli ha saputo dare e saputo tradurre in proposte innovatrici e organiche.
Giustizia e carità: il futuro è nelle nostre mani
Nel 1975 partecipa alla nascita della Lega Democratica che intende operare per un rinnovamento della vita pubblica italiana in continuità con la tradizione «cattolico-democratica», riaffermando la laicità della politica e chiedendo un profondo rinnovamento della Democrazia Cristiana. Nel 1993 aderisce alla iniziativa di Ermanno Gorrieri di fondare un nuovo raggruppamento politico, i Cristiano-Sociali, nella nuova democrazia dell’alternanza che si stava delineando. Accetta nel 1994 di candidarsi con i Cristiano-sociali alla Camera nel collegio di Civitavecchia. Non viene eletto e abbandona l’attività politica.
Dal 1980 è membro della Commissione episcopale Giustizia e pace e ne diviene vicepresidente dal 1987 al 1997, sollecitando quell’organismo a promuovere iniziative e documenti che avranno un forte impatto nell’opinione pubblica anche al di fuori del mondo cattolico. Mi riferisco in particolare al documento Educare alla legalità (4 ottobre 1991) da lui redatto quasi per intero e approvato dal Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana (Cei) in un momento difficile di «eclissi» della legalità, intesa come rispetto e pratica della legge. L’assunto di fondo, svolto con la consueta lucidità, è nell’affermazione che giustizia e carità insieme sussistono o cadono, che giustizia e pace sono a rischio per la caduta della moralità e della legalità. Contro risposte declamatorie e spesso devianti, il documento è un forte invito alla educazione delle coscienze e, in particolare, esortazione ai cattolici perché siano coscienza critica e testimonianza concreta di comportamenti giusti. È il contributo laicale all’interno di una autorevole istituzione ecclesiale; successivamente, la Commissione sarà composta esclusivamente da sacerdoti e vescovi.
È in questi anni (1988-1989) che egli elabora una riflessione critica, da magistrato esperto, sulla tragica morte del fratello Aldo, rapito dai brigatisti e trattenuto in umiliante prigionia per cinquantacinque giorni prima della uccisione. Giorni sofferti da Carlo in una tensione angosciosa e in un isolamento silenzioso. In un volume dal titolo Storia di un delitto annunciato7, Carlo ripercorre, vent’anni dopo, quei giorni nefasti per la società e la politica italiana (nefasti perché hanno segnato una svolta decisiva verso il precipitare della crisi del sistema politico italiano), proponendo domande penetranti e «interrogativi senza risposta». Quel libro resta un documento esemplare della grandezza umana e cristiana dei due fratelli, all’interno dell’imbarbarimento della lotta politica in Italia. È triste affermare che tuttora «le ombre del caso Moro» sono fitte e la verità reale appare ancora velata, così come lo scritto di Carlo ha dimostrato.
L’ansia di un futuro rinnovato
Il «compendio di vita» offerto da Carlo Moro (così egli percepisce la morte come si può leggere nelle ultime righe dei suoi «appunti») compie un passo avanti con la presentazione delle sue riflessioni, di cui ho fatto cenno all’inizio, sul tema: Il futuro è nelle nostre mani: appunti su un mondo in trasformazione, che evidenzia con stile essenziale e severo la crisi della politica nel nostro paese. Vengono sviluppati tra il resto, con sincerità di credente, interrogativi «sul modo in cui la Chiesa è presente in questa nostra società che è in trasmigrazione culturale», essendo ben chiaro che «l’atteggiamento da essa tenuto influisce fortemente sia sul modo di svilupparsi della politica nel nostro paese, sia sul modo di porsi del diritto». Vengono posti in evidenza il silenzio troppo frequente «della Chiesa» e «nella Chiesa» di fronte ai mutamenti in corso, osservando che «le folle plaudenti ma sostanzialmente silenti non hanno mai fatto avanzare la storia». Contro il conformismo o l’assenza, dichiara Moro, «le sfide non si vincono se un’intera comunità non si mobilita nella ricerca di strade nuove». «Perciò non è tempo sprecato fermarsi a riflettere insieme, con onestà intellettuale, sulle tendenze negative e sugli aspetti positivi che si intrecciano nello scenario che è davanti a noi». «L’avvenire è nelle nostre mani ma solo se saremo coscienti delle trasformazioni in atto… Vi è un impegno per la carità intellettuale, che non è meno meritoria della carità nelle relazioni individuali: molte, troppe ferite dell’uomo sono conseguenza di una riflessione non sufficiente e di una inerzia di azione per impedire che la vita sociale sia degradata e le esigenze di crescita umana siano ignorate o accantonate».
È ancora e sempre l’affermazione di un metodo, insieme culturale e morale, di denuncia e di proposta, cui è stato fedele lungo tutta la vita e che lo porta ad affrontare, proprio negli ultimi mesi e giorni sino alla vigilia della morte, un grave problema umano e sociale. Quando, in seno al comitato scientifico della Fondazione Ozanam-Vincenzo de Paoli, viene posta la domanda su quale bisogno, emergente ma nascosto, privo di qualsiasi copertura, sia opportuno rivolgere attenzione, egli, prontamente, senza enfasi ma con precisa consapevolezza, indica l’ambito dei «minori stranieri in carcere». Sempre i minori, la parte debole della società, ma tra essi quelli più deboli perché, in fuga da paesi poveri e senza sviluppo, sono caduti nelle ampie fessure della società opulenta e globalizzata, sono condannati in carcere in quanto accusati di reati di cui sono più vittime che colpevoli. Per affrontare l’argomento nuovo, di cui peraltro egli ha cognizione precisa maturata nel tempo, si fa carico di una ricerca che svolge con validi collaboratori, conosciuti nell’esercizio professionale. La ricerca è pubblicata in marzo dall’editore Guerini a quattro mesi dalla sua morte e viene offerta alle forze del volontariato vincenziano, alle istituzioni e a quanti desiderano collaborare affinché il problema venga correttamente percepito e ogni giovane straniero che esce dal carcere trovi un «tutore» preparato ad assisterlo e a introdurlo nella vita. Aveva scritto Carlo Moro, negli anni della giovinezza, che «la vita dovrebbe essere tutta impostata sulla donazione di sé agli altri»: possiamo affermare, e i tre ultimi eventi della sua vita ce ne danno la prova conclusiva, che egli è stato un uomo di parola, senza retorica e senza esibizionismo. Da studioso, da uomo e da cristiano, da magistrato e da docente, ha pensato, ha operato, è vissuto attuando in ogni ruolo la donazione di sé agli altri.
1 ‑A.C. Moro, Il futuro è nelle nostre mani: appunti in un mondo in trasformazione, in «Studi Zancan», 6, 2005.
2 V. Belotti,R. Maurizio, A.C. Moro, Minori stranieri in carcere, Guerini, Milano 2006.
3 ‑In un incontro a palazzo Chigi con Alcide De Gasperi (1950), chi era subentrato a Carlo Moro alla presidenza della Fuci, con riferimento alla tradizione e al lavoro culturale e morale condotto innanzi dalla Fuci, fu salutato da De Gasperi, che era stato fucino nella sua Trento, con l’impegnativa qualifica che di fatto era una consegna ideale e storica: «Voi,… i nostri successori».
4 A.C. Moro, Valori della famiglia e riforma della legislazione vigente, La scuola, Brescia 1970
5 ‑A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna 2002. La prima edizione risale al 1996.
6 A.C. Moro, Erode tra noi, la violenza sui minori, Mursia, Milano 1988.
7 A.C. Moro, Storia di un delitto annunciato: le ombre del caso Moro, Editori riuniti, Roma 1998