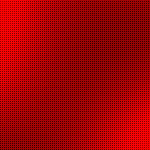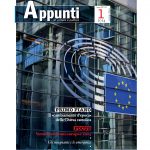Appunti 3_2006
L’Italia «salvata dai ragazzini»
e le sfide che ci attendono
Guido Formigoni 1
Risultato minimo, quanto sofferto!
Che in queste elezioni ci fosse in gioco qualcosa di più profondo di una normale alternanza di governo era una convinzione diffusa. Con Berlusconi e il berlusconismo non si poteva più scherzare: un conto era il «sogno» del 2001 che qualche illuso ancora poteva coltivare, un conto era confermarlo dopo cinque anni di governo arrogante, inetto, classista, sfacciatamente personalistico, deriso in Europa dai conservatori e dai progressisti. Insomma, un problema vivente. E quindi, diciamolo subito, a scanso di equivoci, il risultato minimo è stato ottenuto: gli elettori hanno mandato a casa Berlusconi. Con questo risultato minimo indispensabile, qualche spiraglio si apre, anche se il futuro è ancora una selva oscura ricca di insidie.
Eppure questo paese è andato vicino a fallire anche il risultato minimo. Dopo tutti i sondaggi concordanti, dopo che lo stesso presidente del Consiglio era sostanzialmente apparso in preda al panico della sconfitta (solo così si può spiegare l’approccio all’assemblea di Confindustria), gli italiani quasi lo conservavano al governo. Si può dire davvero grazie ai «ragazzini» che hanno salvato l’Italia (parafrasando il titolo di un vecchio grande libro di Elsa Morante): ai giovani dai 18 ai 25 anni, che hanno dato al centro-sinistra quell’esile vantaggio di circa 25.000 voti, che ha permesso di acquisire il premio di maggioranza alla Camera dei deputati, rovesciando il vantaggio di 220.000 voti che l’alleanza di centro-destra ha ottenuto al Senato. L’altro ancoraggio della felice riuscita dell’alternanza sono stati come è noto gli italiani all’estero, che nonostante aspettative contrarie (e anche grazie alla divisiva tattica suicida della destra) hanno portato al Senato quei pochi eletti di centro-sinistra che riescono a non rendere zoppa la vittoria della Camera, sbilanciando il sostanziale pareggio che si era costituito con la somma dei premi di maggioranza regionali.
L’Italia bipolare: prenderla sul serio
Dunque: che dire, che già non sia stato detto, e nella logica di quanto a questa rivista interessa per il futuro? Intanto, c’è da fare una seria riflessione su questi risultati. Si è sentita molta, troppa, retorica sull’«Italia divisa in due»: molta parte di questi discorsi non è affatto politicamente innocente, in quanto scopertamente mirata a portare acqua al mulino del «governo di larghe intese», cui anche Berlusconi si è subito aggrappato dopo che si era rivelato palesemente improponibile il bluff sulla non accettazione del risultato elettorale. Che l’Italia sia divisa non lo scopriamo oggi: un milione di voti in più o in meno non cambiano il panorama, anche se legittimamente sono l’ago della bilancia di una vittoria e di una sconfitta. L’Italia è stata divisa elettoralmente: le coalizioni hanno rastrellato sotto le proprie capaci fronde, molto più radicalmente che nel 2001 (o addirittura nel 1996), tutte le forze minori (beh, non proprio tutte: il Progetto Nordest dell’imprenditore delle finestre e delle televisioni locali Giorgio Panto, paraleghista e federalista spinto, ha sottratto la dote non trascurabile di 90.000 voti alle somme nazionali dei poli). Il paese è diviso politicamente da contrapposizioni forti e stabili: gli studi di flusso più accreditati (ne ha scritto Paolo Natale) ci dicono che è raro per un elettore cambiare campo radicalmente, mentre è più facile rifugiarsi nell’astensione quando si vuol punire il proprio campo. Il paese è diviso geograficamente: appartenenze tradizionali e subculture funzionano ancora (anzi, sono state esaltate del voto). L’Italia è divisa storicamente: dalla crisi del vecchio sistema politico ad oggi, nonostante tutte le ricorrenti manfrine sul possibile ritorno del centrismo dietro l’angolo, tutte le evoluzioni politiche sono andate nella direzione opposta. L’Italia è divisa socialmente: i blocchi elettorali tendono ad essere anche blocchi sociali, con le partite Iva, la piccola impresa, la rendita, i proprietari di case e una parte dei disoccupati e non garantiti che sta a destra; contrapposti ai dipendenti, all’imprenditoria e a una parte dell’alta borghesia, al pubblico impiego, che tende a sinistra. E’ il bipolarismo, bellezza. Piaccia o non piaccia, l’Italia da dodici anni a questa parte si è ormai immedesimata in questo bipolarismo e pare l’abbia digerito, anzi ci si sia identificata fortemente. Si potrà dire tutto sulla qualificazione politica dei due poli e sulla fragilità di certe identità/fratture, ma il bipolarismo è un fatto contro cui non ha senso polemizzare. Al suo interno occorre casomai lavorare. Ma ricucire non è semplice, nonostante la retorica di molti soloni: occorre partire dal minimo, come far funzionare le istituzioni e ridare un poco di senso della «casa comune» a chi l’ha smarrito da tempo. E per questo, non dimentichiamoci, occorre rispedire al mittente, nel referendum di giugno, l’infausta riforma della Costituzione.
Berlusconi si è difeso meglio del previsto
In questo quadro, il dato vero è la scarsità della vittoria elettorale del centro-sinistra. Era arrivato il momento di archiviare un Berlusconi cotto e stracotto, ma non si è riusciti a farlo. Naturalmente, dal punto di vista dell’offerta politica, questo può significare due cose: Berlusconi si è difeso meglio del previsto, il centro-sinistra ha convinto meno del previsto. Forse c’è del vero in tutt’e due gli aspetti. Il colpo di coda berlusconiano della campagna elettorale ha recuperato molti voti, rimobilitando il proprio elettorato, soprattutto al Nord. Per Forza Italia si può stimare recuperato circa metà dell’elettorato perso e disamorato tra il trionfo del 2001 (11 milioni di voti) e le delusioni delle europee 2004 e delle regionali 2005 (attorno ai 7 milioni). L’alleanza invece ha fatto il pieno, migliorando di molto la quota maggioritaria raggiunta nel 2001 (e di poco anche la somma delle quote proporzionali). Complice non tanto un aumento dell’elettorato (infatti, la percentuale più alta è da parametrarsi su liste elettorali depurate dagli italiani all’estero), ma un vero e proprio crollo delle schede bianche e nulle (1.800.000 circa in meno!). Complice soprattutto la capacità di vellicare il ventre molle del paese, con un messaggio tutto negativo sugli avversari: l’anticomunismo e la paura dello Stato-moloch esattore, un tema che rende ancora, anche quando è presentato nella forma della boutade palesemente irrealistica (basti pensare alla battuta finale dell’ultimo teleconfronto sull’abolizione dell’Ici: ma come crederci?). Insomma, il nostro ha imposto ancora la sua agenda alla campagna elettorale, evitando che si parlasse dei fallimenti di governo (occultati dalla valanga di cifre usate come cortina fumogena: «abbiamo fatto 36 riforme»).
In sostanza, il blocco sociale berlusconiano ha tenuto. E questo vuol dire due cose: che in cinque anni di governo c’è chi ci ha guadagnato con la riduzione delle tasse, l’abolizione della successione, l’aumento selettivo della spesa pubblica, la flessibilizzazione del lavoro, l’abolizione del falso in bilancio, l’allentamento dei vincoli europei e via dicendo. E poi che un’altra parte del paese profondo, lontano dalla politica (tanto da non votare per le amministrative!) è disposto a rinnovare il credito al padrone in nome della paura della «sinistra che mette le mani nelle tasche degli italiani», passando sopra ogni ragionevole giudizio sui propri stessi interessi, messi in crisi da cinque anni di malgoverno. Non è solo lo zoccolo duro dei giapponesi dell’anticomunismo. Dipende dal potere mediatico, certamente. Ma in fondo appare essere il segnale più clamorosamente vivido di un paese in difficoltà, ripiegato su se stesso e pauroso del proprio futuro.
Vittoria scarsa, ma comunque vittoria per il centro-sinistra
Dall’altra parte si può dire che sia stato il centro-sinistra a non riuscire a intercettare il consenso sufficiente per chiudere definitivamente la partita. Attenzione però: non pare giusto parlare di una vittoria elettorale senza vittoria politica. Vittoria politica è stato realizzare una coalizione larga che ha permesso di evitare ogni dispersione di voti (nel 2001 contò la divisione con Prc e Di Pietro, e inoltre i radicali erano andati da soli), conservando l’elettorato identitario, cosa non scontata. Vittoria politica sono i 19 milioni di italiani che hanno votato per i partiti della coalizione arcobaleno e quindi per Romano Prodi al governo: una quota mai raggiunta dal centro-sinistra nell’era contemporanea, due milioni e mezzo di voti in più di quelli presi nel 2001 sul proporzionale dalla somma delle liste ora collegate, e comunque circa 700.000 voti in più che al maggioritario (dove tradizionalmente l’Ulivo andava meglio). Il centro-sinistra non è andato male nemmeno al Nord, contrariamente ad immagini troppo semplicistiche. Certo, si è perso il Piemonte al Senato (vinto nel 2005), ma prendendo 100.000 voti in più rispetto al 2005 (è la destra che ha fatto il pieno, aumentando di 250.000 voti). Insomma, l’avanzata c’è stata ed è stata rilevante. Il messaggio favorevole all’avvenire dei giovani (impostato sul binomio migliore formazione – lotta al precariato) ha probabilmente avuto il suo peso positivo. Detto questo, si può anche dire dell’altra faccia della medaglia: la leadership discussa di Prodi (il compromesso sulla lista unitaria è stato senz’altro al ribasso); troppa serietà senza innovazione e senza spinta creativa; il pasticcio comunicativo sul delicatissimo terreno fiscale (invece di fare un discorso politico motivante il senso possibile del fisco, ci si è incartati sul livello del possibile ripristino della tassa di successione!); la scelta di un tema abbastanza tecnico e oscuro come la riduzione del «cuneo fiscale» come misura immediata da propagandare; quella certa persistente impressione di divisione interna e di anarchia della compagine; la sottovalutazione di questioni internazionali come quella della pace in campagna elettorale. Tutto ciò può avere contato nel limitare e contenere la vittoria.
Una legge elettorale perfida, autogol della destra
Una parola sulla legge elettorale: concepita dalla destra come «una porcata» (Calderoli docet) per sfruttare il proprio tradizionale miglior andamento nel voto proporzionale e forse per ridurre gli effetti della sconfitta attesa, data l’insipienza dei promotori si è convertita in un pauroso boomerang, negando loro quella che probabilmente sarebbe stata una vittoria a legge elettorale antica vigente (almeno a livello di prima impressione sulla distribuzione territoriale del voto). Già ora sono evidenti i primi effetti negativi: c’è un parlamento sostanzialmente nominato dalle segreterie nazionali dei partiti (forti e meno forti), che si sono sbizzarriti in portaborse e apparatciki vari. I giovani sono stati penalizzati (e questo è più grave per l’Unione, dato il discorso fatto sopra). Le liste maggiori hanno dovuto inserire — a modo di marsupiale, è stato detto — anche candidati delle liste minori a rischio quorum, preparando il rischio di nuova frammentazione anche per i gruppi parlamentari maggiori. Nel medio termine, i suoi effetti sono ancora da misurare: lo spostamento della lealtà dell’eletto dalla coalizione al partito (unico dominus della propria elezione) potrebbe causare più d’una tensione in momenti di crisi.
Detto questo, ancora una nota: che si levino alte grida contro il verticismo e la mancanza di democrazia di questo modello da parte di noti ultras del maggioritario lascia un poco perplessi: perché le candidature del vecchio sistema non erano tutte decise con il bilancino in mano dai «tavoli» nazionali delle coalizioni? Perché l’esigenza di raccattare ogni alleato non faceva anche dei vecchi collegi uninominali sicuri il rifugio di leaderini tascabili, pronti a creare gruppetti parlamentari autonomi e quindi a contribuire alla frammentazione? Certo, almeno allora il candidato doveva metterci la sua faccia e fare la sua campagna (almeno in quel terzo scarso di collegi un poco contestati, perché nei collegi sicuri di una parte o dell’altra si poteva eleggere anche il cavallo di Caligola), cosa che i baciati dalla fortuna si sono tranquillamente evitati in questo aprile del 2006. Comunque, riformare la legge sarà importante, in che direzione è tutto da discutere.
Tenuta dell’Unione e rispetto delle istituzioni
Il panorama post-elettorale è quindi ricco di incognite. Quello della destra si riassume in un nome: Silvio Berlusconi. Il centro-sinistra non l’ha spazzato via. Nemmeno gli alleati però ci sono riusciti: il riequilibrio interno alla coalizione si è fermato a metà. Masticano amaro i molteplici colonnelli di Forza Italia ai blocchi di partenza per la gara di successione, oltre agli alleati Fini e Casini, che comunque, messi assieme, hanno ancora molti voti in meno del tycoon. Solo Bossi gode di questa situazione, essendo Berlusconi il più ricattabile dal gioco leghista (come più volte si è dimostrato). L’incertezza si prolungherà e la questione della successione dovrà essere giocoforza rinviata. A meno di un gesto di responsabilità dell’ex premier, che liberi il paese e la sua stessa alleanza della sua emergenziale e condizionante presenza e permetta finalmente di avviare il percorso per una destra «normale» in Italia. Una situazione altamente improbabile.
Nel centro-sinistra la prima questione è la capacità di tenuta. Paradossalmente, una vittoria risicata potrà avere un effetto centripeto. Nessuno può pensare di fare il furbo, con un elettorato che si è espresso in questo modo, e i primi risultati delle elezioni delle cariche istituzionali confermano questa sostanziale spinta alla disciplina interna. Certo, aspetti procedurali non secondari hanno mostrato limiti e incertezze addirittura inconcepibili (il fatto che non fosse maturato in anticipo un qualche accordo minimale di organigramma, l’a tratti addirittura indecente pressing dei dalemiani). Nonostante questi aspetti, la vicenda ha mostrato una certa inaspettata capacità di controllo dei percorsi politici da parte di una leadership plurale. Si sono evitate le divisioni, senza mostrare una logica di conquista assatanata (infatti, chi dice che si sarebbe dovuto lasciare la presidenza di una camera all’opposizione, sostiene una posizione encomiabile di principio, ma trascura che con i nuovi regolamenti e le tendenze della «costituzione materiale», quelle sono cariche eminentemente politiche). Marini e Bertinotti, sindacalisti di origine, dovranno crescere nella percezione collettiva come uomini di Stato, ma particolarmente la seconda nomina ha un senso politico innegabile, legando alla coalizione e alle istituzioni quello spezzone dell’alleanza di centro-sinistra che coltiva al suo interno le più variegate pulsioni critiche. L’elezione di Giorgio Napolitano al Quirinale ha mostrato un apprezzabile spirito di apertura, evitando che si realizzasse una pregiudiziale contraria al primo partito della coalizione — come la destra ha tentato di far passare — e mettendo un’altra pietra sopra il vecchio schema comunista-anticomunista. Non è un capo di partito, è un uomo che ha nel pedigree un rispetto notevole per le istituzioni e un senso di equilibrio e mediazione che talvolta da uomo politico lo isolava dalla sua parte: da uomo delle istituzioni lo potrà dispiegare senza remore.
Un governo in salita: si attende uno scatto innovativo
Tornando alla tenuta dell’alleanza vincitrice, i motivi di divisione possono essere molti e a volte anche banali. Il più grosso è il fatto che il governo Prodi ha di fronte a sé una strada evidentemente in dura salita: non sarà affatto facile contemperare rigore finanziario e politiche di crescita e sviluppo, oltre che di solidarietà fattiva e di riequilibrio di un paese troppo diseguale. La coperta è molto corta, come ognuno sa. E soprattutto il paese è in condizioni difficilissime, per motivi che sono oggettivamente molto più profondi rispetto alle pur gravi responsabilità di Berlusconi. Romano Prodi è un passista, la sua parte migliore si dispiega nell’attività amministrativa-governativa, e quindi lo attendiamo alla prova: auguriamoci che le salite non siano troppo aspre. Speriamo anche che le salite permettano uno scatto innovativo, altrimenti questo governo non decollerà: per intenderci, Prodi non dovrà farsi prendere dall’esiziale logica dei due tempi (prima il risanamento e poi forse le riforme), che già nel 1996 avvelenò l’aria in cui respirava l’Ulivo. Il cambiamento è necessario da subito. L’esito elettorale non può essere sottovalutato: occorrerebbe affiggere un memento sopra ogni scrivania ministeriale. Se si tenterà di trasformare la vittoria politica in approfondimento e allargamento del proprio consenso sociale, l’Unione potrà dar vita a un ciclo virtuoso di sviluppo, altrimenti le cose si complicheranno anche da un punto di vista meramente elettorale.
La compagine governativa appena sfornata è anch’essa oggetto di sentimenti e valutazioni contrastanti. Da una parte non si può non considerare incoraggiante, per l’inserzione di molte personalità di alto profilo politico e personale, che potranno senz’altro portare una dote di competenza e serietà (insomma, si può non essere entusiasti per Mastella alla Giustizia, ma lasciateci dire che non c’è paragone con l’ingegner Castelli!). La presenza dei capi-partito dovrebbe dare garanzie maggiori di durata. Dall’altra restano molti dubbi sulla incapacità di fornire un segnale alto di rinnovamento. Si è puntualmente scatenata una lotta per le poltrone degna di una vittoria più solida. I partiti (piccoli ma anche grandi) hanno ancora troppo peso di condizionamento: 7 ministeri alla Margherita con il 10% dei voti, sembrano financo eccessivi. E tutto ciò succede nonostante le primarie, l’investitura del presidente del Consiglio, le leggi Bassanini e quant’altro ancora. Alcune decisioni sono sembrate francamente deteriori, anche da un semplice punto di vista comunicativo, quali la moltiplicazione dei posti con la divisione dei ministeri (incredibile la separazione di solidarietà sociale, lavoro e famiglia!). In termini di singole scelte, tutti sanno che quella più importante è la nomina di Padoa Schioppa all’Economia: la persona è una garanzia internazionale e tecnica probabilmente necessaria, il problema è che la continuità dell’asse tra Ulivo e tecnici della Banca d’Italia non saldi ancora una volta una visione dei problemi economici troppo condizionata dall’austerità finanziaria e dalle priorità del Washington consensus.
Partito democratico e cattolicesimo democratico
In termini partitici, le elezioni hanno accelerato il processo verso la costituzione di qualcosa di simile all’invocato partito democratico. Parla da solo il fatto che la lista unitaria dell’Ulivo per la Camera abbia preso il 3% in più della somma Ds-Dl al Senato, oppure — detto in un altro modo — che Rifondazione abbia preso al Senato quasi 300.000 voti in più che alla Camera (dove l’elettorato è più ampio!), il che vuol dire che molti più elettori di Rifondazione al Senato hanno quasi certamente votato Ulivo alla Camera. Insomma, la forza d’attrazione dell’unità presso l’elettorato di centro-sinistra è alta. Il nuovo partito democratico, voluto dagli elettori, potrà essere di gran lunga il maggior partito del paese e il perno indiscusso di una coalizione di governo, risolvendo anche una volta per tutte l’anomalia del ricorso al «tecnico» per la guida del governo. Il leader di questo partito sarà anche in futuro naturale candidato alla guida del paese.
Il problema di oggi è quindi il percorso politico che si aprirà: non il se ma il come. Se la nuova forza nascerà come semplice somma di apparati (uno forte e uno debole) e di organigrammi (ambedue ricchi di appetiti) di Ds e Dl, senza investimento personale di un Prodi risucchiato nell’ordinaria amministrazione di governo, il percorso mostrerà una capacità di innovazione pari allo zero. Se invece sarà occasione per un largo appello alle intelligenze e alle energie migliori del paese, se mostrerà la capacità di andare oltre la divisione delle poltrone, se metterà in moto un rimescolamento delle componenti interne, delle sintonie e delle diversità, che arricchisca il panorama complessivo, allora il percorso sarà un vero successo del centro-sinistra e lo potrà presentare al prossimo turno elettorale più fresco e incisivo. Certo, un percorso innovativo e aperto non potrà che rivolgersi anche a tutto quel mondo che si è attivato fuori dei partiti in questo quinquennio.
In questo cantiere il cattolicesimo democratico, forza culturale che noi ci ostiniamo a credere viva nel paese, dovrà investire profondamente le sue energie. Il turno elettorale ha creato malumori in questo mondo, a causa della caduta di alcuni parlamentari non ricandidati dai partiti e a causa di una politica ecclesiastica che ha gestito con il bilancino le «candidature cattoliche» nei due poli, guardandosi bene dal favorire una cultura di laicità e progresso. Nella Chiesa e nei partiti, il cattolicesimo democratico non è certo in condizioni di preminenza. Queste difficoltà sono il punto di partenza da prendere sul serio: se ci sono risorse intellettuali, spirituali, sociali e politiche, occorre investirle in una nuova grande stagione di creatività, che contribuisca al nuovo progetto, incontrandosi con tutti coloro che possono essere sensibili alle opzioni fondamentali per la persona e la comunità. Non si tratta di puntare a una corrente confessionale e culturalmente omogenea nel nuovo raggruppamento, ma occorre ambire a creare una componente politicamente significativa, contribuendo in questo modo a costruire e ridefinire l’orizzonte politico complessivo dell’iniziativa. Come su queste pagine scrivevamo tempo fa, il problema è anche di parole e di cultura politica, a partire dal fatto che non ci si può accontentare dell’etichetta usurata di «riformista» per definire una piattaforma politica che deve essere aperta al futuro. Nel cantiere ormai aperto, chi avrà più filo tesserà.
1 Articolo che sintetizza, con responsabilità di chi scrive, un’ampia discussione redazionale.