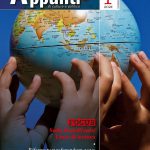Appunti 2_2006
La pace, la politica, il commercio delle armi
| Sandro Pasotti |
Perché non si parla più di disarmo? Quali sono le contraddizioni che si celano dietro al concetto di «ingerenza umanitaria»? Quali i nessi tra multilateralismo, mantenimento della pace e partecipazione popolare. In una stagione storica in cui la «privatizzazione» dei conflitti ne ha inevitabilmente mutato anche la ricaduta mediatica e sociologica, riproporre questi interrogativi non è banale.
Pensare la pace in positivo
Il tema della pace è fra quelli più controversi: ha un facile consenso immediato ma è fra quelli destinati a suscitare polemiche. Astrattamente considerata, la pace è uno di quei valori fondanti che accomunano i popoli, le nazioni e le diverse concezioni del mondo. Il rifiuto della guerra e una politica per la pace fanno parte così di ogni programma politico e di ogni ideologia, e di molte concezioni di filosofica politica. Le guerre più recenti, fino a quella in Iraq, hanno mostrato che spesso il consenso si ferma alla superficie e che le differenze, anche profonde, emergono in tutta la loro radicalità. Del resto abbiamo alle spalle secoli di discussioni ed elaborazione anche in campo cristiano sul tema della guerra, della legittima difesa, della guerra giusta, della liceità o meno del ricorso alla guerra, mentre è molto più recente e timida una riflessione sulla pace ritenuta non solo come una semplice assenza di conflitti. Ha scritto recentemente Enzo Bianchi «che la riflessione della Chiesa sulla pace in positivo, cioè non come semplice assenza di guerra, è un cammino intrapreso solo da una cinquantina d’anni, da quando, all’orrore suscitato dalle carneficine di soldati e civili dovute ai due conflitti mondiali e dalla dimensione inaudita del male raggiunto con la shoah, si è aggiunto il terrore della minaccia della catastrofe nucleare»2. Anche sul versante laico — lo abbiamo visto in occasione del dibattito seguito alla invasione dell’Iraq da parte degli Usa e degli stati alleati — vi sono molte difficoltà ad elaborare una visione in positivo del tema della pace. E d’altro canto tale difficoltà deriva anche dal fatto che, da un lato, i diritti umani e la giustizia continuano ad essere problematici in molte aree del mondo e, dall’altra, che la dimensione dei conflitti locali tende a diventare sempre più «globale», specie se i conflitti vedono schierate le maggiori potenze economiche e militari per ragioni che non hanno nulla a che fare con le motivazioni dichiarate all’inizio dei conflitti stessi. Peraltro la guerra moderna, compresi i due conflitti mondiali, è diventata sempre più una guerra «totale», e ciò comporta la violazione dei diritti fondamentali e l’uccisione di persone innocenti.
Le due recenti guerre degli Usa in Afghanistan e in Iraq hanno fino ad oggi causato la morte di tantissimi innocenti, un numero ben più elevato delle persone uccise nei due attacchi contro le «torri gemelle» e del Pentagono avvenuti l’11 settembre del 2001. Anche le due guerre della Russia in Cecenia hanno causato stragi di innocenti molto più vaste che non quelle fino ad ora causate dalla guerriglia e dal terrorismo ceceno. Lo sgomento, anche personale, di fronte a questi temi è enorme e richiede una riflessione e l’aggancio a punti di riferimento solidi perché alla reazione emotiva, certamente importante, segua anche un atteggiamento personale e politico capace di influenzare il corso della storia. Gli interrogativi che non trovano facilmente soluzione tuttavia sono molti, tanto più se si aggiunge l’osservazione che i conflitti avvengono tra nazioni o Stati nei quali non esiste il rispetto dei diritti umani oppure che è in corso una repressione o un genocidio, oppure che vi sono ancora all’opera feroci dittature. Alla naturale reazione verso le ingiustizie internazionali e contro i genocidi che porta spesso alla teoria, peraltro enunciata dallo stesso Giovanni Paolo II, della «ingerenza umanitaria», non si può perciò disgiungere una riflessione sui rischi e sul limite di questa ingerenza, sugli strumenti da adottare e, se si vuole in modo provocatorio, sul tasso di violazione dei diritti umani che si è disposti a tollerare.
Il piano politico della pace
Sul piano strettamente politico, cioè delle scelte collettive, la sintesi raggiunta dall’art. 11 della nostra Costituzione non è solo molto efficace ma, anche a distanza di sessant’anni e in un mondo che è totalmente cambiato rispetto agli anni ’40, risulta esser anche per l’oggi straordinariamente attuale. La ragione di questa attualità o di questa freschezza, come ha recentemente ricordato l’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro3, sta nel fatto che la nostra costituzione è frutto di un processo di confronto fra culture ed esperienze diverse, fra personalità diverse, che raccoglie il meglio delle diverse ispirazioni ideali presenti in quel momento in Italia. L’istanza pacifista contenuta nella costituzione italiana si fonda su due aspetti fondamentali, entrambi contenuti nell’art. 11: a) il ripudio della guerra come strumento di risoluzione di controversie internazionali o di oppressione di altri popoli; b) la costruzione di un ordinamento internazionale di «pace e giustizia» fra le nazioni, anche a costo di veder limitata la propria sovranità «a parità di condizioni con gli altri stati». Se il primo punto traccia con molta nettezza un confine non superabile, le formulazioni del secondo appaiono concepite in un’ottica quasi profetica (la limitazione della propria sovranità), tanto più che l’idea dei confini è notevolmente cambiata in questi anni. Tuttavia l’equilibrio del testo ammetterebbe, almeno in via teorica, la guerra in almeno due casi: la difesa armata del proprio territorio e la cosiddetta «ingerenza umanitaria», temi tuttavia da maneggiare con cura anche perché possibili fonti di strumentalizzazioni e di paradossi. Spesso infatti si invoca l’«ingerenza umanitaria» solo quando in gioco vi sono interessi economici o strategici mentre i conflitti — ormai regionalizzati — hanno aumentato enormemente il loro potenziale distruttivo, ponendo nuovi problemi sulla liceità di una reazione armata che appare persino peggiore dell’atto che l’ha scatenata.
Non si può tuttavia non registrare come in almeno due casi i presidenti della Repubblica abbiano ritenuto conciliabile la partecipazione italiana a conflitti militari. Il primo fu la guerra in Kosovo, per la quale l’allora presidente Scalfaro ritenne legittima la partecipazione italiana, anche ai bombardamenti, in quanto occorreva fermare uno sterminio etnico di massa. Mentre il secondo, molto più controverso dal mio punto di vista, è stata l’attuale missione in Iraq che fu definita, con un’espressione un po’ farisaica, una partecipazione «non belligerante». In questo caso la partecipazione è servita da giustificazione politica, nelle relazioni internazionali, all’invasione operata in Iraq dagli Stati Uniti con il consenso degli alleati (Italia compresa). Tuttavia, nonostante gli stiracchiamenti interpretativi subiti, l’art. 11 della nostra Costituzione mantiene chiara la sua impostazione che affida alla politica la soluzione delle controversie e da questo punto di vista rappresenta un saldo punto di riferimento.
L’urgenza di nuovo ordinamento internazionale
La costruzione di un nuovo ordinamento internazionale è una priorità, tuttavia negli ultimi decenni abbiamo assistito a due tendenze divergenti: da una parte vi è stata una moltiplicazione di organismi e istituzioni internazionali che hanno almeno in parte limitato e condizionato i poteri sovrani degli Stati, mentre dall’altra si è lasciato un certo numero di decisioni al libero gioco delle forze economiche e il potere militare in pochissime mani (Usa ed alleati). E d’altro canto la pace non si può imporre dall’alto. Neanche la più forte organizzazione internazionale può farcela da sola senza la spinta dei popoli e delle persone attraverso tanti gesti di dialogo e di contenimento dell’aggressività umana. Qualche passo avanti comunque è stato compiuto se oggi, nella coscienza mondiale, è più solido il rifiuto della guerra; e sarà ancora possibile compierne, rendendo meno fragile l’Onu e dotandola di poteri di intervento autonomo anche in tema di dispiegamento di forze militari di pace in funzione preventiva dei conflitti, fino a definire una maggiore sinergia di tutte le istituzioni internazionali e degli organismi sociali e religiosi internazionali.
L’opinione pubblica sia a livello nazionale che internazionale può molto soprattutto nell’indirizzare i governi e nell’impedire o condizionare scelte sbagliate. Da questo punto di vista allora il disarmo, come processo di controllo innanzitutto della proliferazione di nuove armi e poi come riduzione del potenziale distruttivo, é politicamente possibile. Non realistica e non produttiva dal punto di vista dell’avanzamento dei processi di pace è invece la sua versione più radicale, che partendo dall’idea di una riduzione o di un disarmo unilaterale deciso a livello dei singoli stati spera di influenzare anche i processi internazionali. Non nego il carattere profetico di certe istanze se coerenti e coerentemente gestite, ne contesto tuttavia l’utilità concreta ai fini dell’obiettivo. C’è più di un buon motivo per ripudiare la guerra e respingere tentazioni giustificazioniste; così come deve essere continuata una battaglia per la regolazione internazionale dei conflitti, la loro riduzione e la riduzione degli armamenti. Una battaglia che si esprime innanzitutto a livello di opinione pubblica contro la guerra, ma anche a favore della crescita di una cultura della pace, affinché si arrivi alla capacità di comporre e regolamentare e governare i conflitti a partire da quelli domestici, fino a quelli di classe e a quelli nazionali e internazionali: i conflitti sono un fatto «fisiologico», ma il nostro compito è di regolamentarli e contribuire a risolverli.
La questione degli armamenti
Su un altro versante il tema della guerra e di una politica per la pace evoca quello degli armamenti. Qui, pur ridimensionando una certa pubblicistica disinformata che parla della provincia di Brescia come di una provincia ricca di industrie armiere, non possiamo negare l’esistenza di una azienda che produce armi da guerra e di altre che in misura più limitata producono armi cosiddette «leggere» che vengono utilizzate nei conflitti locali4. E’ evidente la complessità del tema: battersi per la pace è in contrasto con il mantenere o addirittura fabbricare produzioni armiere (ovviamente militari) visto che sono in ballo dei posti di lavoro? E lo è sempre? E che cosa occorre fare? Sono interrogativi complessi per chi è chiamato a decidere. E’ molto facile evocare il tema della riconversione dell’industria bellica, meno facile è realizzarlo, e soprattutto fornire risposte concrete a chi chiede se sia meno immorale acquistare fucili e pistole per l’esercito italiano — o europeo in prospettiva — dalla Francia piuttosto che costruirle a Gardone Val Trompia. Su questa contraddizione che non è solo apparente tornerò più avanti. Voglio invece sottolineare concludendo questo punto, come per un cristiano l’incarnazione dei valori nei quali crede, la loro storicizzazione, è sempre un problema ed è sempre affidata alla sua personale responsabilità, secondo una concezione della laicità dell’impegno temporale alla quale ci richiama, ancora oggi, la «Gaudium et Spes». Questo vale anche su altri temi di attualità «eticamente sensibili» come ad esempio l’aborto, la fecondazione assistita, il riconoscimento dei diritti alle nuove forme di convivenza.
Il processo di costruzione di un nuovo ordine internazionale, con la nascita di nuove alleanze, porterà con sé anche e necessariamente una ristrutturazione degli eserciti (si pensi ad esempio all’Europa). In questo ambito occorre battersi per la riduzione degli armamenti. Questo processo comporterà infatti una riorganizzazione e una ristrutturazione in cui l’Europa potrebbe essere in prima fila se non altro perché abbastanza avanti sul terreno dell’integrazione tra paesi membri. Come è successo per altri settori economici, la ristrutturazione e la riorganizzazione comporterà una riduzione della occupazione che dovrebbe avvenire con modalità e con risorse gestibili. Oggi tuttavia il tema centrale è un altro, ossia quello del commercio internazionale delle armi.
Rivedere le norme italiane sul commercio delle armi
La legislazione italiana in materia (la legge 185/90) è stata peggiorata da recenti interventi legislativi, soprattutto per quanto riguarda la garanzia di trasparenza e controllo sulle transazioni bancarie; e ciò nonostante la «campagna contro i mercanti di morte», promossa da oltre 50 associazioni espressione della società civile, tra cui la Cisl, abbia impedito che si apportassero ulteriori modifiche in pejus. In questo discorso occorre includere anche le armi cosiddette «leggere» e quelle ad uso «civile», nel regime di controllo, bloccando quindi le esportazioni di tali armi verso nazioni che violano i diritti dell’uomo. Si ritiene infatti che le armi leggere siano state e siano attualmente responsabili della morte, in seguito ad eventi di natura bellica, del 90% della popolazione civile. Il Comitato internazionale della Croce rossa sostiene, in alcuni recentissimi studi, che in due recenti guerre i civili hanno costituito il 35% dei feriti e il 64% degli uccisi. Nel complesso il numero dei morti a causa delle armi leggere in questi teatri di guerra viene stimato attorno ai 200.000-300.000 l’anno5.
Nella classificazione fatta dalla legislazione italiana che distingue tra «armi ad uso militare» e «armi ad uso civile», alcune armi leggere di piccolo calibro (fucili e pistole fondamentalmente) vengono considerate appunto di uso «civile» per cui sfuggono ai controlli della legge 185. Per l’esportazione è in vigore una normativa molto semplificata che richiede unicamente l’autorizzazione del questore. Ciò, tra l’altro, aggrava i rischi, soprattutto nei successivi passaggi dalla produzione alla commercializzazione, come è stato recentemente denunciato, di «triangolazioni» o di vendite illegali. Occorre perciò introdurre delle norme per regolare le attività degli intermediatori di armi leggere e impedire il traffico illegale delle armi da parte di cittadini residenti e aziende nel caso in cui le armi siano prodotte e trasferite al di fuori del territorio italiano, traducendo in legge il divieto di esportare armi in violazione di un embargo stabilito dalle Nazioni unite per chiunque, sia per i residenti sia per chi effettua il commercio delle armi dall’Italia.
Infine, come ha osservato recentemente il segretario della Cisl, Pezzotta, la salvaguardia della sicurezza e della pace «passa anche attraverso l’adozione di uno strumento giuridico internazionale (il «Trattato sul commercio di armi» proposto dai Premi Nobel per la Pace) che regoli le esportazioni secondo le norme fissate dal diritto internazionale e dalle convenzioni in tema di diritti umani6. Si tratta di una battaglia importante da intraprendere, sulla quale è possibile coinvolgere anche i lavoratori interessati e che tra l’altro consentirebbe di moralizzare il settore facendo selezione nelle aziende sane che seguono le regole rispetto a coloro che invece le violano, mettendo peraltro a repentaglio l’occupazione stessa.
1 L’articolo è una sintesi dell’intervento tenuto al Convegno diocesano dell’Azione cattolica, Di sana e robusta Costituzione, Brescia, 29 gennaio 2006.
2 Aa. Vv., Lezioni Bobbio. Sette interventi su etica e politica, Einaudi, Torino 2006.
3 Le guide del Lunedì: La Costituzione, «Il sole 24 ore», 25 aprile 2005.
4 Per i dati sulla produzione d’armi si veda: R. Bagnato – B. Verrini, Armi d’Italia, Fazi, Roma 2005.
5 Amnesty International (a cura di), Armare i conflitti. Il G8: esportazione di armi e violazione dei diritti umani, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2000.
6 S. Pezzotta, dichiarazione all’indomani della approvazione delle modifiche alla legge 185, 4 giugno 2003.