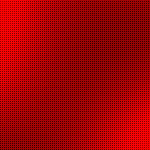Appunti 2_2006
La politica nella prima enciclica di Benedetto XVI
| Luigi F. Pizzolato |
Nel cuore della prima enciclica di Benedetto XVI, dentro l’impegnativa trattazione sul costitutivo compito ecclesiale della carità, si situa una riflessione breve ma densa sulla politica, sul suo rapporto con la giustizia e sul ruolo dei laici nella società.
Il riferimento alla politica nella «Deus caritas est» emerge da un percorso storico che, a partire dall’Ottocento, registra la pretesa delle opere di giustizia (sociale) di sostituire la carità e le sue opere. Pertanto la riflessione si colloca nel tradizionale solco del confronto tra la giustizia e la carità (la quale seconda è oggetto precipuo dell’enciclica). Un confronto che — diciamo noi — non va banalizzato nel senso che «prima» vengano le richieste della giustizia e «dopo» quelle della carità, se è vero che tra le due virtù non si pone alcun conflitto di interesse, dato che la carità è virtù teologale che informa le virtù morali (tra cui la giustizia) e non si affianca ad esse in un ordine di successione, e men che meno le annulla. È da dire peraltro che per giustizia il Papa sembra intendere, più che la virtù omonima, l’insieme dell’ordinamento politico corretto che ad essa fa capo, come a virtù politica antonomastica. La scorretta e nociva separazione tra l’ordinamento della carità e l’ordinamento della giustizia è imputata dal Papa ad una cattiva lettura degli elementi in gioco sia da parte della Chiesa sia da parte del pensiero profano. Il pensiero secolare, incapace di cogliere la dimensione trascendente, ha concepito una concorrenzialità tra gli ordini delle due virtù e ha dato il primato alla giustizia nell’ambito temporale; la Chiesa si è sentita minacciata nelle sue opere e nella sua peculiare vocazione, fino a isolarsi in se stessa e a trascurare, nel nome del primato del trascendente, il problema del giusto ordine sociale, giudicato come estraneo al problema ultimo dell’uomo.
Ma la carità, per natura e per fine, viene prima della giustizia perché è messa in moto da Dio-amore; sta alle origini della creazione stessa; informa tutta la vita relazionale dell’uomo, e quindi anche la giustizia, e resisterà in eterno, anche quando le altre virtù avranno fine. E però, nel tempo, la carità può essere pienamente colta nella sua natura teologale (per cui essa è un amare come ama Dio) solo dal credente, mentre gli altri la colgono casomai nella sua qualità di promotrice e custode della relazionalità; la avvertono per immagini e segni di cui il principale è, appunto, la giustizia (ma ce ne sono anche altri, come la fraternità). Pertanto il credente stesso, per costruire il corretto ordine relazionale insieme agli altri cittadini del mondo, deve declinare la carità attraverso un terreno mediano comune che è la morale relazionale, cercando di portare il comportamento umano sempre più verso la sua pienezza di carità, che non sarà mai raggiunta pienamente nel tempo e che sarà l’ideale finale a cui tendono nel tempo le virtù etiche, compresa la giustizia. Dalla Chiesa è peraltro custodito e gestito «in proprio» un servizio della carità, che ha altre modalità d’esercizio rispetto all’agire politico: nel senso che dà anche a chi non spetta; che tende ad unire (comunione) e non a distinguere (secondo diritti); che dà anche senza esigere rientri.
La corrente continua tra carità e giustizia
L’enciclica tenta comunque di ristabilire la corretta relazione tra impegno per la giustizia e servizio della carità (n. 28). Il Papa non parte da una definizione di giustizia (ma recupera poi il concetto della tradizione filosofica antica secondo cui essa è la virtù «che dà a ciascuno il suo»), bensì la vede come «lo scopo e quindi anche la misura intrinseca di ogni politica» (n. 28a). E però, come ogni altra virtù etica e come i risultati dell’ordine da essa stabilito, nemmeno la giustizia può essere estranea al discorso prettamente cristiano, perché la fede dà occhi più puri alla ragione per vedere anche nell’ordine temporale (n. 28a). Questo è l’apporto specifico della dottrina sociale che «vuole semplicemente contribuire alla purificazione della ragione e recare il proprio aiuto per far sì che ciò che è giusto possa, qui ed ora, essere riconosciuto e poi anche realizzato», argomentando «a partire dalla ragione e dal diritto naturale», attraverso «la purificazione della ragione e attraverso la formazione etica» (n.28a). Sulla formazione etica però il discorso qui non prosegue.
Noi ci permettiamo — fondandoci su una minima conoscenza della storia e sul sensorio dell’esperienza relazionale, per così dire, quotidiana — di raggiungere il dettato dell’enciclica partendo da un altro versante, più mondano. Constatiamo che non solo la carità può soccorrere alla giustizia, ma anche la giustizia può aiutare nel tempo la carità del cristiano a ritrovarsi, nel caso di smarrimenti storici numerosi e reali: la fraternità non è stata forse riscoperta come unità tra tutti gli uomini — e non solo tra membri della comunità cristiana — dalla giustizia politica? Il rispetto della autonoma signoria sulla propria persona non è stato forse (ri)scoperto dalla crescita della percezione dei diritti individuali mondani? L’uomo mondano nella storia percepisce spesso la carità mediante la giustizia, cioè avvertendo nelle relazioni umane situazioni di disuguaglianza da sanare riportando nella storia l’opera dell’amore. Questo è l’altro versante, meno praticato dalla riflessione dell’enciclica, che insiste invece sulla realtà dell’offerta che la fede e la carità fanno alla giustizia politica. In altre parole, si deve dire che tra carità e giustizia passa una corrente bidirezionale, che trova la sua condensazione nel terreno dell’etica o del costume. La carità passa nell’ordinamento politico non solo, e non tanto, attraverso appelli all’amore divino, ma attraverso la costruzione d’un costume relazionale di amore e di giustizia; e, d’altro lato, l’ordinamento politico, con le sue strutture di giustizia, può funzionare come vera carità storica, che, per quanto a dimensione antropologica, fa scoprire e realizzare le esigenze dell’amore anche a chi non crede («avevo fame, e mi avete dato da mangiare; avevo sete…»).
L’enciclica si mantiene comunque dentro il profilo della discesa da carità ad ordinamento giusto, e perciò vede il ruolo discendente della dottrina sociale che «vuole servire la formazione della coscienza nella politica e contribuire affinché cresca la percezione delle vere esigenze della giustizia e, insieme, la disponibilità ad agire in base ad esse, anche quando ciò contrastasse con situazioni di interesse personale» (n. 28a). L’intervento della Chiesa nella questione politica non è di protagonismo nella battaglia politica ma ha i caratteri di questa umiltà diaconica della dottrina sociale, di «argomentazione razionale» e di «risveglio» delle «forze spirituali» nella «formazione delle coscienze». Non teme di passare per «protestante» il Papa tedesco, accentuando il ruolo primario della formazione delle coscienze! Sono escluse quindi quelle intese tra Chiesa e mondo politico che, invece di essere finalizzate a risvegliare le forze spirituali e le coscienze, si configurino come sorta di patti politici tra mondo religioso e mondo politico. L’enciclica vola più alta. E per significare meglio questo suo ruolo spirituale, lascia ad altri, non al personale ecclesiastico — come vedremo — il ruolo di costruire le strutture e le leggi.
Il profilo della politica dentro la carità
Non è intenzione di questa enciclica indagare il piano politico nella sua compiutezza, tant’è vero che esso viene sinteticamente identificato — come abbiamo visto — nella realizzazione della giustizia, intesa come virtù compendiaria relazionale, che meglio può prestarsi a dialogare con la carità, quanto a vicinanza e quanto a differenza. Papa Benedetto ama costruire il discorso — nella forma di una didattica alta — creando sintesi tra concetti contrapposti, come aveva fatto nella prima parte individuando il rapporto tra eros ed agape per infrangere la rigida separazione del Nygren1. In realtà nella costruzione politica giocano (oltre alla giustizia) tutte le grandi virtù: principe addirittura quella della prudenza, che svolge un essenziale ruolo anche metodologico di individuazione del possibile avanzamento del costume della società; poi la fortezza che fa resistere contro gli attacchi di chi vuole costringerci ad abbandonare per nostro tornaconto il bene comune; poi la temperanza, che modera i desideri e permette una convivenza sociale armoniosa ed equilibrata. Se si trascurano queste virtù, il discorso politico resta una lotta aspra e perenne tra principi irriducibili. E, se si sottrae alla visione politica la completezza del piano etico, essa diventa un rapporto troppo radicalizzato tra giustizia (virtù distributiva che «dà a ciascuno il suo», cioè quello che merita) e carità (virtù oblativa che dà in ragione di quello che l’altro per essenza è e può diventare: cioè come dono promozionale). È, ancora una volta, il terreno mediano dell’etica quello che permette alla carità di vivificare le strutture politiche perché in esso già si sente a casa sua, in forza di un’azione relazionale già ivi esercitata dalle virtù. Ma è comunque interessante il ruolo che qui, dentro l’azione tipica della dottrina sociale (cioè dentro il discorso della promozione della giustizia), svolge la carità (n. 28b). Esso è individuato nel completamento e nel perfezionamento della giustizia, quasi come una riserva d’amore laddove l’amore rischi di andare smarrito dentro soluzioni politiche che tendono a ribadire la solitudine dell’individuo di fronte alle strutture; a proporre standardizzazioni a volte disumane nella loro giusta astrattezza; a non reagire con immediatezza di fronte a situazioni emergenti di necessità «anche materiali». Sullo sfondo si può leggere la convinzione del Papa che ogni legge mondana sia manchevole e imperfetta e bisognosa comunque di implementazioni; e che l’amore ha antenne che colgono «prima» i bisogni.
La Chiesa diventa, di fronte ad uno Stato costruito, nella migliore delle ipotesi, su rigide regole di giustizia distributiva, la riserva d’anima relazionale e di amore. Ma si tratta della Chiesa come comunità dove l’uomo cittadino si alimenta ai suoi valori fondativi di carità in prossimità alla fede, o dei membri della Chiesa che cercano di riversarsi nel campo della costruzione della città trasferendo ivi le leggi dell’amore? Il Papa afferma che la «Chiesa è una [si noti: «una»] di queste forze vive» dove «pulsa la dinamica dell’amore suscitato dallo Spirito di Cristo» (n. 28b). Il ruolo fortemente positivo e ideale di cui essa è detentrice sembra riportare il discorso all’idea di Chiesa comunità, serbatoio d’amore, che non ha il compito «immediato» della «formazione di giuste strutture» (n. 28b); che è staccata dalle strutture di potere temporali e che mantiene il ruolo di parametro di riferimento spirituale.
Ripresa del ruolo dei laici
Accanto a questa opera (interna) di custodia e di riserva di carità, la Chiesa può trasferire «attivamente» il suo patrimonio di carità nella politica effettiva attraverso i laici credenti. Papa Benedetto riprende qui un’idea che una certa teologia diffusa ha considerato superata: quella che è compito «immediato» dei fedeli laici (dei christifideles) «operare per un giusto ordine nella società» (n.29). Il senso rinvia alla «Christifideles laici» di Giovanni Paolo II (n.42), ma quell’aggettivo immediato riprende ultimamente l’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi di Paolo VI (n.70), dove si afferma che «compito primario ed immediato [dei laici] non è l’istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale — che è il ruolo specifico dei Pastori — ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti ed operanti nella realtà del mondo. Il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica». Con Papa Benedetto rientra in scena quell’esplicito riferimento («immediato»), e ciò è particolarmente significativo se si pensa che il recente Compendio della dottrina sociale della Chiesa, nella pur imponente massa di testi pontifici citati, ha espunto — chissà perché? — quel passo così significativo della «Evangelii nuntiandi».
Queste ultime considerazioni forse paiono pignolerie ad un tempo in cui sembrano funzionare, anche nella teologia, le macrostrutture discorsive e le ermeneutiche tese come violini, più che il rispetto filologico della parola. Ma un Papa «professore» come Papa Ratzinger ce lo ripropone autorevolmente. Quell’aggettivo immediato, riferito al compito dei laici in politica, non è infatti né casuale né debole, perché è nell’enciclica espressamente distinto dal compito «mediato» della Chiesa comunità (n. 29). Esso dice che i laici ricevono il compito politico direttamente (senza bisogno di conferimenti d’altra origine, nemmeno dalla Chiesa) da Dio e che essi devono operare nella vita sociale «rispettandone la legittima autonomia e cooperando con gli altri cittadini secondo le rispettive competenze e sotto la propria responsabilità» (n. 29). Altro è per quelle opere di carità (n. 29) che fanno direttamente capo alla Chiesa (come, ad es. case di cura cattoliche, case di riposo cattoliche, scuole cattoliche, gruppi caritativi ecclesiali…). Queste ultime sono costruite secondo il sentire della Chiesa e dentro il perimetro della comunità, e si avvalgono primariamente di una logica comunionale; ma, essendo parti del tessuto sociale esse stesse, ed avendo destinazione politica quanto a fine, non si sottraggono nemmeno esse al metodo del raccordo tra giustizia e carità. Inoltre, metodologicamente possono essere laboratori di carità sociale extraecclesiale.
Per molti aspetti l’enciclica «Deus caritas est» è una riflessione che ci riporta agli anni forti della teologia conciliare, quando era vivo il dibattito politico dei cattolici, prima dell’attuale e strumentale ripiegamento clericale di tanti credenti che delegano volentieri alla Chiesa-istituzione la loro opera faticosa e nobile di azione politica. Dalla rinfrescante riaffermazione del ruolo immediato dei laici nella politica può partire il discorso sul metodo di espletamento di quel compito. Esso non può non essere intrinseco alla sostanza di quella immediatezza, e quindi non può essere una semplice traduzione tecnica e secca nel campo politico di principi elaborati altrove (nemmeno nelle comunità cristiane), ma deve essere la messa in atto di tutte le virtù, dianoetiche ed etiche (intellettuali e morali), da parte del laico credente al fine di far crescere nella città non solo la più alta forma di giustizia, ma anche di carità, come fonte prima della stessa relazionalità umana. L’amore oblativo (carità), fontale riferimento della stessa giustizia, trasforma la giustizia da formale a sostanziale, perché «dare a ciascuno il suo» significa individuare le strutture per cui ciascuno ottiene non quello che merita alla luce di un giudizio valutativo astratto o interessato e imperfetto, ma quello che lo porta al grado di dignità di uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, che è quello veramente «suo». Di qui, nel nome della carità trasfusa in giustizia, il discorso della carità sociale, e quindi dell’impegno politico, diventa primariamente il sostegno alle debolezze e alla relazionalità, secondo una visione politica veramente personalistica e non invididualistico-liberale.
1 A. Nygren, Eros e agape. La nozione cristiana dell’amore e le sue trasformazioni, tr. it., Il Mulino, Bologna 1971.