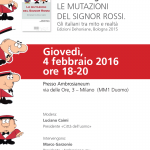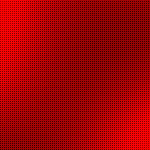Appunti 1_2006
Politica estera
Guido Formigoni
Si parla sempre troppo poco di politica estera. Sarà il tendenziale provincialismo italiano, sarà la difficoltà di orientarsi nell’orizzonte globale, sarà che la politica estera è per eccellenza una politica «forte», che in tempi di politica ridotta ad amministrazione sembra non ci si possa facilmente permettere. In fondo, la speranza è sempre nella linea di galleggiamento del paese, data la radicata convinzione di non potere influire quasi per niente sul contesto internazionale. E quindi più si tiene un profilo basso, meglio è. Il governo attuale ha fatto la politica estera delle pacche sulle spalle (fonte di infiniti equivoci), delle strette di mano (dei diplomatici, naturalmente attenti al sudaticcio!) e della promozione del made in Italy (più apparente che reale). Il centro-sinistra ha vissuto la sua stagione all’opposizione praticando lo sport dell’invocazione dell’Onu come toccasana di tutti i mali e si è concesso una vicenda politica di divisione permanente sulle più improbabili spaccature attorno alla cruciale questione dell’Iraq (il più delle volte artatamente costruite dagli avversari, talvolta frutto di puro autolesionismo). Certo, c’è da notare la continua e benemerita insistenza europeistica di Prodi: ma si tratta veramente di una «linea politica» dell’Unione o soltanto di una specie di testimonianza personale del leader, che fa ormai parte del suo curriculum in modo così forte da non poter che essere ribadita a ogni passo? Al di là di questo, poco o nulla, sia su un fronte che sull’altro. Ad esempio, la politica estera mi pare abbia assunto il ruolo della cenerentola in occasione di ambedue i recenti incontri di dibattito programmatico organizzati dai partiti maggiori all’inizio di dicembre: Ds e Margherita. Sembra che siamo di fronte a una questione tra le più dimenticate e sottovalutate.
Uno scenario instabile, che chiede politica forte
E invece, occorre ribadire la sua centralità. Non dimentichiamo che lo scenario internazionale sta andando verso una pronunciata instabilità. Al suo centro, le difficoltà della leadership unilaterale degli Stati Uniti (fortissima militarmente ma economicamente e politicamente sempre più incerta). Una leadership sfidata in molti modi: la crescita economica e politica dell’Asia orientale, le ricorrenti crisi africane, la polveriera israelo-palestinese, le fiammate del terrorismo, l’inquieto rapporto con l’Europa. Per riaffermare questa leadership l’Amministrazione Bush non ha trovato di meglio che proclamare una globale «guerra al terrorismo», dai sempre più generici e incerti confini. A completamento di questo scenario, c’è la fine della stagione più ingenua della fiducia nella «globalizzazione», intesa come processo economico affidato sostanzialmente alle leggi di mercato, che avrebbe dovuto progressivamente e pacificamente integrare il mondo. E invece ha creato certamente grandi occasioni per una parte del mondo e per alcuni settori all’interno di molti popoli, ma ha gettato altre parti nell’incertezza e provocato tensioni che ormai assumono anche veste politica.
In condizioni di instabilità e incertezza diffusa, le parole d’ordine soft non bastano più: occorrono invece soluzioni serie. Occorre che la politica torni ad essere forte, recuperi capacità di visione, di indirizzo e di decisione, superi i giochetti ideologici e affermi una propria autonomia e originalità. Saprà l’Unione dar prova di questo salto di qualità? Confidiamo ancora in questo esito dello stanco dibattito attuale, e ci permettiamo di indicare alcune priorità su cui riflettere.
Interesse nazionale e sistema multilaterale
La prima è una bene intesa riflessione sull’«interesse nazionale». Molti soloni ci spiegano che occorre rispolverare questo concetto, soprattutto nei tempi ormai non più ideologici che hanno seguito la guerra fredda, e criticano perciò per principio qualsiasi proposta di una politica estera che esprima un respiro ideale. Qui mi pare ci sia una petizione di principio molto grave: perché è chiaro che un governo non può che partire da una visione dell’interesse del proprio popolo e del proprio paese per giudicare «come stare al mondo», ma è altrettanto chiaro che questi interessi non sono dei presunti «a priori» validi per sempre (quasi si potesse tornare al «sacro egoismo» salandrino). Sono piuttosto una costruzione storica e culturale, che va elaborata e spiegata ad ogni momento, fondandosi su un’analisi della situazione e su una valutazione delle possibilità di agire realisticamente disponibili. Per questo si può dire che un interesse italiano oggi ben descritto è soprattutto quello di evitare dannosi isolamenti (il paese è troppo debole economicamente e culturalmente, e lo Stato è troppo fragile per illudersi di «contare» da solo) o anacronistiche speranze nella benevolenza di un solo «padrone» lontano (il rapporto bilaterale Italia-Usa non può ottenere più di tanto, perché dal punto di vista di Washington siamo comunque periferici). Occorre invece definire l’interesse nazionale in termini di interdipendenze e di collegamenti strutturali, che definiscano una visione complessiva del sistema internazionale, la più adeguata per un paese come il nostro, che rischia a ogni pie’ sospinto di cadere nella marginalità. Interesse dell’Italia è quindi prioritariamente la pace e la stabilità, in un quadro di regolazione internazionale delle dinamiche politiche ed economiche che permetta di moltiplicare le proprie scarse potenzialità. E quindi un quadro europeo e un quadro euro-mediterraneo, principalmente, che eviti di consegnare il governo reale dei processi globali a una tendenza spontanea all’unipolarismo a guida americana.
La seconda conseguente riflessione è che non basta infatti rifugiarsi in una mitizzazione dell’Onu, come mi sembra tenda a fare una componente del pacifismo italiano, quasi che si possa superare il velleitarismo della politica estera berlusconiana semplicemente affidandosi a una istituzione inter-statuale che non è un vero soggetto globale, ma dipende dalle politiche dei paesi maggiori, essendo strutturalmente più una sorta di «direttorio» che un vero governo mondiale democratico (a prescindere da ogni valutazione sull’opportunità di continuare a sostenere l’utopia di forme di governo mondiale…). Si può e si deve quindi senz’altro mirare alla riforma e al rafforzamento dell’Onu. Ma nella logica di portarvi dentro un progetto. Ad esempio, una visione più pluralista dell’ordine globale, in cui la superpotenza americana sia sostenuta-riequilibrata da soggetti statuali o regionali articolati e solidi. Si pensi quanto sarebbe stata utile in questa direzione una campagna seria e organica, costruita con una diplomazia costante e lungimirante, per il seggio europeo in consiglio di sicurezza (non lo è stata invece una iniziativa tardiva e strumentale, come quella italiana recente, gestita solo in chiave anti-tedesca, dopo anni di sostanziale gioco indipendente del nostro paese sulla questione della riforma).
Una Europa unita in un mondo plurale e più equo
Terzo passaggio è quindi l’obiettivo di lavorare seriamente per una Europa unita e forte, soggetto essenziale di questo mondo plurale e cooperativo. Occorre superare l’impasse del fallimento delle ratifiche del trattato costituzionale. Non accontentarsi della ripresa di un tran tran istituzionale intergovernativo. Il parallelo della nostra situazione non può essere il fallimento della Ced nel 1954, a cui si rispose con un rilancio sul terreno della cooperazione economico-commerciale. Oggi non c’è margine alcuno di iniziativa nuova su quel terreno: anzi, la presenza del mercato unico, dell’allargamento e dell’euro, configura una situazione in cui non c’è evoluzione possibile che non sia pienamente politica. Occorre lanciare un appello alle opinioni pubbliche europee (dei paesi vecchi e di quelli nuovi) che chiarisca come si intenda un’Europa politica, pluralista ma dotata di iniziativa e volontà unitarie. Onde evitare il distacco e le paure verso un’Europa tecnocratica dei mercati, che destabilizzi la tradizione (paura che è stata fondamentale nel fallimento dei referendum francese e olandese). Un’Europa quindi che rielabori e rafforzi il suo modello sociale originale. Non solo moneta e non solo protezione dell’inflazione, ma utilizzazione dei nuovi margini che il forniti dal rafforzamento finanziario dell’euro per una coraggiosa politica di sviluppo a dimensione continentale. Un’Europa, anche, che sviluppi la sua capacità di influenza politica pacifica da «potenza civile». Che sia interlocutore credibile del mondo in crescita, oltre ogni logica di scontro di civiltà: si pensi ai margini notevolissimi di dialogo e azione comune che ci sarebbero con alcune importanti democrazie del Sud del mondo, che stanno acquisendo peso economico e politico (dall’India al Brasile al Sudafrica). Quindi anche un’Europa che compia una coraggiosa quanto graduale revisione delle politiche commerciali e delle sovvenzioni all’agricoltura (come chiesto da gruppo dei 22 in sede di Wto): non è più possibile che un settore residuale della popolazione europea goda ancora di questa forza di ricatto verso i governi, tanto da condizionare così fortemente il ruolo internazionale dell’Europa.
Al contempo, occorre rilanciare un ruolo innovatore del nostro paese (e dell’Europa) nelle organizzazioni economiche internazionali. Si pensi a quanto sarebbe utile lavorare farvi passare una serie di regole che agiscano efficacemente per orientare la globalizzazione: ad esempio per costruire regole internazionali protettrici del lavoro e dei diritti umani, come esistono accordi internazionali protettivi dei diritti di proprietà intellettuale e dei marchi. Certo, come la seconda serie di norme è criticata dai paesi in via di sviluppo che la ritengono spesso unilaterale ed eccessiva nel tutelare gli interessi delle grandi corporations (si pensi alle polemiche sul prezzo dei farmaci) ma sono difese ad oltranza dai paesi del Nord, le prime sono altrettanto tacciate di mascherare subdole intenzioni protezioniste verso settori manifatturieri ormai decotti dei paesi ricchi, ma curiosamente basta questa obiezione per smontare ogni velleità del G7 nel proporle. Se invece esse entrassero in una logica di scambio reale, venendo proposte come contropartita dell’adozione di politiche commerciali meno chiuse da parte del Nord del mondo, potrebbero essere la chiave per diffondere un senso più equilibrato e umano della globalizzazione e quindi un avvicinamento reale delle condizioni dei diversi paesi su un comune terreno di civiltà.
La questione della guerra e l’ideologia dei diritti umani
Quarto passaggio è la questione della guerra, e in particolare della vicenda irachena (ma prendendo questa vicenda come simbolo di una questione più generale). La situazione era la più lineare possibile: non ci si doveva andare, occorre ritirarsi. Ma questo non vuol dire sottovalutare lo scenario nuovo post-elezioni, o rifiutare tutti gli aiuti possibili a un consolidamento della democrazia in Iraq: vuol dire farlo al di fuori di una logica di occupazione militare e nella consapevolezza che si tratta di una esigenza di lungo periodo, ahimé. Il ripensamento sulla guerra di alcuni settori della sinistra ha qualcosa di inquietante, sul piano storico e logico. Non è che il funzionamento (apparente e parziale) del processo elettorale nel paese sconvolto dal terrorismo e dalla guerra civile, in cui ci sono ancora i segni aperti dei bombardamenti e si snocciolano ogni giorno gli attentati, possa condurci a mutare il giudizio radicalmente critico sul processo politico-militare aperto dalla Amministrazione americana. La democrazia è molto più di un turno elettorale. La guerra ha eliminato il tiranno, ma ha anche suscitato un vespaio, con una coda infinita di tragedie e assassinii: è ovvio che non poteva ottenere quello che solo un tirocinio sociale complesso in condizioni di stabilità — cioè proprio quelle che la guerra per definizione non costruisce, anzi indebolisce — può far nascere e consolidare. E qui sta anche l’insegnamento di lungo periodo: non si tratta di un rifiuto di principio dell’uso della forza per affermare il diritto: l’art. 11 della Costituzione italiana parla chiaro. Si tratta di rifiutare la guerra come «strumento di offesa alla libertà degli altri popoli» e di «soluzione delle controversie internazionali», e quindi costruire politiche per la soluzione dei problemi, che spostino assolutamente all’estremo il caso-limite del ricorso alla forza. Criterio che ad esempio nel caso iracheno (ma anche nel suo precedente del Kossovo) era ben lungi dall’essere rispettato.
Chiudo con un riferimento che non sembri astratto. Tutte queste iniziative hanno bisogno di una «ideologia» unificante, di un discorso complessivo e sintetico che le fondi, le amalgami, le sappia rendere esplicative e efficaci. Ogni politica estera vera non può ridursi a un discorso ideologico senza «denti», ma ha bisogno anche di un discorso ideologico (esigenza troppe volte sottovaluata). Si sente talvolta dire nel centro-sinistra che non può esserci ideologia fondante altra che non una generale intenzione di promozione dei diritti umani da un punto di vista cosmopolitico. Discorso che avrebbe molteplici implicazioni, rispetto ad esempio al superamento di una visione del mondo fatta di sovranità divise e assolute. Figuriamoci se non condividiamo questo riferimento basilare: ma attenzione! Lo vorremmo assumere veramente come criterio fondamentale. Tale discorso è infatti talmente esigente che non permette ipocrisie e distinzioni strumentali. Non può valere per il Kossovo o per l’Iraq e non per il Congo o per la Palestina o per la Cecenia. Stiamo bene attenti a questa coerenza globale, connotato essenziale di qualsiasi ideologia che non sia marxianamente soltanto espressione della nostra cattiva coscienza.