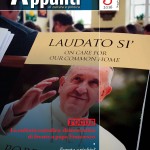Appunti 5_2005
Da pazienti a clienti: la sanità in Lombardia
| Paolo Danuvola |
In questi anni, nel nostro Paese, è risultato vivace il dibattito sui sistemi sanitari: la Lombardia è stata la capofila di un modello sempre più privatistico, con l’affidamento al mercato dell’equilibrio fra domanda e offerta. Dieci anni fa il messaggio «la libertà di scelta» aveva ottenuto una forza competitiva notevole: oggi i nodi vengono al pettine, nella condizione finanziaria fuori controllo del sistema.
Il mercato in sanità
La Legge regionale 31/1997, Norme per il riordino del sistema sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali, accentuava la possibilità di aziendalizzazione del sistema («accentuava» perché si avvaleva della L. 502/92); affermava la divisione netta fra Aziende sanitarie locali (Asl) e Ospedali azienda (Oa: tutti gli ospedali, a volte aggregati, diventavano azienda); evocava come economicamente risolutiva la concorrenza, fra pubblico e privato e fra pubblico e pubblico; poneva una netta divisione fra sanità e assistenza sociale, smentendo il titolo della legge. In Lombardia la «concorrenza senza regole» (per cui l’erogatore privato può scegliersi le prestazioni più remunerative), l’attribuzione da parte della regione del «socio-sanitario-assistenziale» agli enti locali, il pareggio di bilancio degli ospedali ottenuto non solo con il taglio agli sprechi ma anche con il taglio di ciò che non rende… avrebbero dovuto portare un risparmio e quindi un contenimento dei costi ed un miglioramento del servizio strettamente sanitario. Non è stato proprio così. Il successivo Piano socio-sanitario regionale (Pssr, del 2002), pur non essendo legge ma solo atto amministrativo, ha portato innovazioni normative che hanno ampliato gli enunciati liberisti della stessa Legge regionale 31/97, creando col tempo qualche contraddizione e problema nella stessa maggioranza.
Per capire le diatribe delle ultime settimane fra l’assessore leghista alla sanità Alessandro Cé e il presidente Formigoni è utile forse ricordare — oltre alle conflittualità interna alla destra a livello nazionale — come nel 1997 la Lega fosse all’opposizione e come criticò in modo tipicamente eclatante quella legge, insieme al centrosinistra, salvo poi accettarla nella legislatura successiva (2000-2005), una volta entrata in Giunta, approvando, oltre al Pssr, scelte oggettivamente impopolari come il taglio degli ambulatori sul territorio, la chiusura di alcuni piccoli ospedali, i ticket, i voucher in sostituzione dell’assistenza domiciliare, i «tetti di spesa» per singola struttura. Con i tetti di spesa infatti ogni ospedale o clinica, una volta raggiunto il budget dell’anno precedente non può continuare a fare prestazioni convenzionate: si afferma così una contraddizione dirigista soprattutto per chi si era fatto paladino del neoliberismo e dell’equilibrio attraverso il mercato. Parliamo qui di sistema sanitario e non di prestazioni, che in Lombardia erano e restano di alto livello. Di un sistema la cui realizzazione si sviluppa ormai in tre fasi: a) concorrenza fra pubblico e privato (L.r.31/97), b) il privato che entra nel pubblico (Pssr, del 2002), c) la privatizzazione con pagamento attraverso le assicurazioni (progetto ora rallentato ma che potrebbe riprendere nei prossimi anni, dopo la fase elettorale).
Inadeguati all’appuntamento della cronicità
Il progressivo positivo invecchiamento della popolazione e il conseguente prolungarsi del periodo di cura, l’ordinaria convivenza con la cronicità, l’incremento della non autosufficienza, la scoperta (e la prospettiva è quella di un’accelerazione) di nuove terapie e tecnologie diagnostico-terapeutiche che permettono finalmente di curare un numero crescente di patologie, risultano cause oggettive dell’incremento della spesa.
In Lombardia però, l’affidamento della sanità al mercato — soprattutto quella ospedaliera legata alla fase acuta della malattia — ha esaltato l’aumento della spesa sanitaria. Il pagamento a prestazione (Drg) ambulatoriale e ospedaliera, l’«aziendalizzazione spinta» e la concorrenza senza regole hanno provocato un effetto moltiplicativo sui costi, in quanto diverse entità — comprese ormai quelle pubbliche — hanno selezionato i casi più remunerativi e aumentato diagnosi ridondanti quando non improprie o addirittura pericolose. Col tempo si è verificato come alla teorica possibilità di «libertà di scelta» non sia corrisposta un’effettiva possibilità e capacità di scelta: la richiesta e la scelta sono indotte spesso dall’offerta e dalla sua comunicazione (fino al limite che è l’erogatore che sceglie il cliente più remunerativo), talvolta dalla migrazione terapeutica con il moltiplicarsi degli esami. Il costo dei farmaci, pur rilevante, non pare la causa prima dell’esplosione della spesa in Lombardia: questa viene piuttosto indotta da una logica privatistica (il risultato economico prima di quello sociale) infiltratasi anche negli ospedali pubblici.
Eliminati sprechi e inappropriatezze, i costi della sanità restano comunque alti e sottostimati rispetto agli altri Paesi europei e impongono il tema dell’individuazione delle risorse. Al contrario di chi propone di mettere il costo delle prestazioni a carico di chi ne usufruisce (ticket, assicurazioni), l’equità vorrebbe che il finanziamento della sanità rimanesse a carico della fiscalità generale evitando di incamminarsi verso un sistema di tipo assicurativo simile a quello americano, proprio mentre negli Usa si chiede la fine di tale sistema. Il tema dei costi della sanità e in particolare dei farmaci riguarda specificatamente i portatori di patologie croniche (cardiovascolari, diabete, degenerative) e il settore della psichiatria, proprio perché in tali casi l’onere del ticket diventa prolungato nel tempo e chiaramente insostenibile (per le malattie mentali è già difficile che il malato chieda di essere curato, e incerto risulta il confine fra sanitario e sociale).
Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Sssn) è oggi assicurato dal Fondo Sanitario Nazionale distribuito annualmente fra le regioni e da queste alle Asl secondo parametri indicati dalla legge. Il Fondo Sanitario Nazionale è finanziato per il 90% dall’Irap e dall’addizionale Irpef, quindi dalla fiscalità generale. Considerando che l’Irap è destinata all’abolizione, non si comprende come potrà essere sostenuto, da parte di questo Governo, il Ssn se non con uno scarico dei costi direttamente sul malato. Se al monopolio regionale pubblico (che non c’è mai stato in Lombardia) si sostituisce un oligopolio privato non si ottiene un buon risultato. Occorre una prospettiva dove fra pubblico e privato (possibilmente sociale) vi sia un pluralismo effettivamente paritario. Dove la libertà di scelta non pregiudichi la garanzia dell’universalità delle prestazioni e la loro qualità. Il rapporto pubblico privato deve essere progettato nella prospettiva della complementarietà e della parità di regole, riconoscendo a chi sostiene oneri maggiori per l’emergenza e la rianimazione risorse adeguate.
Delegificazione : la via amministrativa alla devolution
Una lettura sintetica del piano propone tre nodi problematici:
a) Titolarità della competenza sanitaria e responsabilità dell’ente pubblico. La Regione vuole dare di sé una posizione di «sedicente terzietà», nella prospettiva del suo ruolo esclusivo di regolatore del sistema, ma non si dice chi diventa il nuovo titolare della tutela della salute dei cittadini in Lombardia, tanto più dopo la riduzione del ruolo delle Asl a Pac (Programmazione, acquisto, controllo). Dopo l’esternalizzazione dei servizi (che negli ospedali riguardano ormai non solo la pulizia e la mensa ma anche l’ematologia e la radiologia e nelle Asl la prevenzione e gli screening) si passa ora alla terziarizzazione dell’intero sistema. Più che il passaggio da un «Welfare evoluto» ad un «Welfare devoluto» ci si avvia in Lombardia verso una dismissione dalla titolarità della responsabilità del Welfare, confermando quell’attacco al sistema delle garanzie già presente su altri fronti.
Le forme assicurative ipotizzate e previste potrebbero preludere all’uscita dal Ssn o, comunque, prefigurare una sostituzione dei fondi oggi derivanti dalla fiscalità generale con un premio assicurativo: un sistema «altro» rispetto alla tradizione europea. L’assicurazione si traduce infatti in una nuova tassazione, dove il cittadino paga il premio non in proporzione al proprio reddito ma sulla base del proprio rischio sanitario.
b) Riconversione privatistica delle strutture e ruolo delle comunità locali. Il passaggio verso il sistema assicurativo è prospettato — furbescamente — attraverso lo strumento delle fondazioni. Le fondazioni hanno, soprattutto in Lombardia, una tradizione di non lucratività, di beneficienza, di promozionalità, ed evocano un concetto positivo. Ma nel Piano della Lombardia, anticipando quanto poi sancito dalla legge nazionale sugli Irrcs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: Policlinico, Besta, Tumori, S.Matteo di Pavia), si introduceva un concetto ambiguo: la «fondazione di partecipazione», che sostanzialmente rimanda a istituti che possono dare origine a società commerciali. Si prevede anche la possibile presenza dei comuni ma cosa potrebbero dire in quella sede i sindaci, sempre che le autonomie locali — che non dispongono di capitali e sono oggi compresse dalla Finanziaria — possano entrarvi? Con la Legge regionale 31/97 della Lombardia i sindaci possono dire qualcosa (poco) nelle Asl, ma nulla negli ospedali, pur avendo il D.Lgsl. 229/99 riconosciuto loro diverse competenze. Ma la stessa procedura di approvazione del Pssr ha contraddetto le attribuzioni previste dalla L.r. 31/97 che voleva il Piano formalmente sottoposto all’esame preventivo della Conferenza dei sindaci delle Asl.
Ciò che va riconosciuto alle Aa.Ll. non è tanto la possibilità estemporanea di interlocuzione con il direttore generale, ma un ruolo di valutazione del piano regionale, di verifica del piano attuativo locale, di giudizio sull’impiego delle risorse per l’integrazione, di riconoscimento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria (ai sensi dell’art.3 c.3 della L.r. 1/2000), di rapporto istituzionale dei sindaci con gli ospedali, di valutazione dei Direttori generali. I sindaci di tutta la Lombardia (e quindi di tutte le colorazioni) avevano fatto sapere, attraverso le loro Conferenze delle Asl, di sentirsi coinvolti e coinvolgibili nella sanità perché sono loro ad avere un costante rapporto diretto con la popolazione, perché è nelle comunità locali che sono nati gli ospedali, perché già oggi — con l’invecchiamento della popolazione — devono organizzare servizi di trasporto (verso prestazioni sempre più lontane, vista la scomparsa degli ambulatori) e d’assistenza (tanto più necessarie con le dismissioni ospedaliere precoci), con pesi crescenti sulle Residenze socio-assistenziali nate e spesso collegate ai Comuni.
c) Fragilità del riferimento socio-assistenziale. Oggi si paga, in Lombardia lo svilimento della dimensione territoriale: in particolare di fronte alle patologie cronico-degenerative, il tema degli anziani non autosufficienti dovrebbe diventare un obiettivo esplicito. L’assistenza domiciliare integrata (Adi), oggi in Lombardia sostanzialmente non c’è più, neppure dove era stata positivamente avviata.
Il Terzo settore e le reti familiari non possono essere utilizzati citando la sussidiarietà per riversare su di loro incapacità o errori gestionali.
Un quadro costituzionale in movimento
L’autonomia regionale in campo sanitario risulta oggi accentuata rispetto al 1997 dalla modifica del titolo V della Costituzione. Il contrasto esistente fra legislazione nazionale (in particolare L. 229/99) e legislazione regionale (L.r. 31/97) viene in parte sanato a vantaggio di quest’ultima nel nome dell’autonomia riconosciuta dalla modifica costituzionale varata dal centrosinistra. Ma nessuno potrà prescindere dai Principi generali dell’attuale Costituzione (finché dura) e richiamare la responsabilità statale in tema di tutela della salute su un uniforme livello essenziale (e non minimo), senza disuguaglianze fra Regioni (art. 32, 3 c.2, 117, 118 Cost.). Abbiamo segnalato il problema sanità ma analogo interrogativo riguarda l’applicazione della L. 328/2000 sull’assistenza, snobbata in Lombardia perché realizzata dal governo di centrosinistra.
Non interessa qui una disquisizione giuridica fra legislazioni nazionali e regionali che hanno invaso di contenziosi la Corte, quanto piuttosto le scelte concrete che stanno ricadendo sul territorio. In questo senso, le risposte finora date restano sostanzialmente incerte se non addirittura contraddittorie. Se poi di devoluzione si dovesse trattare per la sanità allora si vedrebbe aprire nel paese una pericolosa concorrenza fra regioni. Ma questo è un altro capitolo.