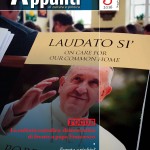Appunti 5_2005
Giuseppe Lazzati: dalla cella alla città
| Francesco Paolo Casavola |
Dagli anni della prigionia fino a quelli del rettorato della Cattolica e poi della progettazione di un servizio di formazione al «pensare politicamente» dei credenti, l’educazione alla cittadinanza fu un criterio permanente della sollecitazione lazzatiana agli intellettuali di non chiudersi nella torre del sapere. Questa missione aveva come fonte una limpida centralità dell’«uomo interiore», del raccoglimento e della preghiera.
Ho conosciuto Giuseppe Lazzati solo nell’ultima parte della sua vita. Di oltre venti anni minor natu, ero stato lettore dei suoi scritti, ma non ebbi con lui occasione di incontro e di amicizia se non quando fui per assumere il peso della presidenza nazionale del Movimento dei laureati, rinnovato nel Meic. La sintonia intellettuale e morale fu tra noi immediata. E il primo frutto fu un seminario sull’idea di progetto storico dell’età montiniana dagli anni Trenta agli anni Ottanta, realizzato in collaborazione tra Università cattolica del Sacro Cuore e Meic.
Del Movimento laureati, Lazzati era stato nominato dall’Arcivescovo Montini nel 1956 presidente a Milano e nel 1958 per l’intera diocesi ambrosiana. Ma da quegli anni aveva fatto tante cose e così importanti che il suo ritorno al Movimento rinnovato, fino a divenirne nel 1983 consigliere nazionale, destava qualche meraviglia. In realtà l’interesse ch’egli tornava ad avere per il Meic si legava strettamente alla sua fondamentale intuizione che il cristianesimo va vissuto nel quotidiano, nelle minute e diffuse esperienze della vita delle persone e della società, dentro le quali soltanto la cultura e la religione si illuminano e si cercano vicendevolmente. Fuori da codesta capillarità stanno solo astratte proclamazioni di principio, sogni di impossibili restaurazioni di totalitarismi confessionali, vampate ardenti che finiscono nella cenere di un cristianesimo nominale reciso dalla realtà. Lazzati non per nulla aveva ramificato, attorno alla Cattolica, i Centri di cultura, i corsi di aggiornamento; sentiva acutamente l’esigenza di non rinserrarsi nella roccaforte della fede e del sapere, ma di raggiungere ogni parte del corpo del paese. Il Meic, movimento non di massa, ma diffuso, gli appariva ancora un’altra via per andare verso le piccole dimensioni di ogni giorno e di ogni dove, consapevole che nel feriale, nell’ordinario, nel periferico, non nel clamore della festa, nell’eccezionalità dei grandi incontri, nella centralità delle capitali culturali e religiose, matura l’intelligenza silenziosa della fede, che conforma la vita, ne esprime i sensi nascosti.
La parola e la «cella interiore»
La Lettera a Diogneto era stata oggetto del suo primo corso di Letteratura cristiana antica nell’anno accademico 1938-1939. Quell’antico testo, che chiamava i cristiani alla condivisione di tutte le realtà umane con gli altri uomini, e a diventare anima orante del mondo e sale della terra, doveva essere di orientamento per Lazzati, cosi come per i Laureati, per la scelta consapevole e rigorosa di uno stile di vita cristiana idoneo a realizzare secondo le peculiarità del nostro tempo la missione laicale, nella Chiesa e nella società civile.
Lazzati rasserenava con il suo volto aperto e il suo parlare pacato e piano. Lo ascoltai una volta alla parrocchia romana del Labaro commemorare Vittorio Bachelet. Le persone più semplici e umili pendevano dalle sue labbra. Mi venne in mente la regola dei suoi Padri della Chiesa, populis populariter loquendum. Ma egli parlava così anche ai papi, ai dotti, ai grandi leader della vita pubblica. Sanno parlare così, dando chiarezza alla mente e coraggio alla volontà di chi li ascolta, gli uomini che hanno visto le sofferenze del mondo e i limiti della natura umana.
Lazzati questa esperienza di dolore e di degradazione l’aveva vissuta, prigioniero di guerra dei tedeschi, in due anni di campo di concentramento in Prussia e in Polonia. Fu allora ch’egli sperimentò la salvezza «del raccoglimento in Dio e con Dio nella cella nostra interiore custodita con cura da ogni vana inframmettenza». La «cella nostra interiore» nella quale ritirarsi per il colloquio con Dio è la metafora della dignità umana. Quando il mondo sociale si fa oppressivo, l’uomo può in ogni istante ritrarsene per incontrare il suo Creatore. L’impegno di Lazzati fu tutto speso perché nel nostro tempo scoprissimo insieme questa grandezza dell’uomo. E così le città dell’uomo — la società civile, lo Stato, la Chiesa stessa nelle sue dimensioni più temporalizzate — vanno modellate e costantemente riformate per rispettare una tale suprema misura dell’uomo che si apparta con il Signore.
Educare alla politica
Ecco perché Lazzati, dalla Costituente fino ai suoi ultimi giorni, ha incessantemente richiamato all’educazione alla politica. Egli, uno dei padri della Costituzione, valutava con realismo il degrado della vita pubblica, il piccolo cabotaggio di ambiziosi, di rissaioli per una fetta di potere, il respiro sempre più corto e asfittico del disegno di riforme e di avanzamento della nostra democrazia, il rischio mortale della delega rappresentativa come dismissione di ogni dovere di partecipazione democratica e di costruzione nel paese reale della coscienza politica.
Egli avvertiva acutissima la responsabilità degli intellettuali in questo compito corale di «coeducazione» popolare alla politica. Voleva perciò che l’istituzione universitaria, il luogo elettivo della formazione degli intellettuali, si ispirasse alla interdisciplinarità e si attrezzasse per l’educazione permanente degli adulti. L’interdisciplinarità per cogliere la complessità della condizione umana, e respingere gli attentati di arbitrarie e nefaste semplificazioni, nonché la sterilità di tragicomici monologhi monodisciplinari; l’educazione permanente, perché, ancora una volta, la cultura, per un cristiano, è elevazione del sapere e della coscienza popolare, non piedistallo di distinzione o di potere di alcuni.
Egli possedeva dunque progetto e strumenti di un costruttore: ora che la sua giornata di lavoro si è conclusa, proviamo tutti a proseguirne l’opera, dalla «cella nostra interiore» alla città dell’uomo. Proviamo tutti, ma ciascuno a suo modo.
In questi quasi venti anni dalla sua uscita dalla vita terrena si sono consumate o sono in corso tante vicende sui cui avremmo voluto ascoltarlo, avere un suo giudizio o consiglio. E forse non noi soltanto, ma anche i non credenti nostri contemporanei. Paolo VI ebbe a dire che il mondo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri: e se ascolta i maestri lo fa quando sono testimoni. Lazzati è un testimone di un tempo che oggi sta giungendo al suo Kairós. La secolarizzazione è come un’onda stanca che rinuncia a sommergere la riva.
Scopriamo le religioni che erano state date per sconfitte da una astratta e astorica civiltà della ragione. Ma con esse nuovi e più complessi problemi che il Novecento non ha conosciuto. Se rievochiamo gli anni di mezzo di quel secolo, tra la seconda guerra e il Concilio, ci vediamo pensare con categorie, già allora scricchiolanti per lo sforzo di andare oltre le eredità di una cultura occidentale, che si illudeva di riassumere in sé l’intero pianeta.
Ci confrontiamo oggi con religiosità diverse dalla nostra che non distinguono le cose di Dio da quelle del mondo. La laicità certo ci appare oggi come non mai una straordinaria conquista del cristianesimo, sia pure raggiunta attraverso un doloroso millenario cammino di conflitti tra Stato e Chiesa, scienza e fede, utopia ed escatologia, storia del mondo e regno di Dio. E la laicità è stata una stella polare nell’itinerario intellettuale, politico, religioso di Lazzati. Indichiamone due tratti.
La cittadinanza civica
La preghiera e la costruzione della città dell’uomo. La preghiera, come esercizio quotidiano di colloquio con Dio, vale a far riflettere all’uomo che il suo destino è contemplare e amare Dio, non i beni del mondo. Con questa energia Lazzati richiamava alla preghiera ogni cristiano, qualunque missione eserciti «fosse pure la missione di papa. Tanto è vero che San Bernardo da Chiaravalle, rivolgendosi a papa Innocenzo III, usciva con questa durissima espressione: «Maledette le tue occupazioni se ti impediscono di pregare». Ed erano le occupazioni di un Papa»2. La preghiera è l’ascolto del Signore della storia. Come diceva Giovanni Crisostomo: «L’uomo che prega ha le mani sul timone della storia»3.
La meta verso cui conduce questo abito della preghiera non è l’estraniamento dei compiti temporali, è anzi l’impegno nel loro adempimento per dovere di cittadinanza nella città terrena, laicamente distinta dalla Chiesa, che come insegna il Concilio nella «Gaudium et spes» 7-6, «in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica». Lazzati, maestro e testimone di vita cristiana e di vita politica, ci sia ancora di guida, come allora, più di allora.
1 Introduzione all’incontro svoltosi in Università cattolica il 27 settembre 2005, in occasione dell’uscita della voce biografica su Lazzati nel Dizionario biografico degli italiani (di Nicola Raponi).
2 Dossier Lazzati, Lazzati uomo di preghiera, Ave, Roma 2004, p. 91.
3 G. Lazzati, La preghiera del cristiano, Ave, Roma 1986, p. 129.