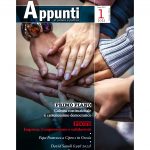Appunti 4_2005
Il debito estero: una opportunità di speranza
| Gianni Vaggi |
Il debito estero dei paesi in via di sviluppo non è questione passeggera, per ragioni strutturali. Occorre una visione della sua sostenibilità che sia ampia e non menzognera, e sia completata da piani concordati di rientro o di riduzione.
“È più facile per una nazione, allo stesso modo che per un individuo, passare da un modesto grado di ricchezza alla più grande opulenza, che raggiungere questo modesto grado di ricchezza”.
(Adam Smith, Abbozzo de La Ricchezza delle Nazioni, circa 1763)
Il finanziamento allo sviluppo
I paesi in via di sviluppo soffrono di deficit strutturali della bilancia commerciale e anche della bilancia corrente, nonostante la crescente importanza delle rimesse degli emigranti. Ciò deriva da una struttura produttiva debole, o per lo meno debole secondo i parametri del commercio internazionale, per cui la produzione ed anche le esportazioni sono legate al settore primario, mentre questi paesi dipendono dai paesi ricchi o da quelli emergenti dell’Asia per l’importazione di beni capitali, ivi incluse le infrastrutture. Vale la pena di ricordare che anche quando le esportazioni sono caratterizzate da prodotti di alto valore, minerali, petroli, gemme preziose, ciò non aiuta particolarmente, perché la struttura produttiva resta debole. Anzi l’alto valore di questi beni può portare più facilmente a corruzione, economie di rendita e conflitti, soprattutto in Africa, il che non aiuta la modernizzazione del sistema produttivo. In sostanza questi paesi necessitano di tempo per acquisire una struttura della produzione e delle esportazioni che li renda meno «deboli». Per confermare la frase di Smith basti notare che non esistono paesi che siano passati da condizioni di basso reddito a condizioni di reddito alto o medio alto in meno di una generazione (venticinque anni) e sono pochissimi quelli che vi sono riusciti, le solite tigri e tigrottine asiatiche. Insomma lo sviluppo non si improvvisa, nemmeno quello economico.
Ma c’è un altro problema che rende difficile il passaggio ad una struttura economica più solida: la mancanza di risparmio interno. Nella teoria dello sviluppo tradizionale l’accumulazione di capitale e quindi di strutture produttive deriva dall’investimento, e quindi dal risparmio. Il risparmio interno non raggiunge il 10% del Pil, il che rende difficile l’investimento e l’accumulazione e quindi anche la diversificazione produttiva. D’altra parte gli Investimenti diretti esteri (Ide), che sarebbero il modo migliore per finanziare l’accumulazione di capitale con fondi esterni, non si dirigono verso i paesi più poveri che in misura minima. I paesi più poveri dell’Africa subsahariana ottengono Ide per valori inferiori all’1% del Pil ed a volte inferiori allo 0.50%!! Né ovviamente vanno in questi paesi investimenti di portafoglio, cioè sostanzialmente acquisizioni di azioni o obbligazioni.
Di qui la necessità dei prestiti agevolati, tipo Ida, International Development Association, della Banca Mondiale, con tassi di interesse molto bassi e scadenze molto lunghe, 25-30 anni. Inoltre continueranno ad essere necessari gli aiuti allo sviluppo. E’ chiaro che ci può essere un eccesso di aiuti e/o prestiti agevolati rispetto alla capacità di assorbimento di un paese; è altrettanto ovvio che gli aiuti vanno gestiti bene e che vi deve essere una responsabilità precisa da parte dei paesi che li ricevono. Detto questo, aiuti e prestiti agevolati dovranno restare ancora per parecchio tempo.
L’insieme di queste due considerazioni ci dice che il problema del finanziamento allo sviluppo non è né un problema di carità, né un problema temporaneo, ma richiede e richiederà una strategia, un patto globale come recita l’ottavo Millenium Development Goal delle Nazioni Unite, per le generazioni a venire. Insomma è probabile e necessario che ancor per un bel po’ ci sia chi presta e chi si indebita ricevendo. E’ per questa ragione che bisogna individuare un criterio ed un percorso di sostenibilità del finanziamento estero, per cercare di evitare, o almeno «smussare», le possibili crisi.
La sostenibilità del debito estero
Per molti anni, a partire dalle primi crisi del debito dell’inizio degli anni Ottanta, l’idea di sostenibilità è stata sostanzialmente solo di natura finanziaria. Cioè bisognava pagare puntualmente quote capitale ed interessi senza accumulare arretrati e senza ricorrere al cosiddetto rescheduling, cioè la modifica delle condizioni, tasso di interesse e soprattutto durata, del debito stesso. Questo era ed ancora è per molti paesi lo scopo delle varie negoziazioni al Club di Parigi. Il concetto di sostenibilità che emerge è quindi, almeno nella sua prima parte, essenzialmente di natura finanziaria, ovvero concerne la capacità di far fronte alle obbligazioni contrattuali assunte. In sostanza alla fine il debito deve essere ripagato e quindi deve andare a zero, magari in un futuro molto distante, o addirittura all’infinito. Se l’azzeramento del debito è prevedibile solo all’infinito allora la sostenibilità del debito viene definita in linea generale come lo stato in cui il rapporto tra lo stock di debito esistente ed il Pil tende a diminuire progressivamente nel tempo. E’ questa anche la linea seguita nel trattato di Maastricht a proposito del rapporto Debito pubblico/Pil.
Solo nel 2001 Banca mondiale e Fondo monetario internazionale affermano che la sostenibilità del debito va intesa come «la capacità di soddisfare pienamente il servizio del debito attuale e futuro, senza ricorrere a debt rescheduling o all’accumulazione di arretrati, e senza compromettere la crescita»2. Quindi si riconosce che la tutela delle condizioni di crescita economica è un aspetto importante della nozione di sostenibilità. Due considerazioni. In primo luogo, la cosa è ovvia visto che di solito si indica il grado di indebitamento sempre rispetto a delle grandezze macroeconomiche, per l’appunto il Pil o le esportazioni, quindi la bassa crescita, o addirittura negativa, peggiora gli indicatori di debito. Secondo, sono ormai passati diciannove anni dall’esplosione della crisi del debito del Messico (agosto 1982), un tempo davvero lungo per inserire il criterio della salvaguardia della crescita nel concetto di sostenibilità.
Bisogna ricordare che già dal 1996 c’è l’iniziativa Hipc (Heavily Indebted Poor Countries), relativa ai paesi più poveri del mondo fortemente indebitati, in cui si accetta per la prima volta il principio che parte del debito possa essere cancellato; questa iniziativa viene «rafforzata» dopo il G8 di Colonia del 1999. Ovviamente può essere cancellata quella parte di debito che è ritenuta «insostenibile». Ecco che si riaffaccia la «sostenibilità», ma chi giudica se un debito sia sostenibile o meno? Ancora una volta Banca Mondiale e Fondo Monetario, mediante una Debt Sustainability Analysis, Dsa, che si basa su alcune ipotesi, in particolare relativamente alla possibile crescita futura dei paesi indebitati. E’ ovvio che è sufficiente supporre un elevato tasso di crescita futuro e molti paesi avranno un debito sostenibile. Di solito si costruiscono scenari di crescita per un periodo di 5-6 anni, che è davvero poco calcolando che stiamo parlando di paesi le cui economie sono molto «deboli» e quindi richiedono tempo per rinforzarsi.
Ma soprattutto i tassi di crescita adottati per la Dsa sono spesso assolutamente troppo ottimistici. In un lavoro del 2002 per 35 dei 41 paesi Hipc ho confrontato i tassi di crescita storici dal 1960 con quelli adottati da banca e Fondo nella DSA. Per 23 paesi il tasso di crescita supposto era più alto di qualunque tasso di crescita mai avuto negli ultimi quattro decenni. Se si considerano i tassi di crescita dalla metà degli anni Ottanta in poi e quindi quelli che rispecchiano meglio le condizioni economiche attuali, solo due paesi, Vietnam e Uganda hanno sperimentato per alcuni anni tassi di crescita superiori a quelli ipotizzati nella DSA3. Non vorrei fermarmi sulle technicalities, ciò che è assai grave in queste operazioni è la evidente mancanza di obiettività, o forse bisognerebbe dire di sincerità delle stesse.
Il rapporto di debito è un rapporto di fiducia delle due parti e non solo del creditore, cioè entrambe le parti devono riconoscere come accettabili, giuste, fair le condizioni. Se questa percezione manca da una o entrambe le parti manca la fiducia ed il rapporto si logora e degenera. Banca e Fondo non danno quell’immagine di arbitri imparziali che forse dovrebbero avere e le analisi di sostenibilità finora condotte sono sembrate più che altro un modo di tirare avanti cercando di cancellare il meno possibile e rinviando il problema al futuro, sperando in una improbabile crescita economica. Non che le analisi economiche possano aspirare ad essere definite «vere», ma è certo che l’adozione di modelli ed ipotesi realistiche potrebbe contribuire non poco ad avvicinare le posizioni di debitori e creditori.
Negli anni Novanta molti studiosi e Ong hanno invocato criteri di sostenibilità del debito dal volto umano4, che oltre alla crescita hanno individuato come elemento essenziale dell’idea di sostenibilità la salvaguardia ed il miglioramento continuo e costante delle condizioni di vita della popolazione. Anch’io ha fatto un tentativo in questo senso5. Inutile dire che queste visioni della sostenibilità sono state a lungo relegate nel «buonismo» e solo verso la fine degli anni Novanta e poi con il nuovo secolo hanno ripreso forza.
Un esempio dei limiti dell’idea ufficiale di sostenibilità e della stessa iniziativa Hipc recepita dagli organismi internazionali sta nel constatare che per molti paesi — Bolivia, Tanzania, Burkina Faso e Uganda — che hanno completato l’iniziativa Hipc gli indicatori di debito (ad esempio il rapporto debito/esportazioni), hanno già superato nuovamente le soglie giudicate insostenibili prima dell’ottenimento dei benefici dell’Hipc. In uno studio recente emerge che dei 27 paesi che hanno beneficiato dell’iniziativa Hipc solo pochissimi, da 1 a 3 a seconda dei criteri, hanno raggiunto una sostenibilità compatibile con lo sviluppo umano6.
Gli «Obiettivi del Millennio» e il «post-Washington Consensus»
Da alcuni anni vi è una strana e sembrerebbe favorevolissima situazione nel dibattito sullo sviluppo e questo è ben riassunto nei Millenium Development Goals fissati dall’Onu nel 2000. L’accordo pare essere estesissimo sia sui concetti che sugli interventi. Lo sviluppo non è solo economico ma anche umano, la lotta alla povertà è una priorità, non bastano le riforme economiche, ma sono necessarie buon governo e responsabilizzazione. La partecipazione dei paesi poveri alle strategie di sviluppo e di lotta alla povertà è un elemento essenziale (Poverty Reduction Strategy Papers). Le istituzioni ed il capitale umano e sociale sono elementi importanti dei processi di sviluppo e si potrebbe continuare a lungo. Questo insieme di temi e dibattiti ha portato ad una convergenza non irrilevante nei punti di vista e negli elementi di giudizio sullo sviluppo, a questo insieme di idee e politiche si da il nome di «post-Washington Consensus», termine usato per la prima volta da Joseph Stiglitz nel 1998. Ci sono varianti sia nel titolo che nei contenuti, ma sembrerebbe comunque di essere in un periodo di grande concordia sia sulle analisi delle cause della povertà sia sulle misure da adottare.
A questo si aggiunga che i paesi più ricchi si sono ripetutamente impegnati ad una serie di azioni, dalla cancellazione del debito ai paesi poveri, al sostegno all’Africa, all’aumento degli aiuti pubblici allo sviluppo. Non passa G8 che non ci sia una qualche dichiarazione/impegno in tal senso. Particolarmente importante è stata la conferenza sul finanziamento allo sviluppo tenutasi a Monterrey nel marzo 2002, in cui gli impegni in questo senso si sono iper-moltiplicati. Ora ci sono l’obiettivo dello 0.7% del Pil in aiuti, le nuove International Financial Facilites proposte da Gordon Brown, il Global Fund per la lotta all’Aids, si parla pure di possibilità di rivalutare le riserve auree del Fondo Monetario Internazionale e di mettere tasse di sviluppo sui biglietti aerei e forse un domani sulle transazioni finanziarie. Siamo insomma tornati al tema del finanziamento allo sviluppo.
Ed in effetti è stato proprio il tema del debito che dalla seconda parte degli anni Novanta in poi ha contribuito ha rinvigorire questi dibattiti ed anche ad orientarli. In questo processo l’anno 2000 ed il connesso Giubileo hanno svolto un ruolo fondamentale e non solo per la Chiesa cattolica e per il mondo cristiano. Quel Giubileo e gli interventi di Giovanni Paolo II hanno anche affermato una attenzione speciale della Santa Sede sui temi della giustizia internazionale e della pace. Questa convergenza di opinioni rappresenta una enorme sfida e una grande possibilità, ma proprio per questo il fallimento delle aspettative che si sono create sarebbe ancora più grave, e qualche segno preoccupante già si intravede. Se nulla cambiasse, se le promesse fossero regolarmente disattese, se si tornasse al solito primato non della politica, ma della realpolitik o degli interessi e degli egoismi nazionali e privati di breve periodo, allora la delusione ed il prezzo di questa potrebbero essere enormi.
Ed è proprio per questo che è necessario che la voce della Chiesa si alzi ferma, chiara e incessante nel chiedere il rispetto dei patti: pacta sunt servanda dice il Messaggio per la Giornata della pace del gennaio 2003. Questo forte richiamo al rispetto degli accordi presi (e aggiungo delle promesse fatte), ritorna nel Messaggio del 2004.
La speranza nel nuovo patto
I dibattiti sul debito ed il Giubileo offrono una grande opportunità perché propongono di eliminare le ingiustizie del passato e di stabilire un nuovo patto. Le ingiustizie sono anche le «furberie» nel valutare la sostenibilità dei debiti, le clausole finanziarie strane e vessatorie, le promesse non mantenute. Il nuovo patto comprende fiducia, nel senso di apertura di credito, ma anche e soprattutto speranza e entusiasmo. Nel Messaggio per la Giornata della Pace del 2005, l’ultimo di Giovanni Paolo II, ritroviamo il tema del debito, e anche quello purtroppo delle mancate promesse nell’aiuto pubblico allo sviluppo7. Voglio sottolineare l’aspetto della fedeltà al problema e quindi della coerenza per ricostruire un rapporto di fiducia fra Nord e Sud del mondo. La coerenza richiede sincerità e — seguendo Max Weber — potremmo dire una politica della responsabilità, che quindi sappia coniugare gli interessi delle parti con una visione strategica.
Nella «Pacem in Terris» Giovanni XXIII ci ricorda che la pace è sorretta da quattro pilastri: verità, giustizia, amore e libertà, in quest’ordine. C’è una verità umile, semplice concreta: quella che si basa sulla sincerità, sulla schiettezza dei rapporti. Questa verità è così necessaria e eppure rara: forse è ciò di cui la politica internazionale ha oggi maggior bisogno, perché solo così si può costruire fiducia. Giovanni Paolo II ha di fatto aggiunto un tassello ai quattro pilastri della pace presenti della «Pacem in Terris»: il perdono. Questo tema era già presente nel Messaggio per la giornata della Pace del 1997, ma ritorna con forza ed insistenza nel corso degli anni duemila. C’è bisogno per tutti di ri-cominciare, non si può continuare con le istituzioni, gli schemi economici e finanziari, i comportamenti che hanno caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta. Questi non sono sostenibili. Del perdono non bisogna avere paura, non è l’indice di un fallimento, ma di una speranza, anzi di più, scrive Giovanni Paolo II: «quella particolare forma di amore che è il perdono»8.
Il vantaggio della Chiesa sulle istituzioni finanziarie e politiche laiche sta nella possibilità dell’incessante richiamo a questi criteri di giustizia condivisi, non si tratta di morale ma di una vera e propria esigenza politica quanto mai attuale. Si troveranno schemi di sostenibilità migliori possibili, nuovi patti che regolino i rapporti economici e finanziari fra Nord e Sud del mondo; tutto ciò è necessario soprattutto in un ottica di lungo periodo. Ma a ciò il messaggio della Chiesa deve unire un’altra urgenza; ora ed adesso ci sono persone che soffrono e che richiedono aiuto, la giustizia sta anche nel darsi istituzioni e strutture eque e condivise, e non imposte da alcuni, ma anche nel prendersi cura di chi oggi nell’immediato ha bisogno. Insomma la Chiesa deve preoccuparsi contemporaneamente del lungo periodo, della politica internazionale, ma anche del breve periodo, di chi ora ha bisogno. Se le istituzioni finanziarie internazionali non saranno riformate, se i debiti verranno cancellati con il contagocce, se gli aiuti non verranno aumentati, se le negoziazioni commerciali fra ricchi e poveri vedranno i secondi sempre soccombere, allora avremo tutti insieme perso una occasione. Anche di questo Cristo ci perdonerà, grazie al suo amore passeremo attraverso la cruna dell’ago, ma avremo lo stesso mancato verso i nostri simili.
1 Testo ripreso dall’intervento al convegno: «Debito estero: a cinque anni dal Giubileo. Presentazione del Rapporto sul debito 2000-2005 “Impegni di giustizia”», venerdì 13 maggio 2005, Milano – Università Cattolica.
2 IMF e World Bank, Development Committee, The Challenge of Maintaining Long-Term External Debt Sustainability, New York 2001.
3 G. Vaggi, Trade and sustainable finance for development, Wider, Discussion Paper, 2002.
4 Unctad, Economic Development in Africa. Debt Sustainability: Oasis or Mirage?, United Nations Publication, New York 2004.
5 G. Vaggi, Sustainable debts and the ‘human factor’, in id. (a cura di), From the debt crisis to sustainable development. Changing perspectives on North-South relations, The MacMillian Press LTD, Basingstoke 1993.
6 Studio in corso ad opera di V. Prizzon, Università di Pavia.
7 Giovanni Paolo II, Messaggio per la giornata della pace 2005, p. 11
8 Giovanni Paolo II, Messaggio per la giornata della Pace del 2002, p. 1.