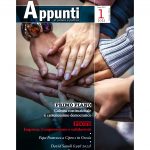Appunti 4_2005
Verso la sfida del governo. Intervista a Romano Prodi
«Appunti» intervista Romano Prodi nel momento in cui il leader dell’Unione ha lanciato una lunga campagna elettorale, e mentre si appresta a definire i dettagli della competizione per le «primarie» che sono state fissate per ottobre prossimo. Prescindendo dalle questioni — pur importanti e controverse — della struttura della coalizione e delle dinamiche interne ai diversi partiti dell’Unione, abbiamo inteso portare il candidato presidente a proporre qualche riflessione essenziale su un progetto di governo per il prossimo futuro e su una idea forte per il Paese. Le risposte non sono di prammatica, ma insistono su questioni non banali. Si tratta quasi di una introduzione e di una motivazione articolata di quelle priorità definite «Progetto per l’Italia» che Prodi ha proposto come sintesi del disegno politico dell’Unione, approvato dai partiti della coalizione alla fine del mese di luglio: riportiamo anche quel documento di seguito, perché ci pare degno di approfondita verifica e discussione. Ci torneremo sopra senz’altro nei prossimi numeri.
«Appunti»: Il trend elettorale positivo dell’Unione è un dato evidente. Anche se bisogna evitare di pensare a una vittoria sicura alle prossime politiche, occorre prepararsi a governare. Lei ha già lanciato l’esperienza della “fabbrica del programma”. Come sta lavorando? Che passi ulteriori ritiene indispensabili in questo senso?
Prodi: Non ho mai pensato di avere già la vittoria in tasca. Anzi, mi si deve dare atto di avere reagito persino allo straordinario risultato dell’Unione alle elezioni regionali con sobrietà e misura, senza indulgere al trionfalismo. Di più: con il senso di responsabilità che si conviene a chi deve mostrarsi all’altezza della pressante domanda di un’alternativa e di una futura responsabilità di governo. Al punto di dichiarare la nostra disponibilità a concorrere nel mettere a punto misure atte a far fronte a una pesante emergenza economica. Solo dopo aver assistito allo spettacolo non esaltante di manovre, balletti, conflitti dentro la Casa delle libertà, che fanno presagire un anno che non possiamo permetterci di sprecare, abbiamo responsabilmente prospettato l’esigenza di restituire la parola ai cittadini. A fronte della paralisi del governo, essa si configura come la via più limpida e persuasiva per venire a capo di una crisi senza sbocchi.
Circa il programma, da mesi ho attivato la cosiddetta «Fabbrica». E’ stato ed è un prezioso luogo di ascolto del paese in tutte le sue articolazioni: famiglie, lavoratori, attori economici, categorie sociali, professionisti, uomini di cultura, rappresentanti delle istituzioni. Un processo di ascolto che intendiamo sviluppare non solo a Bologna, sede della «Fabbrica», ma anche altrove, portando l’iniziativa della Fabbrica in giro per l’Italia come già abbiamo iniziato a fare a Bari, Vicenza e in Abruzzo. Si tratta solo dell’accumulo di domande, di idee, di spunti programmatici, cui seguirà un’opera più organica di elaborazione programmatica per la quale abbiamo insediato una cabina di regia cui partecipano i rappresentanti delle forze politiche e che si coronerà con un’assemblea dell’Unione che varerà il programma comune.
La costruzione di un programma è un passaggio cruciale per la sintesi politica di ogni coalizione di governo. Come giudica lo stato di avanzamento di questo amalgama? Siccome poi il programma va sintetizzato in alcune priorità forti che diano un messaggio chiaro e forte al paese, quali pensa siano le più importanti?
Indubbiamente, ci è chiesto di sviluppare un’elaborazione a tre livelli: l’ispirazione sintetica che presiede all’intero programma di governo; le idee-guida di esso da condensare in un messaggio politico suscettibile di essere comunicato e di mobilitare la partecipazione; le priorità programmatiche che orientano e qualificano un programma più dettagliato e analitico. Già a Milano, alla prima assemblea dell’Unione appena costituita, accennai a tre idee-guida, tutte ispirate al proposito di rimettere in moto le energie vitali di un paese in ginocchio. Penso alle politiche atte a contrastare il congelamento, la dispersione, la frustrazione delle energie vitali di cui dispongono le giovani generazioni, attori protagonisti del nostro futuro. Penso all’investimento sul Mediterraneo che, grazie al protagonismo delle nuove potenze che si affacciano sulla scena del mondo (dalla Cina all’India), può rappresentare un bacino economicamente, culturalmente e politicamente strategico per il futuro del pianeta e dunque anche per l’Italia. Penso infine all’immigrazione, da interpretare per davvero come risorsa più che come problema, in modo che la giusta esigenza di accrescere la sicurezza dei cittadini non faccia andare perso un patrimonio di energie vitali essenziali per un futuro di prosperità, di lavoro, di dialogo tra le culture, di giustizia e di pace.
Tutto questo presuppone due condizioni. La prima: il coraggio di dire tutta intera la verità agli italiani, dopo anni di irresponsabile demagogia e di occultamento dei nostri problemi e dei nostri ritardi. La seconda: la determinazione nello scommettere sull’attivazione responsabile dei nostri concittadini, la fiducia che il nostro paese può farcela ad uscire dalla profonda crisi in cui versa, anche a motivo di precise responsabilità imputabili al governo, dopo aver guardato in faccia, senza infingimenti, il rischio del declino che ci attanaglia.
Come giudica il dibattito che si è aperto sull’opportunità di smontare le riforme della destra? Quali sono i settori più urgenti dove occorrerà intervenire a suo parere?
La sua domanda evoca una disputa che francamente non mi ha convinto. L’interrogativo concernente la continuità o la cancellazione delle leggi varate dalla destra è mal posto, muove da un approccio sbagliato in radice. E’ scontato ed evidente che non si possa fare tabula rasa della legislazione di un quinquennio. Così pure è ovvio che non è buona norma immaginare che ad ogni avvicendamento alla guida dei governi, di diversa ispirazione, debba corrispondere l’azzeramento di ogni legge varata nel precedente ciclo politico. Il modo giusto di impostare la questione è semmai un altro e fa leva su due punti a me chiarissimi. Il primo, di ordine metodologico, suggerisce di muovere dal nostro autonomo programma e dalle leggi attuative di esso. Solo a partire di lì e su quel parametro si può poi stabilire ciò che è compatibile e ciò che non lo è della legislazione precedente. Il secondo è quello del carattere nitidamente alternativo del nostro programma rispetto a quello della destra. Altrimenti non si spiega perché noi ci proponiamo come una vera alternativa di governo. Fissati tali criteri, è comunque evidente che alcune leggi varate dalla Casa delle libertà dovranno essere letteralmente soppresse o fortemente rimaneggiate. Penso alle leggi ad personam, che non solo hanno ferito la nostra coscienza e intaccato l’immagine del nostro paese presso l’opinione pubblica internazionale, ma che hanno altresì inferto ferite al nostro ordinamento, specie nel campo della giustizia. Penso alla legge Gasparri scritta su misura degli interessi di Mediaset e contro lo sviluppo del pluralismo dell’informazione. Penso alla risibile legge sul conflitto degli interessi, che, al contrario, lo avalla e lo legalizza. Penso alla legge Bossi-Fini sull’immigrazione, concepita come un manifesto propagandistico. Penso infine allo stravolgimento della Costituzione con il suo sistema di garanzie che fa tutt’uno con i postulati di una democrazia liberale e pluralistica.
Secondo lei nella crisi del berlusconismo si intravedono anche le possibilità di rilanciare un percorso democratico alternativo, che coinvolga di più le forze sociali e le energie dei cittadini? Come può fare la politica del centro-sinistra a intercettare le molte disponibilità di una società un po’ delusa e ripiegata su se stessa (pensiamo al sociale, ai giovani, alle forme di ripensamento della globalizzazione)?
Difficile rispondere a una domanda così impegnativa. Mi limito a due spunti. Il primo concerne lo spirito che deve animare la nostra proposta. E’ un po’ quello che informò la campagna elettorale del ‘96, che suscitò partecipazione ed entusiasmo presso larghi settori della società civile. Si respirava il senso e la tensione a innovare le forme e gli attori della politica, dopo il collasso del sistema dei partiti che pure avevano avuto grandi meriti nell’instaurazione di una democrazia di massa nel nostro paese, ma che mostravano di aver esaurito la propria spinta creativa. «Democratica» deve essere la nostra proposta non solo per i contenuti, e cioè per l’espansione dei diritti di cittadinanza, ma anche per il metodo, quello di una democrazia che si nutre di partecipazione, che riattiva i canali di comunicazione tra società e istituzioni.
Il secondo spunto verte sulla ispirazione e sulla cifra di una politica che aspira a governare le sfide della globalizzazione. Qui forse si rinviene un elemento di discontinuità rispetto al ’96. Noi siamo certo impegnati a modernizzare il nostro paese, a contrastare corporativismi e rendite di posizione, a liberare le energie di cui dispongono l’economia e la società italiana. Si tratta di riprendere il cammino della modernizzazione che inesorabilmente passa attraverso l’Europa, dal quale l’attuale governo ci ha allontanato, contribuendo all’attuale momento di crisi dell’Unione Europea. La modernizzazione che vogliamo, oggi più di ieri, non può tuttavia affidarsi ai miti e ai dogmi del «pensiero unico». La politica deve assegnare a se stessa il compito alto e irrinunciabile di governare orientando i processi di modernizzazione verso più alti traguardi di giustizia e di pace. In Italia, in Europa, nel mondo. Direi meglio: muovendo dall’Italia, attraverso l’Europa, per un mondo nel quale alla globalizzazione dei mercati si accompagni la globalizzazione dei diritti.
Lei ha detto recentemente di sentirsi dossettiano quanto all’etica, ma di aver studiato una economia moderna alla London school of economics. Quali sono gli orientamenti fondamentali del suo progetto per l’economia italiana, sul tema della competitività e del declino, del fisco e dell’intervento pubblico?
Ma guardi che anche i dossettiani erano attenti all’economia moderna, anzi esprimevano per i tempi un pensiero economico di avanguardia quanto a ricerca e capacità di innovazione; basta andare a rileggere le pagine di «Cronache Sociali», la rivista del gruppo, dove si studiavano e si analizzavano proprio le teorie economiche della scuola inglese di quegli anni. Quello che dobbiamo mantenere di quella esperienza non sono le soluzioni, le tecniche economiche, che possono, anzi devono cambiare, come cambia la storia, come cambia l’economia mondiale. Quello che dobbiamo mantenere è l’ispirazione di fondo, la tensione ideale, la determinazione incessante ad intraprendere politiche economiche orientate allo sviluppo, ad uno sviluppo per tutti: una crescita umana e civile, e non solo economica. Questo è il lascito etico di quella generazione che ancora oggi noi dobbiamo tenere vivo e operante.
Quanto al progetto per l’economia italiana le dico subito che non può esserci crescita economica senza maturazione etica e che i problemi della competitività delle imprese, come del fisco, come del declino, si risolvono anche con uno scatto di orgoglio, uno scatto di reni da parte degli italiani che non si vogliono rassegnare a prospettive economiche negative. Le soluzioni al declino sono in un cambio di mentalità. Dobbiamo aprirci ai mercati del mondo, non chiuderci, non temerli: dobbiamo avere tra di noi e pretendere da altri più trasparenza, maggior rispetto delle regole, batterci per affermare una maggiore responsabilità sociale d’impresa. Dobbiamo avere imprese più forti e più grandi in grado di affermarsi sui mercati esteri tanto quanto dobbiamo lavorare per creare le condizioni sociali e culturali migliori per attrarre nuovi investimenti nel nostro paese.
A volte si parla, a sproposito aggiungo io, delle ricchezze degli italiani, ricchezze pari ad otto volte il prodotto interno lordo e si termina con la conclusione consolatoria che siamo ancora un paese ricco. Ma un paese è ricco per quello che fa non per quello che possiede. Dobbiamo tornare a guardare con simpatia e orgoglio alla nostra industria, alla nostra capacità di fare, di trasformare, di creare, all’industria manifatturiera. Non dobbiamo cercare le soluzioni nel passato, e penso anche alla stagione delle Partecipazioni Statali e dell’interventismo dello Stato, che, pure, hanno dato un impulso importante alla crescita del paese. La politica, tuttavia, può e deve ancora indirizzare lo sviluppo verso quei settori innovativi dove è ancora forte e significativa la possibilità di creare valore e ricchezza, dove è possibile essere competitivi. Questa attenzione alla crescita, agli investimenti giusti e mirati, non ci fa però dimenticare che non esiste sviluppo senza coesione sociale. E’ proprio dal godimento di reali ed effettivi diritti di cittadinanza che può innescarsi quel processo di fiducia in grado di consentire a quelle energie ancora non pienamente dispiegate della società italiana, penso ai giovani, agli immigrati, ai piccoli e medi imprenditori, di poter finalmente realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni, in un quadro certo e trasparente di diritti e doveri.
Indubbiamente la politica estera è un terreno delicatissimo di qualificazione di un personale di governo. Come è possibile valorizzare il patrimonio della larga opposizione sociale alla guerra in Iraq, in termini realistici, propositivi e progettuali (su temi quali l’Onu, l’Europa, l’emergere dei paesi orientali)?
La politica estera deve tenere ferma la bussola della Costituzione repubblicana e insieme la tradizione europeista, multilateralista e di dialogo propria dell’Italia. La pace è l’obiettivo di fondo della politica estera del nostro Paese, è scritto a chiare lettere nell’art. 11 della nostra Costituzione, nel ripudio della guerra in nome del rispetto dovuto alla libertà di ciascun popolo, nel richiamo a giustizia e pace quali valori fondanti nelle relazioni tra nazioni, nell’esplicito richiamo alle organizzazioni internazionali, richiamo che oggi per noi si traduce nel rafforzamento dell’Unione Europea, nostra casa naturale, e nel sostegno alle Nazioni Unite, garanti dell’ordine e della legalità internazionale.
Queste convinzioni, ferme e forti, che sento pienamente condivise dal nostro popolo, sono pregne di conseguenze. Sull’Iraq dissi subito, a conflitto appena iniziato, che si trattava di una guerra che non avrebbe mai dovuto essere iniziata. Contro quella guerra si sono espressi tutti i popoli europei, milioni di persone in tutto il mondo, scendendo per le strade e manifestando pacificamente il proprio dissenso, così come la stessa maggioranza del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea generale dell’Onu. Per questi motivi lo stesso Kofi Annan ha parlato di una guerra «illegale» dal punto di vista delle norme internazionali. Certo oggi la situazione è diversa e dobbiamo tener conto e salutare positivamente il coraggio di milioni di iracheni che si sono recati alle urne per aprire una pagina di speranza e di democrazia per il loro Paese, ancora martoriato dagli strascichi di violenza, morte e disordine che la guerra ha portato con sé. Tuttavia la nostra opinione è rimasta fermamente contraria alla decisione di avviare un’operazione che è stata operazione di guerra e non di pace e non abbiamo cambiato idea sulla correttezza di quella valutazione.
Questo non vuol dire ignorare che possono esistere casi (la protezione della popolazione civile da atti di genocidio, da guerre civili, da aggressioni esterne, da gravissimi attacchi terroristici) in cui l’uso della forza come ultimo mezzo, con il consenso della comunità internazionale e ispirandosi al principio della proporzionalità dell’offesa, possa rivelarsi drammaticamente necessario. In questo senso mi paiono interessanti le conclusioni tratte dal panel di esperti sulla riforma dell’Onu nominato da Annan che meriterebbero un approfondimento. Tuttavia di fronte a tutto questo, all’idea di esportare la democrazia con le armi, alla teorizzazione della guerra preventiva, il mio pensiero va alla grandezza del progetto europeo, un progetto coerentemente e sapientemente di pace, grazie al quale oltre cinquecento milioni di uomini e donne, prima nemici sui campi di battaglia poi crudelmente divisi nel corso della guerra fredda, ora lavorano, si spostano e progettano un futuro insieme, da popoli fratelli, in una cooperazione che auspichiamo sempre più stretta. Questo è lo stile europeo per esportare la democrazia! Proprio per questo suo valore storico è indispensabile che l’Italia riprenda una iniziativa forte sull’Europa, contribuendo a rilanciare, su basi nuove e più forti, un progetto che continua ad attrarre paesi e nazioni vicine, così come rimane il fulcro di una reale stabilizzazione della regione, dai Balcani al Mediterraneo.
Accanto al tema dell’Europa vi è poi il tema delle Nazioni Unite, attese al varo di una riforma che deve dotarle di maggiore efficacia decisionale ma anche di maggiore democraticità e rappresentatività. E’ infatti di grande importanza che il Palazzo di Vetro divenga un forum di coordinamento delle politiche di sviluppo e di contrasto della povertà, così da iniziare a delineare una governance economica mondiale che orienti anche verso obiettivi di promozione umana e sociale le travolgenti dinamiche della globalizzazione.
In conclusione, che parole di fiducia e di speranza direbbe a un giovane rispetto al paese e al mondo?
Non amo fare prediche. Anzi, la fiducia e la speranza sono virtù umane e cristiane che ciascuno deve reperire in se stesso. A noi adulti compete piuttosto di testimoniare la fiducia e la speranza che sono in noi. Per quel che mi riguarda, mi contenterei di tre messaggi che mi piacerebbe trasmettere ai nostri figli: innanzitutto, che la vita è bella, merita di essere vissuta intensamente e che essa è una cosa seria, sarebbe un delitto dissiparla, galleggiare distrattamente alla superficie senza afferrarne il senso e gustarne tutto il sapore per sé e per gli altri; in secondo luogo, che anche il nostro tempo, come ogni tempo, può e deve essere un tempo creativo, l’alba di un mondo nuovo cui merita dedicare se stessi, vincendo l’apatia, le paure, la tentazione del ripiegamento dentro il proprio «particolare». Infine — a questo ho dedicato un pezzo importante della mia vita — la convinzione che il nostro futuro comune passa attraverso l’Europa sognata dai suoi padri fondatori. Essa è il traguardo di uno straordinario processo di civilizzazione ed è la via e lo strumento concreto che conduce ad un mondo più abitabile, meno ingiusto e meno distante da quel bene supremo che tutti li riassume rappresentato dalla pace. La generosa, confortante mobilitazione di tanti giovani contro la guerra che ha riempito le piazze di tutto il mondo non può ignorare che, in concreto, sul piano politico, l’idea della pace passa anche e soprattutto attraverso un’Europa che assurga ad attore globale.