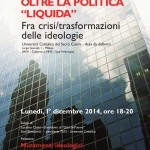Appunti 6_2004
Il lavoro flessibile e la vana attesa di un nuovo Welfare
| Alberto Guariso |
Tutti ricordano (ma molti fanno finta di non ricordare) che quando due anni fa cominciò a concretizzarsi la prospettiva di una grande riforma del mercato del lavoro, i fautori della flessibilizzazione ipotizzavano all’unanimità due tappe, o meglio due percorsi convergenti: da un lato la riduzione delle tutele «nel rapporto di lavoro», attraverso la moltiplicazione delle tipologie contrattuali, dall’altro la costruzione di una grande rete di protezione sociale volta a tutelare i lavoratori «nel mercato», consentendo loro di entrare e uscire senza traumi dai vari rapporti di lavoro. Non era necessario avere la sfera di cristallo per prevedere che, conseguito rapidamente il primo obiettivo, la seconda tappa non sarebbe mai neppure partita. E così è andata.
Stallo parlamentare
Dal punto di vista della mera cronaca parlamentare, le cose stanno così: dal progetto di legge n. 848 che ha condotto poi alla legge Biagi (legge 30/2003) è stato stralciato un disegno di legge delega n. 848bis che, dopo la presentazione di un emendamento del governo, si compone ora di quattro articoli: il primo stabilisce i criteri di delega in materia di incentivi all’occupazione; il secondo i criteri di delega per gli ammortizzatori sociali; il terzo modifica l’indennità di disoccupazione secondo le modalità indicate dal «Patto per l’Italia»; il quarto stabilisce i criteri di delega per la famosa modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Orbene il disegno di legge giace da due anni alla commissione lavoro del Senato la quale, stando ai resoconti parlamentari, se ne è svogliatamente occupata più o meno una decina di volte in tutto il corrente anno: secondo recenti dichiarazioni del ministro Maroni il disegno di legge dovrebbe tagliare il traguardo entro dicembre, ma vi sono almeno tre buone ragioni per dubitare che la promessa possa essere mantenuta.
In primo luogo nessuno, nello schieramento di maggioranza, ha voglia di scoprire le carte in tema di articolo 18 (se lo si cancella definitivamente dalla legge, come ormai quasi tutti vorrebbero, ci si perde la faccia; se si procede, si riapre l’ennesima ragione di scontro); in secondo luogo, in un momento in cui si sta raschiando il fondo del barile per soddisfare la bramosia del premier in tema di (fittizia) riduzione fiscale, nessuno saprebbe dove trovare le risorse per finanziare le pur minime modifiche in tema di indennità di disoccupazione; infine, anche il movimento sindacale sembra aver alzato bandiera bianca e la tematica appare pressoché cancellata dall’agenda della mobilitazione. In realtà, per parte governativa, l’idea che la flessibilità del lavoro debba accompagnarsi ad un Welfare minimo (secondo una prospettiva che appare diversa persino da quella delineata nel «Libro bianco») ha ragioni più profonde e meno collegate alla contingenza politica: da un lato l’idea è coerente con la concezione generale dello Stato minimo così cara a Silvio Berlusconi; dall’altro un Welfare minimo è contrabbandato come strumento «pro-attivo» cioè idoneo a evitare le cosiddette «trappole della povertà» (non cerco lavoro perché tanto ho un sussidio) e stimolare i soggetti ad offrirsi con sufficiente decisione sul mercato; questione, quest’ultima, assolutamente seria (e non a caso spesso dibattuta in sede comunitaria) ma che, utilizzata strumentalmente, può condurre a conclusioni paradossali, giacché qualsiasi euro elargito ad un disoccupato può avere, in astratto, effetti disincentivanti.
I nodi di fondo del sistema sociale italiano
L’assopimento del disegno di legge 848bis potrebbe dunque offrire l’occasione per una riflessione postuma sulla vicenda del «Patto per l’Italia»; per chiedersi cioè se davvero valeva la pena di sacrificare quel che restava dell’unità d’azione del movimento sindacale, sull’altare di una contropartita che, a due anni e più di distanza, è ancora inesistente. Ma assai più utile è invece ragionare in prospettiva: passata la ventata liberista, rimossi i furori ideologici che hanno in parte ispirato la legislazione recente sul lavoro, resterà in ogni caso l’esigenza di risolvere alcuni nodi di fondo sui quali anche la vicenda del disegno di legge sollecita a riflettere.
Sui difetti del nostro sistema di protezione sociale il consenso è pressoché unanime: eccessivo sbilanciamento sulla spesa pensionistica, a danno della protezione nel corso della vita lavorativa (la percentuale di spesa per protezione sociale dedicata alla voce «disoccupazione» è del 2,2% sul totale della spesa sociale, contro una media europea del 6,8%.); in quest’ultimo ambito, sbilanciamento sulle tutele passive (volte cioè alla ridistribuzione del reddito) a danno delle tutele attive volte a favorire la ricollocazione del lavoratore; infine, tra le tutele redistributive, irrazionalità della differenziazione per settori e per tipi di attività.
Sui rimedi, invece, il dissenso è amplissimo. Volendo qui limitare il discorso alle tutele passive o redistributive, il primo problema da porsi è quali diritti di protezione sociale debbano qualificarsi come «diritti di cittadinanza» (intesi come diritti collegati alla mera residenza sul territorio nazionale, senza alcun riferimento alla cittadinanza in senso giuridico), privi di collegamento con la prestazione lavorativa e dunque necessariamente da finanziare con la fiscalità generale e non con il prelievo contributivo sulle retribuzioni; quali diritti di protezione sociale debbano invece essere collegati al lavoro; infine quale sia la nozione di «lavoro» rilevante a tale ultimo fine. Il problema non è nuovo, ma si pone ora in termini diversi.
Come è noto, attualmente le protezioni sociali collegate alla pregressa prestazione di lavoro sono l’indennità di disoccupazione (40% della retribuzione per sei mesi, o per nove per gli ultracinquantenni, solo in caso di licenziamento e solo se vi sia stato lavoro per un anno negli ultimi due); la più modesta indennità di disoccupazione «con requisiti ridotti» (la si percepisce, indipendentemente da ogni requisito, per un numero di giorni pari a quelli lavorati) e l’indennità di mobilità (l’80% della Cassa integrazione, fino a tre anni, a seconda dell’età, ma solo in caso di licenziamento collettivo e con esclusione dei licenziati dalle piccole aziende). Altre forme più rilevanti di aiuto (come l’indennità di mobilità cosiddetta «lunga», che accompagnava il dipendente fino alla pensione, anche per molti anni) sono ormai quasi interamente a carico dell’impresa e dunque difficilmente possono qualificarsi come aiuto pubblico. Come subito si vede, a parte la estrema modestia degli interventi dal punto di vista quantitativo, vi sono numerose figure che restano completamente tagliate fuori da un sistema così congegnato: innanzitutto i «prestatori d’opera» cooordinata e continuativa (i co.co.co o i collaboratori a progetto) i quali, pur trovandosi in una condizione personale del tutto identica a quella dei dipendenti, sono oggi privi di qualsiasi tutela contro la disoccupazione; poi i lavoratori delle piccole aziende (esclusi dalle tutele più consistenti); e ancora quei lavoratori giovani, che non appena fatto ingresso nel mercato, ne restano subito esclusi, senza aver maturato i requisiti per l’indennità di disoccupazione; infine quell’esercito di working poors, di poveri «nonostante il lavoro» (secondo l’ultimo rapporto Ue sulla situazione sociale, sono a rischio povertà il 6% degli occupati) composto cioè da tutti coloro che svolgono una attività lavorativa minima e sottopagata, ma che per questo non vengono considerati «disoccupati» e non percepiscono sussidi. Si tratta quindi proprio di quelle figure che, in un mercato del lavoro flessibile e frammentato, sono in rapidissimo incremento.
Dunque la contraddizione non potrebbe essere più stridente: da un lato un mercato del lavoro che si vanta di avere il suo punto di forza in una miriade di giovani «moto-pizza» e consulenti informatici a progetto; dall’altro un sistema di protezione strutturato sulla grande fabbrica fordista: il fatto che solo l’indennità di mobilità abbia una ragionevole consistenza, riporta alla (vecchia) idea che solo il licenziamento collettivo della grande impresa sia idoneo a creare quell’allarme sociale che giustifica uno sforzo economico più consistente della collettività; laddove è invece evidente che, nel «nuovo» mercato, identico allarme sociale è creato dalla frantumazione della vita lavorativa in mille lavori e lavoretti (alcuni dei quali, come il lavoro intermittente previsto dalla legge Biagi, sono quasi dei «non-lavori»).
Linee di riforma prioritarie
Se dunque guardiamo al mercato del lavoro reale, le direttrici sulle quali deve muoversi la riforma sembrano emergere con chiarezza: in primo luogo alcuni diritti essenziali a base universalistica e solidaristica (un «reddito di cittadinanza», non necessariamente monetario, ma comunque finanziato con la fiscalità generale); in secondo luogo, alcuni diritti sociali aggiuntivi collegati al lavoro, ma secondo un «contratto sociale di attività» che comprenda tutti coloro che hanno prestato lavoro in favore di altri, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto (dipendente, co.co.co., a progetto, ecc.); infine dei requisiti per accedere a tali strumenti di protezione che siano sufficientemente ridotti, in modo che gli stessi siano accessibili anche da soggetti che, appunto per la ridotta durata dei rapporti di lavoro, dispongono di un patrimonio contributivo minimo.
Il disegno di legge 848bis si muove invece in senso del tutto opposto. Sul piano immediato, sono previsti incrementi degli strumenti già in essere, ma in misura assai modesta (e ciononostante, come si diceva, è probabile che siano anch’essi destinati a sfumare): l’indennità di disoccupazione passerebbe al 60% decrescente e per un anno, con un tetto di due anni nel quinquennio e senza copertura contributiva oltre i sei mesi. Sul piano del sistema, è previsto un rafforzamento del principio «assicurativo»: in pratica ciascun settore produttivo dovrebbe pagarsi la disoccupazione che crea, garantendo un sostanziale pareggio di bilancio al proprio interno, salvo un contributo di solidarietà a vantaggio dei settori dove lo squilibrio tra entrate e prestazioni erogate è maggiore (cioè oggi, essenzialmente il settore agricolo); inoltre ciascun settore potrebbe integrare (o addirittura sostituire) il sistema pubblico con un sistema privato su base contrattuale.
La prospettiva potrebbe essere ragionevole, ma a due condizioni. Di per sé, un sistema a base assicurativa impone che l’accesso ai diritti sociali sia connesso al rapporto di lavoro standard (quello a tempo indeterminato e pieno) che è l’unico in grado di pagarsi la propria tutela: nel momento in cui si vuole (o si deve, per necessità) ridurre la rilevanza di tale tipologia contrattuale, il sistema a base assicurativa è inevitabilmente quello meno adatto a fornire risposte; esso ha dunque senso solo a condizione che si innesti su un altro a base universalistica che, come si è visto, ad oggi non esiste e neppure viene previsto dalle modifiche in corso.
La seconda condizione è che, per la quota di sua competenza, il sistema assicurativo venga integralmente applicato. Se il principio è, in parole povere, che ciascuno paghi il «rischio disoccupazione» che produce, allora è del tutto logico prevedere una contribuzione aggiuntiva per il datore di lavoro che assume a termine o con una delle varie forme di lavoro flessibili (come peraltro era previsto da un progetto di legge dell’Ulivo del 2002); il che da un lato ripristinerebbe un minimo di favore per il rapporto a tempo indeterminato; dall’altro introdurrebbe il principio – per nulla rivoluzionario ed anzi strettamente «mercantilistico» – secondo il quale l’imprenditore che beneficia della flessibilità (non solo utilizzando i contratti atipici, ma anche licenziando per ragioni d’impresa) deve più degli altri contribuire a pagarne i costi sociali.
Il lavoro non manca: manca la stabilità e quindi la tutela
Quanto sopra aiuterebbe anche sul piano del reperimento delle risorse, ma certo non risolverebbe il problema: che tuttavia potrebbe rivelarsi meno drammatico di quanto si possa immaginare. Le modifiche in corso nel mercato del lavoro sono infatti radicali. Dopo gli anni ottanta della «crescita senza occupazione» (elevati tassi di crescita e bassi tassi di occupazione, causati da un aumento di produttività che sembrava irreversibile) il millennio si è chiuso con una inversione di tendenza che pochi avevano previsto: aumento continuo dell’occupazione pur in presenza di bassi tassi di crescita, ovviamente grazie ad un contributo determinante di settori a bassa produttività, primo fra tutti quello dei servizi alla persona.
Non sembra trattarsi di un fuoco di paglia, né di un mero effetto della famosa flessibilizzazione: l’aumento dell’occupazione riguarda infatti paesi che hanno ridotto sensibilmente i sussidi alla disoccupazione come la Gran Bretagna e paesi che hanno mantenuto un elevato livello di Welfare come la Svezia; paesi che hanno proceduto ad una forte deregolamentazione del rapporto di lavoro come la Spagna, paesi che hanno puntato tutto sulla regolamentazione concertata tra parti sociali come l’Olanda e paesi che hanno deregolamentato in misura modesta come l’Italia (si intende, l’Italia ante legge Biagi, ove la crescita occupazionale era già in atto da tempo). A dispetto delle previsioni di due decenni fa, sembra dunque potersi prevedere un futuro dove il tasso di partecipazione al lavoro (se pure ad un lavoro più instabile) possa aumentare e con essohttp://cittadelluomo.i-tec.it/index.php?option=com_content&task=new§ionid=6&Itemid=30 la possibilità di garantire una «esistenza libera e dignitosa» anche quando il lavoro non c’è. E magari anche quando non c’è per libera scelta del lavoratore, per realizzare cioè quei «diritti di prelievo sociale» (diritto alla formazione permanente, alla cura dei figli e dei genitori, ecc.) che un recente rapporto della Direzione generale lavoro della Commissione europea, ha identificato come la nuova frontiera dello stato sociale.
D’altra parte non è una novità che tra regole di stabilità del rapporto (la libertà di licenziare) e sistema di protezione sociale debba esistere uno stretto legame inversamente proporzionale: tanto si riducono le prime, tanto deve estendersi il secondo. La salvaguardia di questo legame non risolve ogni problema, ma certo garantisce che la flessibilità non degeneri in una esasperata precarizzazione delle esistenze. Resta il fatto che in Italia le regole di stabilità vanno svanendo, senza necessità di mettere mano all’art. 18, ma semplicemente grazie all’introduzione di molteplici forme di ingresso «atipico» nel lavoro, che contengono già la regola dell’uscita. Il sistema di protezione, come si è visto, è invece ben lungi dall’avere un pur minimo sussulto di vitalità. La logica dei due tempi, si rivela, ancora una volta, una sonora fregatura.