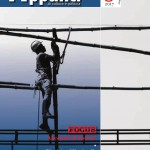Appunti 3_2004
Focus: La novità storica della diplomazia popolare
| Albino Bizzotto |
Diplomazia popolare. Sembra una contraddizione in termini. Al «popolare» tutto si concede tranne che il «diplomatico». Anzi in termini politici «popolare» spesso viene usato in antitesi a «diplomatico». Per noi popolare è tutto ciò che esprime partecipazione politica allargata, anche istituzionalmente non strutturata; associamo questo predicato più facilmente a sostantivi come movimento, organizzazione, volontà, ma mai diplomazia.
In realtà nessuno conosce un «diplomatico popolare» di professione con funzioni e attività permanenti, né una scuola di formazione per tale figura nella società. Eppure in questi anni l’espressione «diplomazia popolare» ha preso piede; ma per significare che cosa? Da dove nasce? Proprio perché non si tratta di realtà strutturata, ma solo di esperienze, il mio approccio rimane necessariamente parziale con un campo di indagine estremamente ristretto e cioè le esperienze dell’associazione Beati i costruttori di Pace, cui appartengo.
Ciò significa che non solo ci sono tantissime altre modalità in cui per altri può esprimersi la diplomazia popolare, ma anche che il mio concetto e il mio tentativo di definizione possono essere ampiamente allargati e anche contestati. Le esperienze verranno richiamate non come prodotto da esporre, ma semplicemente per fondare ed esplicitare il ragionamento.
Un tentativo di partecipazione costruttiva
C’è la guerra in Bosnia. Vogliamo superare il senso di rassegnazione e di impotenza che riguarda tutta la società civile. La guerra rimane sostanzialmente un tabù: riguarda solamente alcuni dirigenti politici ed è territorio esclusivo delle persone armate. Per le popolazioni che ne vengono coinvolte saltano tutti i meccanismi della normale vita civile; vengono sospesi o cambiano anche i rapporti con le istituzioni. Per chi non è direttamente coinvolto non rimane che guardare, aspettare che finisca, al massimo esprimere la propria contrarietà politica con manifestazioni, ma sempre fuori dal territorio di guerra.
Volere entrare a Sarajevo sotto assedio, disarmati e in tanti come società civile, significa rompere un tabù e inoltrarsi in un terreno anche politico-istituzionale mai sperimentato prima. Per questo si costruisce un progetto collettivo, che, oltre alla libera decisione di chi vi partecipa e alla organizzazione, prevede necessariamente tutta una serie di contatti e relazioni con tutti i soggetti che sovrintendono politicamente e militarmente alle operazioni di guerra.
Vista dalla televisione, o dalla stampa, la guerra è crudelmente semplice e schematica; visitata da dentro si rivela molto più complessa, anche se rigida. La zona di guerra è zona interdetta per tutte le attività della politica ordinaria e della diplomazia. Anche per l’Onu la sicurezza del proprio personale è la condizione prima per rimanere su un territorio o andarsene. I volontari della società civile, pur con tutte le misure possibili di prudenza, entrano e si muovono in luoghi «proibiti». Per questo sono necessari rapporti con le parti in conflitto e un filo diretto con l’unità di crisi del ministero degli Esteri del proprio paese.
Un rapporto speciale con tutti i vertici delle istituzioni implicate diventa necessario quando si vuole realizzare un progetto volto a un risultato politico, volto cioè a fermare la guerra. Non ci si impalca ad ambasciatori, ma si cerca di dare il massimo di valenza politica alle iniziative. Come la guerra presenta una sua complessità, anche la ricerca della pace deve necessariamente essere multilaterale.
Molti sono portati a leggere le varie esperienze di interposizione nonviolenta in zona di guerra come testimonianza, dove il rischio esprime la straordinarietà dell’azione dei volontari. Se si legge la guerra dalla parte di chi riceve le pallottole e non dalla parte di chi spara, non c’è niente di eccezionale nell’azione dei volontari. La vita del volontario vale quanto quella di tutte le persone che si trovano dentro a un inferno non voluto; per questo chi opera per la pace avverte anche in questa situazione la sofferenza per la guerra, ma anche la distanza che esiste tra quanto succede e il ripristino della normalità e della legalità… Di fatto c’è la coscienza che è sempre troppo poco ciò che si riesce a fare di fronte alle urgenze di chi è colpito. Ma proprio questa coscienza diventa una forza per stabilire rapporti con le istituzioni con modalità imprevedibili in altre situazioni.
L’esperienza dei Beati costruttori di pace
Provo ad elencare le forme di diplomazia che hanno visto coinvolta l’associazione BCP.
1) Costruzione di progetti di interposizione. E’ necessario per lo meno mettere al corrente i vertici istituzionali interessati; meglio se si riesce a ottenere un consenso o un coinvolgimento. Generalmente le istituzioni tendono a scoraggiare iniziative di società civile che interferiscano con la zona e l’attività militare. Nel ’92, nella prima marcia a Sarajevo, ad accoglierci e a convocarci a Spalato, per fermarci, c’era il console italiano. A volte le istituzioni si prestano a fare buon viso a cattiva sorte ma sostanzialmente cercano di boicottare questo tipo di iniziative. Ho osservato che sempre, prima di ogni iniziativa, uscivano le veline dei servizi segreti che preannunciavano una strage. Semplicità, determinazione, organizzazione e prudenza da parte dei volontari possono dare conto della serietà dei progetti e costringere i diplomatici di professione a rapportarsi. Per esperienza personale devo riconoscere che non è bene fidarsi delle grandi promesse che vengono fatte a parole dai funzionari del ministero degli Esteri; al momento in cui sono necessari, i supporti promessi vengono a mancare. Rimane comunque la necessità di mantenere aperto il rapporto come canale politico. Prima di realizzare i progetti si cerca di incontrare le persone più rappresentative delle parti in conflitto, possibilmente i vertici politici e militari, anche solo per informare. L’informazione trasparente e puntuale è uno dei punti essenziali per tutte le attività in zona di guerra. Un rapporto particolare va stabilito con i rappresentanti della Comunità internazionale, in particolare con i vari funzionari dell’ONU.
2) Attività specifica per la cessazione della guerra. Sarebbe la parte più bella da raccontare quella che ci ha visto a Sarajevo, a Belgrado, a Pale, a Zagabria, a Ginevra, a Città del Messico e a Goma, come al ministero degli Esteri italiano e in Vaticano ad avere incontri e a compiere gesti che cercavano il dialogo, portando però sempre con chiarezza il punto di vista e l’ansia di pace delle popolazioni vittime della guerra. Vorrei accennare a due episodi tra i tanti. Nel ’93 a Belgrado in delegazione abbiamo incontrato il Patriarca ortodosso Pavle, portando un saluto e un messaggio da parte della segreteria di Stato, in un momento difficile dei rapporti tra Chiesa ortodossa e Chiesa cattolica. Nel ’95, subito dopo l’eccidio di Srbrenica una nostra delegazione è riuscita ad arrivare a Pale per contestare le azioni dei responsabili politici e militari serbi a nome delle vittime e a nome dello stesso popolo serbo. Nell’occasione abbiamo ricordato che la misura per la Comunità internazionale era colma. Siamo stati derisi, ma tutto si è verificato come annunciato.
3) Attività per coinvolgere le istituzioni a farsi carico di situazioni abbandonate. Sto pensando all’Africa, a tutti gli sforzi a livello Ue e di istituzioni italiane perché il progetto Anch’io a Bukavu potesse già nella sua realizzazione trovare i canali migliori per smuovere l’interesse politico dell’Europa, oltre ad esprimere solidarietà e dare fiducia a tutti i rappresentanti della società civile italiana.
4) Attività per rinforzare le istituzioni che sono preposte alla risoluzione corretta dei conflitti. Ricordo il progetto Si vive una sola pace che ci ha portato con il treno fino a Ginevra nel ’95 per incontrare i responsabili Onu, ma anche per dire ai capi di Stato della Comunità internazionale che l’Onu e non la Nato era l’organizzazione che doveva intervenire con un mandato più ampio e un appoggio più concorde per porre fine alla guerra in Bosnia.
5) Messa in campo di nuovi soggetti di diplomazia. Gli enti locali, le ambasciate di democrazia locale (Adl), le Ong e altri stanno diventando con sempre maggiore frequenza veri e proprio soggetti di politica estera, dove la diplomazia popolare si intreccia con quella ufficiale.
Cercare spiragli in ogni direzione
Un’ultima osservazione mi sta a cuore. Molto spesso siamo chiamati a esprimere la nostra solidarietà a chi viene oppresso, a chi si sente vittima nelle varie situazioni. Quasi sempre questo significa schierarsi e fare una scelta di campo. L’abbiamo sperimentato a Sarajevo, in Chiapas, in Palestina e in Africa. Ma ricercare la pace non sempre può esaurirsi nella solidarietà. Qualche volta abbiamo sentito un rifiuto del nostro modo di porci quando abbiamo tentato di fare monitoraggio, di incontrare e valorizzare le persone amanti della pace anche in campo «nemico». La diplomazia popolare entra anche in questa modalità che non esclude la solidarietà, ma va oltre nel percorrere quelle strade impossibili a chi chiede soltanto solidarietà. Se in questo momento essere a fianco dei palestinesi non significasse anche riconoscere e valorizzare le azioni di chi si impegna per la pace nella società israeliana si rischierebbe semplicemente di esacerbare ulteriormente e radicalizzare il conflitto. Per chi si trova nella necessità di avere risposte veloci e urgenti questa è la via più difficile, a volte incomprensibile, ma sarebbe un tradire l’impegno per la pace se, come figure internazionali, noi non ci impegnassimo a percorrerla.
Non ho mai adoperato la parola nonviolenza. E’ evidente che è la chiave di volta di tutti i progetti di interposizione, di tutte le attività di ricerca della pace, superando l’ideologia del nemico e naturalmente anche della diplomazia popolare.