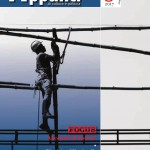Appunti 3_2004
La legge "Biagi", i soggetti svantaggiati e la comunità ecclesiale
| Rosario Iaccarino |
Lo sviluppo della fase attuativa della riforma del mercato del lavoro del governo Berlusconi conosciuta anche come legge «Biagi», fa emergere con sempre maggiore chiarezza i contorni di un disegno politico finalizzato a spostare a favore dell’impresa l’equilibrio di potere nei rapporti di lavoro. Il simbolo della nuova legge, in questo senso, è la riforma del part-time, che malgrado si ponga l’obiettivo di favorire una tipologia contrattuale usata relativamente poco in Italia rispetto alla media degli altri paesi europei (l’8,5% contro il 18%) non appare incentivante per chi si offre sul mercato del lavoro quanto invece per le imprese alle quali – al fine di disporre di una maggior flessibilità organizzativa – la legge concede il potere di modificare la collocazione temporale e di variare in aumento l’orario di lavoro, con un preavviso al lavoratore di sole quarantotto ore. La conseguenza per coloro che intendono scegliere questa forma di lavoro – che in genere hanno delle necessità di carattere personale o familiare – sarà una maggiore difficoltà a conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita, per cui, come già accade per le donne con grossi carichi familiari, alcuni saranno costretti ad abbandonare obtorto collo l’attività ed altri non entreranno affatto nel mercato del lavoro. Inoltre, nel caso il lavoratore svolgesse due part-time presso aziende diverse, per rispettare il nuovo regime flessibile di orario si vedrebbe costretto a rinunciare ad uno dei due contratti e quindi ad una quota consolidata di reddito; con buona pace dello spot ministeriale che beffardamente recita: «grazie al nuovo part time ora è più facile mettere d'accordo le esigenze delle imprese e dei lavoratori».
Questa, tuttavia, è soltanto una delle linee portanti della legge 30/03 e del successivo decreto attuativo (276/03), prese già in esame su queste colonne1. Tali norme segnano una discontinuità nel diritto del lavoro del nostro paese, che con le nuove normative deve registrare: il consolidarsi dell’era del lavoro in affitto (oggi possibile anche a tempo indeterminato), l’ulteriore frammentazione dell’unità produttiva (per la maggiore facilità di esternalizzare e scorporare parti dell’attività di un’impresa), la marginalizzazione del sindacato nel governo delle flessibilità e l’apertura alla contrattazione individuale, la concorrenza sul piano dei costi (al ribasso) tra molteplici tipologie contrattuali, la riduzione della platea di soggetti coperti dallo Statuto dei lavoratori, la sterilizzazione del controllo e della mediazione giudiziaria nei conflitti di lavoro. Il nuovo corso delle politiche del lavoro allontana l’Italia dall’«Europa sociale» nata a Lisbona nel 2000 con gli obiettivi della «piena occupazione» e della cosiddetta «flexicurity» (la flessibilità del lavoro combinata con la protezione sociale), e la spinge verso la via bassa della competizione internazionale, in quanto una politica economica incentrata sull’offerta di incentivi fiscali (dati a pioggia) e di riduzione del costo del lavoro per le imprese, viene incontro alla parte meno competitiva e più protetta del nostro sistema produttivo. Peraltro, si tratta di un settore già in serio declino e a rischio di un’ulteriore flessione delle esportazioni, in una congiuntura economica mondiale caratterizzata dalla crescita di paesi emergenti come la Cina e dalla svalutazione del dollaro che sta ridando fiato alla competitività degli Stati Uniti. E non inganni l’aumento (modesto) dell’occupazione, in quanto come osserva Pierre Carniti, ciò è dovuto «alla crescita abnorme di contratti di lavoro cosiddetti atipici. Crescita a cui non ha affatto corrisposto un aumento del lavoro»2, per cui: «Il risultato di questa nuova composizione del lavoro è stato una flessione della produttività media degli occupati, alla quale si è naturalmente accompagnata una flessione del loro reddito reale medio. Siamo quindi più nel campo della redistribuzione del reddito che in quello della sua produzione»3. Come dire che più persone dividono tra loro una torta che cresce poco.
Le misure per l’inserimento al lavoro dei soggetti svantaggiati
A connotare ancor più negativamente una riforma che con il suo impianto «modernizzatore» tende ad indebolire il lavoro dipendente e la sua rappresentanza sindacale, vi sono poi alcune criticità che riguardano i soggetti svantaggiati, il cui inserimento al lavoro è favorito da una serie di incentivi alle imprese tra i quali la possibilità di derogare dai minimi contrattuali. In virtù della discriminazione che si configura tra questi e il resto dei lavoratori dipendenti, c’è da chiedersi se sia accettabile una normativa che promuova l’accesso al lavoro a qualsiasi condizione, e quindi se il diritto al lavoro dei soggetti svantaggiati così inteso non entri in conflitto con altri diritti costituzionali, quali quello dell’uguaglianza dei cittadini, e, nei casi di reinserimento al lavoro delle donne attraverso politiche attive di questo tipo, quello della parità tra i generi. E se, infine prestazioni professionali meno costose come quelle in oggetto – vista anche l’ampia definizione di soggetti svantaggiati, ossia «qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà di entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro» – possano dare luogo a situazioni di dumping sociale, alterando anche la concorrenza tra le imprese.
Nel caso della somministrazione di lavoro (lavoro in affitto), ad esempio, la nuova normativa (art. 13), sia pure in via sperimentale, prevede che a fronte dell’offerta a soggetti svantaggiati di un progetto di inserimento mirato con l’assistenza di un tutor e di un’assunzione non inferiore a sei mesi, le agenzie autorizzate alla fornitura di lavoro possano operare in deroga al regime di parità di trattamento economico e normativo, trasferendo di fatto al lavoratore stesso l’onere del suo inserimento. Inoltre, se il medesimo lavoratore dovesse percepire una qualche forma di indennità (disoccupazione, mobilità ecc.), le agenzie fornitrici di lavoro, offrendogli un’assunzione non inferiore ai nove mesi, possono detrarre dalla sua retribuzione la misura del sussidio da esso percepito; indennità che peraltro decade in caso di rifiuto del lavoratore ad accettare il percorso di inserimento, o un corso di formazione professionale, o l’offerta di un lavoro a determinate condizioni. In questo caso attraverso strumenti impropri quali i sussidi di carattere assistenziale che fungono da incentivo economico alle imprese, è la collettività a farsi carico dell’inserimento al lavoro dei soggetti meno competitivi sul mercato del lavoro: «in sostanza abbiamo l’utilizzazione di fondi destinati ai lavoratori svantaggiati per incentivare le agenzie di somministrazione ad occuparsi del loro inserimento o reinserimento. Pertanto la prestazione assistenziale rimane a carico dell’ente previdenziale pubblico, ma muta natura, diventando un incentivo all’assunzione temporanea del lavoratore svantaggiato»4.
Il nodo critico del lavoro per i disabili
L’articolo successivo della legge «Biagi» (n.14) – anch’esso dedicato ai lavoratori svantaggiati – presenta alcune novità relative all’inserimento al lavoro dei disabili, che vanno a sovrapporsi pur senza abrogarla alla legge precedente – la 68 del 1999 – la quale prevede che le imprese con più di 15 dipendenti debbano riservare, a seconda delle dimensioni, una quota di assunzioni obbligatorie per i disabili. E’ peraltro possibile per l’azienda, al fine di rendere più agevole per il disabile l’ingresso nel mondo del lavoro, collocare il lavoratore temporaneamente presso una cooperativa sociale, alla quale la stessa azienda provvederà a fornire in cambio delle commesse di lavoro. Questo meccanismo finalizzato all’inserimento mirato del disabile viene confermato dalla riforma Biagi, la quale tuttavia introduce una variante sostanziale che consente all’impresa – se essa si vincola ad una convenzione quadro su base territoriale – di non assumere più direttamente il disabile (come prescrive la 68/99), ma di inviarlo alle dipendenze della cooperativa sociale in cambio di un ammontare annuo di commesse tale da consentire l’assolvimento dell’obbligo. In questo modo l’impresa potrà coprire la quota di riserva imposta dalla legge senza stabilire alcun rapporto con il disabile, il quale sarà inserito secondo le esigenze di lavoro (più o meno temporanee) e le condizioni contrattuali (meno favorevoli rispetto ad altri contratti) delle cooperative, senza tuttavia alcuna garanzia di continuità del rapporto di lavoro e quindi di un consolidamento del suo percorso di integrazione sociale.
La modifica non è di poco conto e risponde ai desiderata delle imprese, come peraltro confermano le dichiarazioni improntate al realismo del presidente della Commissione Handicap di Confindustria: «non riesco proprio a capire l’ostinata preclusione di taluni al fatto che la persona disabile possa svolgere la propria attività in un luogo diverso da quello della fabbrica tradizionale. Non riesco proprio a trovare nessuna ragione a giustificazione del fatto che il lavoro nei luoghi ‘usuali’ sia più socializzante, più gratificante, più educativo, più ‘lavoro’ che invece nelle sedi e nei luoghi delle cooperative sociali. […] c’è da considerare poi che al di là della disponibilità all’assunzione delle persone disabili da parte dell’imprenditore e della volontà dell’azienda di adeguare la postazione di lavoro, spesso, troppo spesso, le persone disabili si trovano a dover rinunciare alle proposte di lavoro per l’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro. Va altresì considerata la tendenza di oggi a segmentare le fasi produttive esternalizzando il più possibile la produzione in outsourcing»5. Tesi che non trovano ovviamente accoglienza nel mondo della cooperazione sociale (malgrado i potenziali benefici in termini di commesse previsti dalla legge) come emerge, ad esempio, dal documento elaborato da alcuni enti ed associazioni non profit in Lombardia, con capofila la Caritas, che sul punto specifico testualmente afferma: «Il recente art. 14 del Decreto legislativo 276/2003 (attuativo della legge Biagi) accoglie alcune pressioni tendenti a rendere più flessibile il rapporto e le convenzioni (di cui all’art.12 legge 68/99) tra imprese profit e cooperative sociali con lo scambio tra commesse di lavoro e cessione degli obblighi di assunzione di persone disabili. Questa soluzione, se da una parte può apparire facilitante per aumentare il numero di soggetti immessi al lavoro, rischia di relegare alla cooperazione sociale l’inserimento lavorativo di persone disabili, soprattutto quelle con maggiori difficoltà, rinunciando a chiedere alle imprese azioni di responsabilità sociale. Questa interpretazione riproporrebbe risposte ormai abbandonate di inserimenti differenziati e ghettizzanti, non rispettosi della dignità delle persone e del loro diritto ad una integrazione possibile e sostenuta. Una importante e giusta maggiore flessibilità non può portare al ritorno a forme di ghettizzazione e a luoghi di lavoro normali e di serie B. Proprio per il significato sopra descritto il lavoro deve mantenere quelle caratteristiche di integrazione e di ruolo sociale intrinseche che non possono essere esclusivamente garantite dalla sola cooperazione sociale»6.
I soggetti deboli come riserva indiana
Un esito di tal genere configurerebbe i disabili come una sorta di «riserva indiana» da proteggere e assistere invece che da promuovere socialmente, e sancirebbe per legge l’esistenza di un mercato del lavoro duale. In questo senso ci sentiamo di condividere quanto scrive in proposito il giuslavorista S. Slataper e cioè che la riforma del mercato del lavoro «pur creando un meccanismo astrattamente idoneo ad aumentare la quantità di persone svantaggiate lavoranti, fallisce completamente lo scopo di diminuire l’esclusione sociale dei lavoratori svantaggiati. Invero, i faticosi tentativi di rendere accettabili gli svantaggiati ed i disabili nei contesti sociali ordinari – primo fra tutti nell’ambito del lavoro – vengono del tutto frustrati creando una netta cesura tra l’azienda committente, dove lavoreranno solo persone sane e bennate, e il purgatorio delle cooperative sociali dove, in cambio di uno stipendio gli sgraditi svantaggiati e disabili staranno lontano dai ‘normali’»7.
Un altro aspetto non convincente relativo all’inserimento dei lavoratori svantaggiati è rintracciabile agli art. 33 e 34 del decreto 276/03, che disciplina il cosiddetto lavoro intermittente, una nuova tipologia contrattuale per la quale, in cambio di un’indennità di disponibilità, una persona rimane in attesa di un’eventuale chiamata dell’azienda per lavorare in un determinato periodo (ore, giornate, settimane, mesi). Si tratta di una forma di lavoro sui generis che se da un lato è fortemente vincolante per il lavoratore e penalizzante sotto il profilo della continuità del reddito, oltre che incerto sull’esigibilità di una serie di diritti (ferie, malattia, maternità, infortunio, ecc.), dall’altro non favorisce certo un percorso professionalizzante né un inserimento stabile nel tempo. A maggior ragione ciò che sorprende è che la legge, mentre per la definizione delle causali per attivare questo tipo di contratto rinvia alla contrattazione collettiva (quindi al controllo sindacale), prevede invece una deroga per i soggetti svantaggiati – nella fattispecie i lavoratori con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo o in mobilità, e i disoccupati con meno di 25 anni – rendendolo solo per costoro già praticabile e senza alcun tipo di condizione.
Una menzione infine merita il «contratto di inserimento», istituto che ha sostituito il vecchio contratto di formazione e lavoro, mutando tuttavia natura e venendo oggi finalizzato, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, all’inserimento o reinserimento al lavoro di soggetti deboli sul mercato quali i giovani, i disoccupati di lunga durata, gli over 50 espulsi dalla produzione, le donne residenti in aree con forte disoccupazione, fino alle persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Tra molti aspetti condivisibili della nuova normativa, lasciano perplessi la eccessiva potenziale durata – fino a 36 mesi – del contratto per i portatori di handicap (per gli altri prevista dai 9 ai 18 mesi), e la facoltà alle imprese di poter inquadrare, nell’ambito del sostegno all’occupazione delle fasce deboli, i destinatari del contratto di inserimento in una categoria professionale inferiore di due livelli. Secondo molti giuristi, questa previsione della legge sarebbe in contrasto con l’art.36 della Costituzione per il quale «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa»8. Peraltro viene puntualmente sottolineato che avendo il contratto di inserimento non più finalità formative come il c.f.l., ma di incentivo all’occupazione «non si giustifica più la disparità di trattamento sotto il profilo salariale essendo venuto meno il valore aggiunto della formazione, da sempre invocato per legittimarla. Il sottoinquadramento, per di più raddoppiato rispetto a quello consentito in relazione al c.f.l., rappresenta una evidente anomalia anche sotto il profilo sistematico, in quanto nell’area degli incentivi all’occupazione di tipo economico, l’alleggerimento del costo del lavoro in favore del datore di lavoro non comporta mai ‘l’alleggerimento’ anche della retribuzione in danno del lavoratore »9.
La legge Biagi e la comunità ecclesiale
La riforma del mercato del lavoro ha scosso dal torpore anche la comunità ecclesiale, almeno a livello di vertice, inducendola ad uscire da un silenzio assordante sull’attuale transizione politica e giocoforza a discutere e a dividersi su una questione sociale che tocca significativamente la vita delle persone e delle famiglie e non è indifferente ai destini della cittadinanza e delle relazioni di comunità. E se ha messo in evidenza risorse apprezzabili di autonomia e di laicità, ha anche confermato come non sia ancora maturata quella svolta nel rapporto tra fede e politica che era lecito attendersi di fronte ad una fase nuova – quella del bipolarismo – del nostro sistema politico. Magari recuperando l’eredità del Concilio Vaticano II che pur collocando la comunità ecclesiale su una dimensione diversa, «altra», dalla quella politica, la vede profeticamente coinvolta nella faticosa quotidianità della città dell’uomo, e per questo abilitata a formare coscienze in grado di criticare e di ispirare laicamente anche la politica.
«La legge Biagi è per i più deboli». Con questo titolo il quotidiano «Avvenire»10 nell’ottobre scorso sintetizzava la risposta del ministro Maroni, contenuta in un testo inviato ai vescovi e redatto dal sottosegretario Maurizio Sacconi e dal giuslavorista Michele Tiraboschi (gli autori della riforma del mercato del lavoro), alle considerazioni preoccupate che la Pastorale del lavoro del Piemonte aveva espresso in una lettera aperta11 indirizzata allo stesso ministro alla vigilia della fase attuativa della riforma del mercato del lavoro (la promulgazione del D.lgs. 276/03). Un testo nel quale i rappresentanti della Chiesa piemontese – dopo aver ricordato la motivazione tutta pastorale del loro intervento, svolto «nello spirito di Marco Biagi» – evidenziavano, anche con l’obiettivo di «favorire un dibattito pubblico, talora difficile ma doveroso», la forte problematicità di questioni quali la precarietà del lavoro dei giovani, le difficoltà di reinserimento dei lavoratori espulsi dalle aziende in crisi, l’utilizzo massiccio dei contratti atipici, la flessibilità non regolata, il lavoro nero, nonché l’urgenza di maggiori investimenti in formazione professionale, ricerca e sviluppo.
Temi significativi, sui quali Sacconi e Tiraboschi, pur dichiarandosi impegnati a verificare gli effetti della riforma e disponibili a correggerla, non si soffermarono nella lettera di risposta, preoccupandosi invece di spostare la discussione dal merito della riforma all’agibilità politica necessaria per applicarla, sottolineando che: «sarà ora il prevalere di un dialogo sociale costruttivo il completamento essenziale per dare definitivamente corpo al sogno di un giurista cattolico, quello di un mercato del lavoro inclusivo e competitivo perché in grado di offrire a ciascuno e a tanti la continua capacità di mantenere o acquisire un lavoro di qualità. Al contrario il processo alle intenzioni avrebbe come unico risultato quello di sottrarre alle molte persone oggi ai margini del mercato del lavoro la possibilità di sperimentare l’efficacia dei nuovi strumenti»12.
Una risposta che appare dunque volta a chiudere definitivamente un dibattito difficile, e in qualche circostanza dai toni vivaci, iniziato in occasione dell’uscita del Libro bianco sul mercato del lavoro – testo che avrebbe poi ispirato la riforma del 2003 – e della proposta di revisione dell’art. 18. Proprio la Consulta dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei aveva promosso un dibattito con lo stesso Marco Biagi, un paio di mesi prima della barbara uccisione per mano delle Br del giuslavorista bolognese13. Quando la notizia dell’incontro fu resa pubblica14 don Raffaello Ciccone, responsabile della pastorale del lavoro ambrosiana, ne sottolineò il taglio essenzialmente pastorale che – scriveva – «obbliga ad essere attenti ai limiti, a guardare in faccia un volto, ad ascoltare e cercare per quanto è possibile insieme una soluzione. Se con le scelte politiche o economiche non si può essere mai fiancheggiatori (e quando lo fa la Chiesa lo paga duramente), ci sentiamo seri e convinti collaboratori per tutti quegli aspetti che sostengono i valori della persona»15. Quindi don Ciccone evocava il clima del seminario con Biagi che «si fece serrato poiché giocavamo in casa, con un credente che sa capire e con uno studioso che cerca soluzioni a livello legislativo. Non parlavamo per noi o per i nostri interessi ma, come pastori, sentivamo che la flessibilità nascondeva il volto della precarietà e della selettività con i più deboli, i più fragili, con le future generazioni, con l’handicap…»16. Due autorevoli commentatori come Alfredo Recanatesi ed Eugenio Scalfari, scrivendo dell’incontro tra Biagi e la Pastorale del lavoro ebbero a mettere in evidenza l’approccio di merito, tutto laico, della discussione, e la differente visione strategica sui temi economici e del lavoro. Al punto che, sottolineava Recanatesi, «sembra che Biagi e i vescovi parlino due lingue diverse. Il professore spiega di aver inteso il proprio ruolo come quello di perequare le tutele attraverso riforme compatibili con le esigenze della struttura produttiva quale oggi è e che viene considerata data. […] I vescovi per contro si pongono il problema delle condizioni di vita che si stabiliscono per i lavoratori in un sistema che faccia assegnamento sulla flessibilità e sulla riduzione delle tutele; dunque un sistema dominato dall’incertezza nel quale ‘occorre sempre ripartire e ricominciare da capo’»17. Gli faceva eco Eugenio Scalfari che nel giudicare «democratico e per certi aspetti perfino liberale» il pensiero sociale espresso dai responsabili della pastorale del lavoro in quell’occasione, mentre segnalava come la posizione di Biagi nel ricercare le «soluzioni più adatte nei limiti della situazione data» entrasse in conflitto con quella dei suoi interlocutori che «mettono in discussione proprio l’immodificabilità di quella situazione», dando luogo, a suo avviso, ad una sorta di inversione di ruoli: «il laico (sia pure di fede cattolica) che assolutizza orgogliosamente la propria verità mondana e i rappresentanti della Chiesa che relativizzano gli strumenti mantenendo fermo il fine»18.
Apprezzamenti acritici
La ricchezza di un dibattito laico, vero e approfondito, e i giudizi critici che ne erano scaturiti sulla riforma del lavoro, non piacquero invece al ciellino Antonio Socci, che dalle pagine del «Foglio»19 di Giuliano Ferrara, negli stessi giorni, definì «burocrazia ecclesiastica del livello meno qualificato» i rappresentanti della pastorale del lavoro italiana e l’incontro con Biagi un «confronto polemico, dal sapore inquisitoriale». Inoltre Socci, che rilevava come negli interventi dei rappresentanti ecclesiali «se non erro, mai una volta viene evocato Gesù Cristo», si affrettava a ricordare che «queste burocrazie ecclesiastiche non esprimono, come crede Scalfari, il pensiero della Chiesa che invece è espresso dagli interventi del Magistero, il Papa, i cardinali Joseph Ratzinger e Camillo Ruini, che vanno in tutt’altra direzione»20. Socci concludeva il suo articolo evocando, attraverso le parole del patriarca di Venezia Scola, ciellino come lui, la virtù del compromesso, che a suo avviso dà legittimazione pastorale a cattolici riformatori come Biagi: «la qualità della politica risiede in ultima analisi nella politica del cum-promittere, cioè dell’instancabile ricerca della miglior soluzione pratica possibile di ogni problema specifico sotto lo sguardo avvertito dell’arbitro, cioè del popolo. Rivelando il valore inalienabile dell’essere personale. Cristo Gesù ci indica così l’imprescindibile garanzia per edificare la vita buona, nella sua dimensione personale e sociale. Infatti il mistero della redenzione funge, per così dire, da antidoto contro le inevitabili e sempre ricorrenti tentazioni dell’ideologia e dell’utopia»21. Lo sforzo di riflessione della Pastorale del lavoro riunita per l’incontro con Biagi al massimo livello (con la presenza di mons. Giancarlo Bregantini, presidente della Commissione episcopale per il lavoro, la giustizia e la pace), non è stato di aiuto neanche ai vertici della Cei, che forse più preoccupati di lanciare un messaggio politico di carattere generale, hanno espresso sulla riforma del mercato del lavoro – come già accaduto in occasione della discussione sull’art.1822 – una posizione assai più conciliante. In occasione della prolusione al consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana del settembre scorso, ad esempio, il card. Ruini, parlando dell’esigenza da un lato, «di tutelare i redditi effettivi delle persone e delle famiglie specialmente di condizioni più modeste evitando che si allarghi l’area della povertà» e dall’altro «di costruire o rafforzare i presupposti di un sistema sociale ed economico più dinamico e capace di sviluppo», concludeva significativamente affermando che «in proposito sembra sia stato imboccato, con la cosiddetta ‘legge Biagi’, un percorso che dovrebbe consentire di rendere più moderna e meno squilibrata la nostra normativa sul diritto del lavoro, con il contributo delle diverse parti sociali e senza abdicare alla necessaria tutela dei lavoratori: la speranza è che ne derivino conseguenze positive soprattutto sull’importantissima frontiera dell’occupazione»23.
Anche «Avvenire», il quotidiano della Cei, in questi mesi, ha sostenuto acriticamente la riforma del mercato del lavoro, ospitando in genere commenti e articoli a senso unico, e con titoli tipo «Legge Biagi: dalla parte dei non garantiti»24. Un esempio del tipo di comunicazione distorta sul tema ha riguardato proprio il part-time. Il cui scarso utilizzo viene additato ad «ostacoli di tipo culturale, vi è la difficoltà da parte delle aziende a riorganizzare i tempi di lavoro su più ‘fasce’, ma vi è soprattutto la poca conoscenza della normativa attuale, decisamente più vantaggiosa rispetto a un tempo»25. Vantaggiosa per chi il quotidiano cattolico non lo dice, ma aggiunge, lasciando immaginare chissà quali opportunità si aprano per i lavoratori, che il nuovo part-time «può essere applicato anche a contratti a tempo determinato; può consentire il ricorso al lavoro supplementare o allo straordinario; permette di cambiare più facilmente la collocazione temporale o la durata della prestazione lavorativa; può prevedere riduzioni di orario anche minime»26.
Certo modernizzare è faticoso, come dice il titolo di un articolo della rivista dei dehoniani «Il Regno» del settembre 200227, che nel commentare l’incontro tra la Pastorale del lavoro e Marco Biagi, tende a riconoscere le posizioni del giuslavorista bolognese come una sorta di via tecnica, istituzionale alla riforma del mercato del lavoro, e quindi politicamente neutra, e sembra rimproverare agli interlocutori di Biagi di non aver colto «una domanda di intelligenza storica rispetto a cui le comunità cristiane sembrano distratte»28.
La questione, tuttavia, rimane sempre «come modernizzare», arginando con il governo un mercato che, spesso coadiuvato dalla politica e dall’ideologia, si fa più aggressivo e selettivo, lasciando sul terreno molte macerie. Tale domanda chiederebbe di non strozzare il dibattito ma di tenerlo vivo, anche perché il diritto del lavoro «è inseparabile dal suo ambiente, sia nel senso che lo condiziona, sia nel senso che ne è condizionato», e in quanto «si propone finalità pratiche di bilanciamento degli interessi in conflitto che escludono la sua assolutezza ed ogni sua autonoma trascendenza»29, anzi «nasce dalla, e si nutre della, critica di una relazione sociale suscettibile di generare grandi conflitti nel cuore del sistema capitalistico. La critica, però, è così poco radicale da proporsi, piuttosto, di impedire la radicalizzazione dei conflitti. E’ una critica, cioè, la cui pars construens non può non prevalere sulla destruens perché è diretta a ricercare accettabili, ancorché provvisori, equilibri tra le esigenze di efficienza, produttività competitività dell’impresa e quelle di salvaguardia dei valori umani di cui è portatore il fattore lavoro riconosciuti dalle carte costituzionali della seconda metà del 900»30.
1 R. Iaccarino, Molti vizi, poche virtù. La nuova riforma del mercato del lavoro italiano, in «Appunti di cultura e politica», 2003, 3.
2 P. Carniti, Occupazione: un paradosso italiano, 27 marzo 2004, dal sito web www.eguaglianzaeliberta.it.
3 Ibid.
4 L. Zoppoli, Gli obiettivi di inclusione sociale nella riforma del mercato del lavoro, dal sito web www.unicz.it.
5 D. Cervellin, Così cresce il lavoro dei disabili, in «Il Sole 24 Ore», 17 agosto 2003
6 La persona disabile: presa in carico, vita autonoma e sistema dei servizi, aprile 2004, dal sito web, www.caritasambrosiana.it.
7 S. Slataper, Le convenzioni con le cooperative sociali per favorire l’inserimento dei soggetti svantaggiati, in (a cura di M. Miscione e M. Ricci) Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276
8 Costituzione della Repubblica, art. 36.
9 D. Garofalo, Il contratto di inserimento: dall’occupabilità all’adattabilità, dal sito web www.unicz.it.
10 «Avvenire», 13 ottobre 2003.
11 Il lavoro che non rende liberi di mons. Fernando Charrier – don Giovanni Fornero, Lettera aperta della Pastorale sociale e del lavoro del Piemonte al Ministro del lavoro, in «L’Unità», 27 settembre 2003.
12 Ibid.
13 La trascrizione del dibattito è ora disponibile integralmente sul sito www.chiesacattolica.it/cci_new/cei/.
14 Il giorno in cui Biagi litigò con la Chiesa, in «La Stampa», 20 luglio 2002.
15 R. Ciccone, Ricordando il prof. Marco Biagi, «Il nostro tempo», settembre 2002.
16 Ibid.
17 A. Recanatesi, I dubbi della Chiesa sul Libro bianco di Biagi. Se manca un progetto dietro le riforme del lavoro, in «La Stampa» 22 luglio 2002.
18 E. Scalfari, Marco Biagi e le critiche della Chiesa, in «La Repubblica», 25 luglio 2002.
19 A. Socci, Marco Biagi, il pensiero della Chiesa e quello delle burocrazie ecclesiali, in «Il Foglio», 27 luglio 2002.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Vedi «Adista» n. 28, 8 aprile 2002.
23 Conferenza Episcopale Italiana, Consiglio Permanente, Prolusione del Cardinal Presidente, Roma, 22–25 settembre 2003.
24 «Avvenire», 17 marzo 2004.
25 «Avvenire», 9 marzo 2004.
26 Ibid.
27 L. Prezzi, La Chiesa e Biagi. La fatica di modernizzare, «Il Regno – Attualità», 15 settembre 2002.
28 Ibid.
29 U. Romagnoli, Diritti del lavoro nella globalizzazione, novembre 2003, dal sito web www.eguaglianzaeliberta.it.