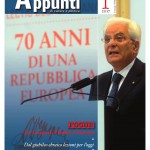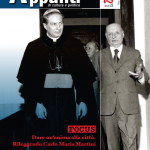Appunti 2_2004
Focus: Madrid e la Costituzione europea
| Mario Sepi |
Il sanguinoso attentato di Madrid e le sue conseguenze avranno importanti risvolti non solo sul futuro del processo di integrazione europea a medio e lungo termine, ma anche nella discussione un po' sfilacciata che si andava svolgendo in Europa sulla nuova Costituzione.
La conclusione della Presidenza italiana era stata un insuccesso evidente, che ha avuto aspetti tragicomici nella conferenza stampa di Berlusconi, quando egli, secondo le sue abitudini nei rapporti con l'opinione pubblica nazionale, ha cercato di affabulare la platea della stampa internazionale con la trovata del semisuccesso, affermando che i punti di contrasto erano molto limitati, anzi solo uno: il meccanismo della maggioranza qualificata nel Consiglio dei Ministri.
Il fatto che contrastava clamorosamente con queste affermazioni, e che è stato immediatamente sottolineato nei giornali di tutto il mondo, era che la Presidenza italiana, forse per non mettere in imbarazzo l'"amico" Aznar, che insieme alla Polonia poneva il veto rispetto al compromesso faticosamente raggiunto dalla Convenzione, sulla maggioranza qualificata (del 50% degli Stati e del 60% della popolazione) non aveva mai convocato la Conferenza intergovernativa in plenaria per verificare almeno i risultati raggiunti.
In effetti questa scelta italiana di rimanere al livello di incontri bilaterali con i singoli governi ha permesso da una parte agli oppositori di non assumersi le loro responsabilità di fronte all'intera Conferenza, ma dall'altro lato ha lasciato in mani esclusivamente italiane la valutazione degli altri punti controversi. Ciò ha aumentato le già pesanti responsabilità dell'insuccesso della Conferenza intergovernativa (Cig) da parte del governo italiano, titolare di una politica europea oscillante e contraddittoria senza una evidente volontà politica di andare fino in fondo nel suo ruolo.
Il metodo dei colloqui informali bilaterali che ha convinto il Presidente del Consiglio di aver raggiunto un accordo su 21 punti controversi, avrebbe dovuto essere verificato con il plenum della Conferenza, per vedere se le concessioni fatte bilateralmente dalla Presidenza ai singoli governi potessero essere accettate da tutti. Per questo la favola del semisuccesso non poteva fare molta strada e si è conclusa con pesanti giudizi sia da parte degli euroscettici che da parte degli europeisti.
La Costituzione europea dopo Napoli
Gli avvenimenti successivi hanno mostrato ad libitum la gravità di questo clamoroso esito negativo. Innanzitutto la Presidenza irlandese ha subito messo le mani avanti, rilevando che l'area di dissenso era molto più estesa di quanto annunciato dalla Presidenza italiana. Il governo irlandese ha cominciato a muoversi con molta prudenza, dando segnali a volte di cauti progressi, ma il più delle volte inviando messaggi di scetticismo sulla possibilità di superare i contrasti. L'Irlanda è un piccolo paese con una linea di governo tradizionalmente molto prammatica, che teme fortemente di finire stritolato in una Conferenza intergovernativa controversa e perciò senza garanzie di successo. Per questo in tutto il mese di febbraio Dublino aveva lanciato messaggi di rinvio, molto pericolosi e scoraggianti.
Nel frattempo, e forse anche a causa di questi messaggi, prendeva corpo la proposta di un'Europa "a due velocità". Alcuni paesi, e in particolare Francia e Germania, moltiplicavano gli avvertimenti e le iniziative per permettere a quanti volevano in ogni caso andare avanti sulla via dell'integrazione di poter progredire verso forme di governo e campi di attività comuni.
Questa politica trovava ampio risvolto nelle riunioni periodiche dei due governi e nelle indicazioni comuni che lanciavano nelle riunioni settoriali del Consiglio dei Ministri.
La sorpresa è stata che ad essi si è unito, almeno per quanto riguarda la politica di difesa, il governo di Tony Blair che aveva mantenuto in tutta la discussione sulla Convenzione, nelle migliori tradizioni politiche britanniche, un atteggiamento quasi sempre euroscettico. Le interpretazioni di questa mossa sono state le più varie: da quelle positive per cui Blair per uscire dall'isolamento in cui si era trovato in Europa sull'Iraq, aveva deciso di saltare sul carro europeo della difesa, considerando anche gli interessi industriali della Gran Bretagna in questo settore. A quelle negative e cioè di entrare nel gioco franco-tedesco per controllare eventuali derive troppo autonome rispetto alla Nato.
Il fatto è che i vertici e le proposte dei tre grandi paesi risultavano sgradevoli ai governi dei paesi più piccoli, sempre timorosi di essere egemonizzati da una coalizione (si è parlato di direttorio) dei grandi paesi, ma anche all'Italia e alla Spagna, sempre più marginalizzate nei processi europei.
Da questi vertici parziali sono peraltro venuti alcuni segnali inquietanti come la proposta di creare un commissario per la competitività, il cui campo si è più concretamente precisato intorno al complesso dei problemi economici, e le proposte subito accettate da altri 6 paesi di limitare le risorse proprie della Commissione alla vigilia dell'allargamento.
Si stava così delineando uno scenario complessivo molto preoccupante con una Presidenza strutturalmente debole, tentativi di fughe in avanti, con solo il Parlamento europeo ed anche il Comitato economico e sociale europeo in grado di rilanciare con ostinazione la necessità di riprendere e concludere il cammino iniziato nella Convenzione, convinti che lo scorrere del tempo potesse pregiudicare i risultati raggiunti.
L'attentato dell'11 marzo
In questo clima malsano di una discussione che andava sempre più sfilacciandosi è piombato l'attacco terroristico di Al Qaeda e l'insospettato risultato delle elezioni spagnole.
Il primo effetto è stata la sensazione acuta ed estesa di insicurezza, che ha colpito l'opinione pubblica e la società europea, infine consapevole della esposizione al terrorismo in cui si ritrovava, dopo l'intervento in Iraq e dopo l'11 settembre americano e i numerosi e altrettanto sanguinosi attentati della stessa matrice avvenuti in Estremo Oriente, in Marocco e in Turchia.
Questa sensazione e il riflesso che essa ha avuto sulle istituzioni hanno portato alla fantastica manifestazione di Madrid, in cui le Tv europee hanno mostrato una marcia comune che vedeva la presenza dei capi di governo europei alla guida di milioni di persone.
L'effetto di questa immagine, la forza della condanna al terrorismo, il messaggio di solidarietà concreta che ha dato dell'Europa porteranno sicuramente ad un rilancio dell'integrazione europea. Davanti a quelle immagini e a quella domanda di sicurezza che esprimevano le società e le istituzioni dei paesi europei, si misuravano l'incongruenza scandalosa dei balbettamenti del ministro Castelli sul mandato di cattura o sulla procura europea. È probabile che sia nata di fronte a questa manifestazione l'Europa della sicurezza.
Altrettanto sconvolgenti per gli equilibri europei sono state le prime dichiarazioni del nuovo premier sull'Iraq innanzi tutto, ma anche sull'Europa e sulle sue prospettive. Sull'Iraq Zapatero ha proposto di ritirare il contingente spagnolo entro il 30 giugno, giorno di scadenza del precedente mandato, se l'Onu non assumerà una responsabilità condivisa sulla missione. Una proposta che sposta equilibri consolidati tra governo spagnolo e amministrazione americana e soprattutto in Europa, dato che la Spagna aveva firmato insieme ad altri 7 paesi la famosa lettera di dissociazione rispetto alle posizioni sostenute soprattutto da Francia e Germania. Dato che Aznar era stato tra i maggiori sostenitori del partito filoamericano, la nuova posizione del governo spagnolo indeboliva sostanzialmente quest'ultimo e rendeva meno ardua la ricerca di una linea comune europea con a più lungo termine la possibilità di superare gli ostacoli ad una dottrina di politica estera comune.
Ma riflessi decisivi avevano anche le dichiarazioni sulla politica europea. Qui anche il cambio di rotta era a 180°. La Spagna prendeva, infatti, l'impegno di arrivare al più presto all'approvazione della Costituzione, dichiarandosi pronta ad una trattativa senza pregiudiziali. La Polonia rimaneva così isolata nella sua politica di opposizione frontale sui diritti di voto e cominciava a lanciare messaggi di moderazione. Miller, primo ministro polacco, smentiva di aver mai lanciato lo slogan "Nizza o morte", che esprimeva con estrema rigidità la volontà di Varsavia di conservare il peso che le attribuiva il Trattato di Nizza. D'altra parte anche la Germania sembrava disponibile a discutere il compromesso raggiunto sulla Convenzione.
La presidenza irlandese e il Parlamento europeo e la Commissione riprendevano fiato e rilanciavano la proposta di concludere con la nuova Costituzione entro la fine di giugno.
Conclusioni interlocutorie
Alla vigilia del vertice europeo di primavera e di un chiarimento definitivo sul futuro della Costituzione, vorrei concludere con qualche considerazione di carattere generale sui problemi che presumibilmente rimarranno sul tappeto nei prossimi mesi.
La prima questione riguarda i tempi di approvazione della Costituzione che non sono ininfluenti rispetto ai suoi contenuti. Dato che essa entrerà in vigore in ogni caso nel 2009, si potrebbe pensare che non ci sia fretta. Invece è importante che essa sia approvata durante la Presidenza irlandese. Innanzitutto perché più passa il tempo più si logora l'effetto dato dalla Convenzione e peggiora quindi la qualità dei compromessi raggiunti in quella sede. In secondo luogo perché l'opinione pubblica europea, formatasi durante il corso dei suoi lavori, che era uno dei suoi successi più importanti, perderà con il tempo l'interesse per i suoi contenuti e il suo disegno complessivo. In terzo luogo perché siamo alla vigilia di importanti scadenze istituzionali con il rinnovo del Parlamento europeo a giugno e della Commissione ad ottobre. Un nuovo Parlamento e una nuova Commissione potrebbero difficilmente esercitare la stessa pressione positiva sulla Conferenza intergovernativa rispetto a quelli in scadenza.
Sui problemi di contenuto la discussione potrebbe prendere un altro slancio, se è vera e non solo emotiva la domanda di più Europa che veniva dalla manifestazione di Madrid e dagli attestati di solidarietà che sono venuti da tutti i popoli europei. Il problema della maggioranza qualificata potrebbe trovare una mediazione ragionevole (si parla di 55% degli Stati e 55% dei popoli), si potrebbe però vedere la possibilità di estendere il voto a maggioranza sui problemi di sicurezza e di cooperazione giudiziaria, oltre che stabilire, superando alcune reticenze dei paesi con una tradizione di neutralità, una clausola di solidarietà di cooperazione militare e di polizia contro gli attacchi terroristici.
Resta in prospettiva il problema di una Costituzione materiale che tarda a disegnarsi. L'effetto economico di depressione dei consumi e degli investimenti che produrranno gli attentati non possono essere ancora valutati: essi saranno pesanti e l'Europa, al contrario degli Stati Uniti, non ha una struttura istituzionale per rispondere con l'efficacia con cui hanno risposto le autorità americane. Negli Stati Uniti infatti subito dopo l'11 settembre è stata concessa un'enorme quantità di liquidità al mercato, tanto è vero che si è passati da una situazione di avanzo strutturale del bilancio ad una politica di "deficit spending" addirittura esagerato. Gli attentati e la loro minaccia in futuro hanno messo così in evidenza non solo una esigenza di sicurezza, ma anche la necessità di adottare strumenti di intervento economico anticiclico e non solo in questi casi di emergenza.
In sintesi questi attentati ci restituiscono un'Europa più fragile, ma forse più consapevole del suo destino comune.