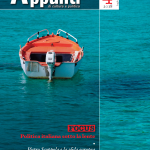Appunti 1_2004
Pace nella giustizia per la famiglia umana. A quarant'anni dalla Pacem in terris
| Achille Silvestrini |
La prima domanda che mi sono posto è questa: posso io spiegare la "Pacem in terris" a un pubblico come questo, che già la conosce e che l'avrà tante volte letta? Indubbiamente però ci sono aspetti da considerare: in primo luogo quello storico, come è nata l'enciclica. Vi è poi la persona di mons. Pietro Pavan, di cui va in qualche modo ricostruito il ruolo. Infine c'è la proiezione dell'enciclica oggi, del resto felicemente espressa da Giovanni Paolo II nel messaggio per la Giornata della pace 2003.
Il primo punto è il contesto della Chiesa. Esso è rappresentato dal momento di indizione del Concilio. Si avverte nell'enciclica il discorso di apertura del Vaticano II. E' il momento in cui Giovanni XXIII, l'11 ottobre 1962, pronuncia quel celebre discorso, che è una delle sue pagine più belle, allorché usa il linguaggio della speranza e presenta il Concilio non come un circolo di teologi ma come una assemblea destinata a "rendere la Chiesa presente nel mondo e il suo messaggio sensibile alla ragione e al cuore dell'uomo impegnato nella rivoluzione tecnica del XX secolo". E aggiunge quelle espressioni che sono diventate famose: "Ci sono persone che nei tempi moderni non vedono che prevaricazione e rovina e vanno dicendo che la nostra età in confronto con quelle passate è andata peggiorando. A noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di sventura". E' rimasta famosa questa presa di distanza di papa Giovanni dai "profeti di sventura", che annunziano eventi sempre più infausti, quasi che incombesse la fine del mondo. Il papa precisava poi che lo scopo del Vaticano II era questo: "Un approfondimento della dottrina certa e immutabile della Chiesa cattolica per presentarla in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo". Altra cosa è la fede, vale a dire le verità contenute nella dottrina cristiana, altra cosa è la forma con cui quelle verità vengono enunciate, conservando a esse lo stesso senso e la stessa portata. E' questo il quadro ecclesiale in cui nasce l'enciclica.
Poi c'è il quadro politico. Nell'agosto del 1961 c'era stata la crisi di Berlino, la costruzione del muro, davanti al quale Kennedy era poi andato a dire: "io sono un berlinese". L'Occidente si era perciò schierato contro la chiusura del muro. Questo approccio però permetteva successivamente contatti fra Chruscev e Kennedy per avviare possibili conversazioni, più che un negoziato, per un possibile assetto mondiale. Dall'altra parte c'è il rapporto fra il mondo sovietico, specialmente Chruscev, e Giovanni XXIII. Abbiamo il telegramma di Chruscev per l'ottantesimo di Giovanni XXIII il 25 novembre del 1961. Sappiamo bene che c'entrano De Luca, Rodano, fino a Togliatti, che avevano suggerito questa iniziativa. Apparentemente sembrava un puro complimento formale, in realtà era un primo accenno di dialogo.
Gravi rischi di guerra
L'anno successivo, nell'ottobre 1962, si apre invece la crisi cubana. Kennedy aveva incominciato il suo periodo presidenziale con la terribile sconfitta della "Baia dei porci", quando aveva trovato già pronto un progetto dei cubani esuli nella Florida, che la Cia aveva organizzato, per tentare un colpo di mano a Cuba. Era stato un fallimento totale. Kennedy era stato molto realista e ne aveva assunto la responsabilità, non aveva scaricato sui suoi organi esecutivi, e aveva così chiuso la cosa. Si trattava però del segno che Cuba rappresentava qualcosa di profondamente delicato nei rapporti Est-Ovest. Non era soltanto un piccolo paese che, nel contesto latino-americano, si era dichiarato comunista. Fidel Castro era andato al potere all'inizio del 1960 e Cuba era diventata una specie di avamposto del mondo comunista. L'intelligence americana attraverso i satelliti aveva verificato che si stavano costruendo basi missilistiche e che arrivavano le navi sovietiche dall'Europa con i missili.
Quella del 20 ottobre 1962 è una settimana drammatica. Il presidente Kennedy annuncia che bloccherà le navi sovietiche in rotta verso Cuba. Aveva tracciato una linea, che doveva essere invalicabile. Il 23 ottobre però, consapevole che rischiava tutto, manda il fratello Robert Kennedy dall'ambasciatore russo Dobrinin, con il messaggio che, anche se erano in disaccordo, c'era tuttavia una reciproca fiducia sulla quale Chruscev poteva contare. Poi viene fuori un singolare personaggio non ufficiale, Norman Kosinsky, che già lavorava tra Est e Ovest. Era introdotto bene a Mosca, lavorava con il dipartimento di Stato e organizzava anche degli incontri di studio tra scienziati atomici russi e americani. Kennedy lo chiama e gli dice: voglio prendere un contatto col Vaticano. Kennedy è un cattolico, però non aveva molte relazioni nel mondo vaticano. Kosinsky chiama il padre Morlion, un altro personaggio da studiare. Era un domenicano e fu fondatore della università Pro Deo. Lo ricordo nella primavera del '48 quando aveva organizzato una grande propaganda a favore della Dc. Morlion dice che dubitava di questo contatto col Vaticano ma, sollecitato, si mette in contatto con mons. Igino Cardinali. In questa situazione si vede come le persone contino moltissimo. Igino Cardinali, che poi è morto come nunzio in Belgio, era un latino-americano. Era nato a New York e vi aveva vissuto da ragazzo, quindi parlava inglese e aveva molti amici americani.
Il messaggio di Kennedy è questo: che Chruscev è disponibile al fatto che ci sia un invito a tutti e due per superare la situazione di rottura. Nella notte dal 23 al 24 ottobre Giovanni XXIII lavora con, accanto a lui, mons. Angelo Dell'Acqua e mons. Cardinali. Il messaggio venne preparato a notte inoltrata in una stanza dell'appartamento privato del papa. Mons. Cardinali e mons. Dell'Acqua avevano lavorato in équipe, ogni tanto il papa li lasciava e andava in cappella a pregare: "Voi continuate a lavorare – diceva – intanto anch'io vado a fare qualcosa". Le luci della Segreteria di Stato erano state accese fino all'alba. I prelati delle varie sezioni linguistiche aspettavano che fosse consegnato loro il messaggio per tradurlo nelle varie lingue. Il papa sapeva che Chruscev aspettava. La mattina del 24, mercoledì, fa un discorso di tono informale all'udienza generale davanti a ottocento pellegrini portoghesi: "il papa parla sempre bene di tutti gli uomini di Stato che si occupano di qua, di là, di su e di giù per incontrarsi ed evitare in realtà la guerra e procurare un po' di pace all'umanità. Ma si comprende che solo lo Spirito del Signore può compiere questo miracolo, giacché evidentemente laddove non c'è la sostanza e la vera vita spirituale non si possono immaginare di ottenere molte cose". Voleva dire dell'Unione Sovietica, ma forse anche dell'America. Mentre il papa ancora parlava inviati vaticani bussavano all'ambasciata sovietica e a quella americana a Roma portando il suo messaggio. Diceva il papa: "Noi ricordiamo i gravi doveri di coloro che portano la responsabilità del potere. Con la mano sulla coscienza ascoltino il grido angosciato che da tutti i punti della terra, dai bambini innocenti ai vecchi, dalle persone alle comunità, sale verso il cielo: pace, pace. Noi rinnoviamo questa solenne invocazione. Noi supplichiamo tutti i governanti di non restare sordi a questo grido dell'umanità". Alle dodici del 25 ottobre la radio vaticana diffuse l'appello. Il 26 ottobre la "Pravda" pubblicava l'appello del papa in prima pagina.
Si mette allora in moto il discorso negoziale. Alla Casa Bianca giunge un lungo telegramma di Chruscev: Se gli Stati Uniti s'impegneranno a non invadere Cuba e non permetteranno che altri lo facciano le cose saranno immediatamente cambiate. In questo caso la presenza dei sovietici a Cuba non sarà più necessaria. La crisi era come una corda con un nodo nel mezzo. Più se ne fossero tirati i capi più il nodo si sarebbe stretto e soltanto con la spada si sarebbe spezzato. Allentando invece i capi, il nodo si sarebbe sciolto. Kennedy rispose di essere pronto all'accordo e il 28 ottobre, domenica, arrivò la risposta di Chruscev il quale s'impegnava a interrompere i lavori alle basi missilistiche, a far rientrare in Unione sovietica le armi e ad avviare negoziati all'Onu. A Roma i giornali quella domenica mattina erano ancora allarmistici, la spirale però era già stata interrotta e pochi lo sapevano. Papa Giovanni celebrò nella cappella privata la Messa per la pace. Cadeva in quel giorno il quarto anniversario della sua elezione al pontificato. Mons. Dell'Acqua gli portò un messaggio segreto giunto da pochi minuti: Chruscev aveva accettato l'invito. Più tardi in dicembre Chruscev avrebbe significativamente sottolineato quello che papa Giovanni ha fatto per la pace: "Il suo intervento è stato un intervento umanistico che sarà ricordato nella storia. Il papa e io possiamo essere divergenti su molte questioni, ma siamo uniti nel desiderio della pace". Fin qui il contesto.
La via della distensione e l'impegno concreto per la pace
Ai primi di novembre dello stesso anno 1962 il papa chiama monsignor Pietro Pavan (poi cardinale): "Il Signore ci ha preservato da un disastro, la guerra, si direbbe ora che quando il papa parla di pace gli uomini lo stiano a sentire. Non potremmo riprendere l'argomento con maggior ampiezza?". Pavan ha ricordato che le concezioni del papa erano molto lineari in politica internazionale. Diceva il papa: "Io non posso attribuire malafede all'una o all'altra parte. Se lo facessi non ci sarebbe dialogo. Le porte si chiuderebbero". Giovanni XXIII voleva un'enciclica pastorale pratica. E qui emerge la sollecitazione per il lavoro dei cattolici a favore della pace. E' vero che l'enciclica si rivolge all'uomo di buona volontà, ma l'appello più forte, che è poi il finale dell'enciclica, è per l'impegno dei cattolici, esortati a partecipare alla politica con reale competenza e in piena autonomia. Il criterio-base era di ricercare ciò che unisce, mai ciò che divide. Che cosa hanno in comune tutti gli uomini, credenti e non credenti? Ecco il punto di partenza: la coscienza di essere persona. Lo proclama infatti il primo capitolo dell'enciclica, che muove dal concetto della persona.
Il 7 gennaio 1963 Pietro Pavan portò la prima redazione dell'enciclica. L'idea di Giovanni XXIII era che bisognava riaprire gli occhi dei credenti agli orizzonti della storicità: la dottrina va bene, ma essa non muove le persone; occorre che le persone si immergano in quelli che sono gli avvenimenti della storia, che ne prendano atto. Questa è un'altra delle ispirazioni che papa Giovanni ha fornito al Concilio, un potente principio di sollecitazione. Oggi noi vi siamo abituati, abbiamo capito che la Parola è legata alla storia anzi, come diceva una volta Enzo Bianchi, che la Bibbia nasce da una storia, direi quasi che è la storia che fa discendere la parola di Dio. Pertanto la storicità è vista come luogo in cui si manifestano i segni dei tempi e in cui si tratta di lavorare laicamente, senza integrismi e anche senza una visione teocratica. La stessa Chiesa è invitata a cercare se stessa anche fuori di sé. Una pace umana costruita secondo le modalità della crescita storica diventava uno scopo quanto mai meritevole di attenzione e dell'apporto dei credenti.
Un altro momento molto significativo di quel periodo è la conferenza che il card. Agostino Bea tenne il 13 gennaio 1963 in un'agape organizzata dalla Pro Deo davanti ai rappresentanti di settanta paesi e di ventidue gruppi religiosi. Il tema era la verità nella carità. Il cardinale Bea difende il mutuo rispetto e la libertà religiosa e condanna come male ogni guerra di religione. Egli spiega che la massima che l'errore non ha diritti, così usata per tutto il secolo XIX, è un nonsenso, dal momento che l'errore come tale è sempre un'astrazione, incapace quindi di avere o non avere diritti, mentre i diritti sono della persona e non cadono per la semplice ragione che le persone siano nell'errore. Questa è la chiave di tutto. Bea fu attaccato e spiegò che egli non parlava di una qualsiasi libertà ma della libertà di seguire la propria coscienza in cui c'è il mistero di Dio. La coscienza include la legge morale che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo e senza la quale la libertà diventa licenza. La "Pacem in terris" dirà: "ogni essere umano conserva in ogni caso la sua dignità".
Vi è un aspetto della figura di Giovanni XXIII che mi ha sempre colpito: egli non aveva la pretesa di proporre delle nuove dottrine, ma aveva una sensibilità che gli veniva dalla fede e dall'amore alle persone, all'uomo, all'umanità e che gli dava il dono di saper cogliere ciò che era maturo e urgente. Per esempio nell'atteggiamento verso gli ebrei. Nella prima Settimana di passione del suo pontificato, il venerdì santo del 1959, al momento della liturgia chiama improvvisamente il cerimoniere e dice: "adesso non mettete più nella preghiera "per i perfidi ebrei", ma dite semplicemente: pro judeis". Mi sono chiesto come gli fosse venuta questa idea. Ora, c'è un precedente. Nel 1928 esisteva una associazione a cui partecipavano anche dei cardinali romani e che si chiamava Amicizia ebraico cristiana. Fra le cose che proponeva vi era la ripulitura della liturgia dai sentimenti antisemiti. Papa Giovanni ha raccolto queste sensibilità. Era uomo che assumeva le cose vere, le custodiva dentro di sé e al momento opportuno le esprimeva. I suoi gesti non sono mai improvvisazioni. Ricordiamoci che egli ha conosciuto la stagione del modernismo e, benché ortodosso in tutto e per tutto, coglieva tuttavia che cosa c'era di accettabile nei cosiddetti modernisti. Era amico di Ernesto Buonaiuti e sapeva che cosa c'era in questa straordinaria figura.
Nel febbraio 1963 viene rilasciato dai sovietici l'arcivescovo Slipyi – di cui Chruscev si era impegnato a esaminare il caso – che giunge a Roma. Si ferma a Orte perché si voleva evitare la pubblicità e viene ospitato a Grottaferrata. Il giorno dopo si prostra a baciare i piedi del papa. Questi esclama: "grandi cose ha fatto l'Onnipotente" e Slipyi gli consegna la divisa di carcerato e la mappa russa dei campi dell'arcipelago Gulag. Il 13 maggio dello stesso anno in un memorandum della Cia è detto che il Papa e i suoi collaboratori pensano che in Unione sovietica il marxismo sia in declino e che stiano rinascendo sentimenti religiosi. Monsignor Pavan spiega invece: "No, non è questo assolutamente, non ci facciamo illusioni, ma il Vaticano vuole rafforzare, quando può, anche la Chiesa ortodossa russa perché serva i suoi rinascenti ideali cristiani". Alla luce di questo possiamo rileggere ciò che dice la "Pacem in terris": "In ogni essere umano non si spegne mai l'esigenza congenita nella sua natura di spezzare gli schemi dell'errore per aprirsi alla conoscenza della verità". E' l'insegnamento che fornisce anche il ben noto capitolo in cui si parla dell'ideologia e dei movimenti storici, dell'errore e dell'errante, e che trae la conclusione: chi può negare che nei movimenti storici, nella misura in cui essi sono conformi ai dettami della retta ragione e si fanno interpreti delle giuste aspirazioni della persona umana, vi siano elementi positivi e meritevoli di approvazione?
L'eredità della "Pacem in terris"
Dobbiamo interrogarci su quale eredità Giovanni abbia lasciato alla Chiesa e al mondo. La "Pacem in terris" completa il processo iniziato nella "Mater et Magistra" (anche questa enciclica, che è poco ricordata, è stata fatta da Pavan, come mi disse il cardinale Tardini). Giovanni XXIII vi si sente intimamente libero di considerare con la massima serietà il mondo moderno e di offrirne un giudizio positivo. Inizia ad esempio con una dichiarazione di fiducia nella scienza che sembra quasi echeggiare Teilhard de Chardin: i progressi delle scienze e le invenzioni della tecnica attestano come negli esseri che compongono l'universo regni un ordine stupendo. Nella parte della "Pacem in terris" intitolata L'ordine tra gli esseri umani sviluppa l'idea che il rispetto della dignità della persona umana è la norma di ogni morale. La persona ha diritti ai quali corrispondono doveri; ciò che contribuisce alla crescita della persona umana è positivo, ciò che ostacola o distrugge la crescita umana è negativo. Giovanni Paolo II è in perfetta continuità e sviluppo di tutte idee. La "Redemptor hominis" ne è documento. Essa afferma che il senso del vivere umano è rivelato soltanto dalla incarnazione di Gesù Cristo. E' Cristo che facendosi uomo si unisce in un certo modo ad ogni essere umano e gli conferisce il senso, gli comunica il perché della propria esistenza. Quindi la Chiesa è tenuta alla strada che gli è posta davanti da ogni essere umano: l'uomo è la via.
La "Pacem in terris" prova che c'è una differenza tra ciò che è semplice e ciò che è semplicistico. Questo specialmente per ciò che riguarda la guerra e la pace. Papa Giovanni assume uno stile molto diretto, ha però la semplicità di ciò che è essenziale, fondamentale. Quando parla della guerra dice: alienum a ratione. Quello che è stato nel passato lasciamolo da parte; il discorso è che oggi, con questi mezzi di distruzione di massa, è contro qualsiasi ragionevolezza pensare che la guerra possa risolvere le controversie internazionali. Se mai in passato sono stati formulati dei criteri – ad esempio il criterio che la forza dovesse essere misurata per non portare più danno di quello che la violazione aveva portato – ebbene oggi questa criteriologia non tiene più. Ecco il fondamentale, l'essenziale.
Anche riguardo alle Nazioni unite. Pio XII aveva enunciato nei suoi messaggi una costruzione della società internazionale che era parallela alle Nazioni unite. C'erano però molte riserve sulla stessa dichiarazione dei diritti dell'uomo, riserve per alcune espressioni che riguardavano il matrimonio, il rispetto della libertà di coscienza. Giovanni XXIII va al positivo quando dichiara che ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo il dettame della coscienza e quindi ha diritto al culto di Dio, privato e pubblico. Egli afferma qualcosa di nuovo perché ancora nel secolo XIX questa libertà non veniva riconosciuta a quelli che non erano cattolici. C'era sempre il problema dello stato cattolico confessionale e della tolleranza, ma non della libertà.
Quando Giovanni XXIII difende il diritto dei paesi in via di sviluppo all'autodeterminazione dice ancora qualcosa di nuovo. Nel 1830 il papato aveva ordinato alla Polonia e all'Irlanda, paesi cattolici, di obbedire alle autorità legittime, con Gregorio XVI. Nel 1863, quando ci fu l'insurrezione polacca, Pio IX aveva invece incoraggiato e difeso questo diritto della nazione polacca. Ancora: mentre nel secolo XIX la chiesa difendeva le sue posizioni salvaguardando i propri diritti istituzionali contro uno stato concepito come ostile, la "Pacem in terris" assegna la priorità ai diritti delle singole persone umane chiunque esse siano, e pertanto assume la difesa delle minoranze, dei rifugiati, dei popoli ancora non indipendenti. Mentre il secolo XIX si mostrava sprezzante nel confronto del linguaggio dei diritti umani, dalla Rivoluzione francese, Giovanni XXIII invece ritiene che i diritti umani siano fondamentali per la predicazione del Vangelo e, mentre il magistero del secolo XIX considera legittima la strumentalizzazione dello Stato da parte del cattolicesimo per mantenere le sue posizioni, Giovanni pensa a una società pluralista dove Chiesa e Stato sono distinti e possono collaborare
Vediamo adesso – terzo e ultimo punto – che cosa ha tratto dalla "Pacem in terris" il messaggio per la Giornata della pace del 2003. Giovanni Paolo II vi afferma che Giovanni XXIII aveva intuito la forza insita nella cosciente consapevolezza dei diritti umani che andava emergendo a livello nazionale e internazionale e il suo straordinario potere di cambiare la storia. Di questa consapevolezza Giovanni Paolo II ha fatto una forza d'urto nella sfida all'Est, e anche dopo nella critica al consumismo, al capitalismo consumistico. Quelle della "Pacem in terris" non erano idee astratte: sorsero ben presto, dice Giovanni Paolo II, dei movimenti per i diritti umani che diedero espressione concreta a una delle grandi dinamiche della storia contemporanea. E' quanto Giovanni Paolo II afferma anche nella "Centesimus annus". Il papa osserva ancora nel suo messaggio per la Giornata della pace 2003 come Giovanni XXIII abbia suggerito che il concetto di bene comune doveva essere rielaborato in un orizzonte mondiale. Non c'è più un bene comune della sola società nazionale ma un bene comune universale e, come conseguenza, l'esigenza di un'autorità pubblica a livello internazionale che possa disporre dell'effettiva capacità di promuovere tale bene universale Ma, come dice la "Pacem in terris", tale autorità non dovrebbe essere stabilita con la coercizione ma col consenso delle nazioni. Non è questo, chiede Giovanni Paolo II, il tempo in cui tutti devono collaborare alla costituzione di una nuova organizzazione dell'intera famiglia umana per assicurare la pace e l'armonia fra i popoli? E' tuttavia importante evitare fraintendimenti. Non si vuole qui alludere alla costituzione di un "super-stato globale". S'intende sottolineare l'urgenza di accelerare i processi già in corso per rispondere alla domanda pressoché universale di forme democratiche nell'esercizio dell'autorità pubblica sia nazionale che internazionale, come anche alla richiesta di trasparenza e di visibilità ad ogni livello della vita pubblica.
La "Pacem in terris" spinge con audacia il mondo a proiettarsi al di là del proprio presente stato di disordine e ad immaginare nuove forme di diritto internazionale a misura della dignità umana. Ricordiamoci che nella "Redemptor hominis" Giovanni Paolo II, sviluppando questo concetto, aveva detto che i diritti dell'uomo sono i criteri di legittimazione dei sistemi e dei regimi politici. Sono legittimi quei che promuovono i diritti dell'uomo e della persona e sono illegittimi quelli che li negano. Questa fu la sfida che Giovanni Paolo II lanciò all'Unione sovietica e al "campo socialista".
Infine richiamo il legame fra pace e verità, che contesta la visione di coloro che pensano alla politica come a un territorio svincolato dalla morale e soggetto al solo criterio dell'interesse. Proprio perché le persone sono create con la capacità di elaborare scelte morali, nessuna attività umana può situarsi al di fuori dalla sfera dei valori etici. Fra le premesse di una pace durevole c'è sempre un legame inscindibile – dice il messaggio per la Giornata della pace del 2003 – fra l'impegno per la pace e il rispetto della verità. L'onestà nel dare informazioni, l'equità dei sistemi giuridici, la trasparenza dei sistemi democratici danno ai cittadini quel senso di sicurezza, quella disponibilità a comporre le controversie con mezzi pacifici, quella volontà d'intesa reale e costruttiva che costituiscono le vere premesse per una pace durevole Vorrei sottolineare: onestà dell'informazione, equità dei sistemi giuridici, valore delle istituzioni, trasparenza delle procedure democratiche.
Pacta sunt servanda dice ancora il papa riprendendo l'antico adagio. Se tutti gli impegni assunti devono essere rispettati, una speciale cura deve essere posta nel dare esecuzione agli impegni assunti verso i poveri. Particolarmente frustrante è infatti il mancato adempimento di promesse da loro sentite come di vitale interesse. In questa prospettiva bisogna decisamente lamentare il mancato adempimento degli impegni con le nazioni in via di sviluppo. Qui emerge il pensiero di Paolo VI. Un' altra fra le encicliche che è stata messa "in archivio" (come la "Mater et magistra") è proprio la "Populorum progressio". Paolo VI aveva sostenuto che è lo sviluppo dei popoli il nuovo nome della pace. Se guardiamo alla differenza che c'è fra il 1967 (anno della "Populorum progressio") e oggi nel rapporto fra Nord e Sud, vediamo quanto la forbice si è allargata. La sofferenza causata dalla povertà risulta drammaticamente cresciuta dal venir meno della fiducia, e il risultato finale è la caduta di ogni speranza.