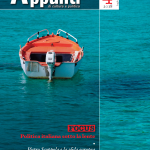Appunti 1_2004
Le proposte di riforma costituzionale del governo Berlusconi
| Leopoldo Elia |
Una considerazione anche rapida del disegno di legge costituzionale presentato dal governo (Atti Senato n. 2544) presuppone due precisazioni sul metodo di esame. Il primo è di carattere temporale: si deve tener conto della situazione odierna e non di quella risalente magari a cinque anni fa (tanti ne sono trascorsi dalla fine della bicamerale D'Alema). Sembra un criterio ovvio, ma in realtà non lo è, perché alcuni, in nome della coerenza, chiudono gli occhi di fronte alla evoluzione più recente e più significativa dell'ultimo quinquennio. La seconda avvertenza riguarda la necessità di un uso molto cauto ed informato dei precedenti di diritto costituzionale comparato, specie dopo le vicende della legge salvacondotto (più nota come lodo Schifani). L'iter legislativo e l'opinione pubblica furono in tal caso sviati anche da informazioni, rilevatesi inesatte troppo tardi, su un preteso diritto comune degli Stati democratici.
Auspico anch'io larghe intese, desiderabili sempre in tema di riforme costituzionali; ma non si può rinunciare alla critica e al dissenso, quando ci sembrano fondati. Due chiarimenti sul passato: malgrado il voto finale a maggioranza ristretta, non è un precedente autentico di revisione "maggioritaria" la riforma del Titolo V approvata al termine della XIII Legislatura. Infatti il disaccordo verteva su un di più rispetto al testo adottato: e cioè sugli emendamenti della devolution presentati dall'opposizione di allora dopo le intese con la Lega. Sul resto c'era un accordo che risaliva alla bicamerale e al voto della Camera nell'aprile 1998, confermato dalla non opposizione della Casa delle libertà in sede di referendum (ex art. 138 Cost.) e dalla ricezione ribadita nel testo presentato il 17 u.s. dal Governo. Invece a mio avviso si deve fare autocritica sul voto referendario in blocco previsto dalle due leggi costituzionali per le bicamerali De Mita-Jotti e D'Alema: l'eterogeneità della materia era lesiva della libertà dei votanti, come deprecava Dossetti e già nel 1996. Può darsi che, dati i precedenti, le obiezioni sviluppate ora da Alessandro Pace su questo punto non impediscano il voto in blocco del disegno di legge governativo su oggetti massimamente eterogenei: può capitarci anche di non essere presi sul serio, ma è comunque necessario creare una opinio che possa in futuro accrescere la libertà di chi partecipa al voto referendario scegliendo su singoli disegni distinti per materie omogenee, come era del resto espressamente previsto nel disegno di legge costituzionale Elia-Bassanini presentato alla Camera nel 1994. Le opinioni espresse dal relatore sen. D'Onofrio sul carattere unitario del progetto del governo, derivante dalla scelta di fondo del federalismo cooperativo, sebbene degne di riflessione, non convincono perché, ad esempio, il cittadino votante può essere favorevole al federalismo ma contrario al tipo di premierato prescelto, e viceversa.
Un rischioso "premierato assoluto"
Veniamo al merito. Premierato debole o forte? Non è questo il punto, perché negli articoli-chiave del testo si propone un "premierato assoluto", che contrasta con il principio cardine del costituzionalismo elaborato in più di due secoli dopo le rivoluzioni di fine settecento: il principio che si oppone alla concentrazione di troppi poteri in un solo titolare di ufficio pubblico. In questa proposta il primo ministro italiano, per la convergenza potestativa che si realizza nella sua persona, può essere assimilato soltanto al presidente della Repubblica francese quando è leader della maggioranza dell'Assemblea nazionale; e questa figura, anche dopo la riforma del quinquennato, è un unicum nel panorama costituzionale delle maggiori democrazie parlamentari. Altrettanto unico è lo status del presidente del Consiglio assicuratogli dalla legge sulle immunità per le alte cariche dello Stato. Ora si prosegue nella stessa strada garantendogli il monopolio del potere di scioglimento della Camera politica. In particolare si trasferisce a livello statale la normativa prevista per il governo delle regioni e per quello dei principali enti locali con finalità "antiribaltone"; come è noto, secondo tale regola, alla sfiducia manifestata dai consigli nei confronti del vertice di governo fanno riscontro simultaneo ed automatico l'effetto delle dimissioni del titolare del potere governante e quello dello scioglimento del consiglio sfiduciante.
Eppure la grande maggioranza della dottrina italiana si era pronunciata a più riprese contro l'estensione di tale regola ai rapporti tra governo e parlamento nazionale per ragioni piuttosto evidenti: sia per l'anelasticità e l'automatismo del collegamento tra la sfiducia e le sue conseguenze sia perché il potere legislativo delle camere riguarda non di rado situazioni costituzionalmente protette come diritti fondamentali: porre la fiducia su questioni riguardanti tali diritti (si pensi al diritto di informare e di essere informati ex art. 21 Cost.) può presentare pericoli che è doveroso non incentivare.
Il potere di scioglimento delle camere senza vincoli
Orbene, la riforma governativa non si accontenta di estendere il simul/simul al rapporto tra premier e Camera dei deputati (art. 94, terzo comma), ma aggiunge il potere permanente del premier di chiedere al presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere a prescindere da ogni manifestazione di sfiducia (art. 88, primo comma); il premier, secondo la formula trasposta dall'art. 115 della Costituzione spagnola, agisce "sotto la sua esclusiva responsabilità". Ma noi sappiamo da sempre che dove è la responsabilità ivi è il potere: dunque è questo un potere ad esercizio solitario del premier, dotato di effetto automatico (la relazione governativa parla per pudore di "sostanziale automatismo").
Inoltre questo potere è assolutamente monocratico anche per la posizione della questione di fiducia al governo ad oggetto del tutto indeterminato, giustamente definita da Giuliano Amato come una "bomba nucleare" (art. 94, secondo comma, una specie di voto bloccato, che se dà esito negativo, produce l'effetto simul/simul): mai è prevista una deliberazione del Consiglio dei Ministri, come in altri ordinamenti, mai un vero intervento di garanzia, come un potere di rifiuto, da parte del capo dello Stato, privato cosi del mezzo più significativo per adempiere alla sua funzione di garante costituzionale (art. 87, comma primo). Perfino nella legge fondamentale israeliana del 14 aprile 1992, che introduceva l'elezione diretta del primo ministro, lo scioglimento della Knesset, su proposta del premier non sfiduciato, era previsto con l'approvazione del presidente di Stato; e – a fortiori – dopo l'abrogazione di questa legge (7 marzo 2001), si è affermato che lo scioglimento del parlamento può essere attivato dal premier in accordo con il capo dello Stato.
Del resto, da sponda non sospetta di nobile conservatorismo, si esprimono rilievi di sicura consistenza. Augusto Barbera, a proposito del presidente della Repubblica, osserva: "Inoltre deve mantenere una qualche funzione di garanzia, nel caso la decisione di sciogliere il parlamento fosse un atto palesemente ingiustificato"1. Ma come fa il presidente a garantire, dico io, se il potere è monopolizzato dal premier? E Stefano Ceccanti aggiunge: "perché prevedere un automatismo di scioglimento in caso di voto contrario alla priorità del governo o di approvazione della sfiducia?"2.
In appoggio all'attribuzione del potere di scioglimento al premier si è soliti citare il modello Westminster. Ma nella classica monografia di G. Marshall, Constitutional Conventions, troviamo scritto a proposito del premier: "His right is only to advise, not to have, dissolution; since dissolution can in some circumstances to be refused"3. Infatti il primo ministro britannico ha buone chances di ottenere lo scioglimento della Camera dei comuni, se innanzi tutto ha la maggioranza nel suo partito parlamentare. Dunque, il primo vero contrappeso al potere del premier consiste nella funzione di controllo che esercita nei suoi confronti il suo gruppo.
E' superfluo citare le dimissioni non infrequenti di primi ministri inglesi posti in minoranza; basta ricordare che Blair si sarebbe dimesso se non avesse mantenuto il consenso del suo partito parlamentare per la vicenda irachena. Ma da noi, con i partiti personali, padronali e di clan, controllo non ce n'è, specie sulle questioni che davvero interessano il primo ministro.
I poteri del governo sono già stati rafforzati
E poi negli ultimi cinque anni c'è stato un notevolissimo rafforzamento del potere governativo e del presidente del Consiglio. Con il regolamento Violante, ogni tentativo ostruzionistico è, alla Camera, bloccato a priori e i tempi dell'iter legislativo, severamente contingentati, consentono deliberazioni su temi gravi anche in tempi brevi. Quanto ai poteri normativi del governo è ormai divenuto costante il ricorso a leggi-delega, che rappresentano autentiche cambiali in bianco. Può darsi che qualcuno, il quale non si stanca di richiamare vecchie prese di posizione dentro la bicamerale D'Alema non si sia accorto di quel che è successo dopo. Ma il catalogo è questo. E siamo tanto poco ossessionati dalla situazione dell'attuale presidente del Consiglio, che il premierato assoluto non lo vorremmo neppure se fosse, in futuro, un leader dell'opposizione di oggi a potersene servire.
Che cosa offriamo per avere un primo ministro tipo Westminster? Certo il potere di proporre al capo dello Stato la revoca oltre che la nomina dei ministri, al fine di evitare casi Mancuso. Non abbiamo obiezioni di fondo a dare al premier la nomina e la revoca; anche se ricordiamo che il sacrosanto rifiuto del presidente Scalfaro ci ha evitato nel 1994 la nomina a ministro della Giustizia dell'avvocato del presidente del Consiglio.
Per lo scioglimento della Camera si può concordare sul recupero del potere di proposta del vertice dell'esecutivo perduto dopo le vicende del 1953, che col trascorrere del tempo avevano indotto una parte cospicua della dottrina e del ceto politico a ritenere che il potere di scioglimento fosse attribuito esclusivamente al presidente della Repubblica. Qui il potere di proposta viene esercitato nell'ambito di una potestà condivisa, il cui esercizio è legato al consenso di entrambi i titolari dei due uffici. La decisione del presidente, che può anche rifiutare la proposta, sarà adottata considerando il risultato elettorale ma anche quanto può essere avvenuto dopo le elezioni, specialmente in termini di attuazione del programma. La storia non finisce con l'election day.
Peraltro è da apprezzare positivamente, nel progetto del governo, la deroga all'automatismo (prevista dall'art. 92, quarto comma ), secondo cui in caso di morte, di impedimento permanente, di dimissioni del premier per cause diverse dalla sfiducia, il presidente della Repubblica nomina un nuovo primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati. Si evita così la grottesca rigidità dell'art. 126, comma terzo, Cost., che fa discendere lo scioglimento del Consiglio regionale anche dalla morte, dall'impedimento permanente e dalle dimissioni volontarie del presidente della Giunta. E' pure apprezzabile il tentativo di identificare gli atti del Presidente della Repubblica di sua esclusiva competenza , escludendo la necessità della loro controfirma da parte del primo ministro o di altri ministri (art. 89, terzo comma).
Da ultimo va considerato che la singolarissima ampiezza del potere di scioglimento del primo ministro corrisponde ad un impianto che già in sede elettorale, con le indicazioni sulla scheda del nome del candidato alla carica e il collegamento con la candidatura nei collegi, tende a risolvere la vita democratica in una democrazia di mera investitura: e il fenomeno si aggraverebbe in regime proporzionale con premio alla coalizione vincente. Anche qui si dovrebbe far autocritica essendo sufficiente per far funzionare il modello Westminster rendere noto prima delle elezioni il nome dei leader candidati alla premiership e i loro programmi.
Il federalismo cooperativo e l'attribuzione delle competenze
Ho dedicato ai poteri del Primo ministro la maggior parte del mio contributo; e con ciò non è certo esaurito il commento sulla riforma di governo delineata nella nuova proposta; ma ho detto quanto basta per mettere in guardia contro i pericoli di una "democrazia del capo", che toccherebbe in fine anche la forma di Stato (qualità della democrazia). Passo ora a qualche osservazione sulle nuove norme dedicate al federalismo. Credo sia stato saggio mantenere, in tema di riparto di attribuzioni legislative tra Stato e regione a statuto ordinario, lo schema della riforma precedente: competenze esclusive dello Stato, competenze concorrenti, competenze esclusive (in forma espressa o residuale) delle regioni. L'eliminazione delle competenze concorrenti (che non è la ragione preminente del contenzioso presso la Corte costituzionale) ha evitato che la somma di competenze esclusive statali e regionali accentuasse la rigidità del sistema in netto contrasto con l'impianto di federalismo cooperativo accolto dalla riforma. Certo la formulazione del nuovo quarto comma dell'art. 117 (lett. a-d del primo comma) non offre un contributo di chiarezza nel contesto dei poteri ripartiti ai tre livelli delineati nei due commi precedenti dello stesso articolo; ma alcuni pericoli già paventati in sede interpretativa dovrebbero essere in via di superamento, salva sempre la possibilità di formulazioni più chiarificatrici. Se mai, per la legislazione concorrente si potrebbe discutere se al criterio troppo rigido, almeno in apparenza o meglio sulla carta, fondato sulla distinzione tra principi e legislazione applicativa di dettaglio, non sarebbe conveniente sostituire una soluzione analoga a quella dell'art. 72 della Legge fondamentale tedesca che attribuisce al Bund l'intera disciplina nelle materie nelle quali viene posta a rischio l'unità giuridica o economica del gesamtstaat o meglio dell'interesse dello Stato intero, comprensivo del Bund e dei Länder. Ma in Germania questa scelta è fortemente condizionata alla presenza del Bundesrat!
Inoltre bisognerebbe eliminare gli equivoci non solo verbali della confusa formula, secondo la quale i senatori (come i deputati) "rappresentano la Nazione e la Repubblica" (art. 67): la confusione si aggrava poi nell'art. 127, nuovo secondo comma, in cui si ragiona di leggi regionali che pregiudichino "l'interesse nazionale della Repubblica". A parte i dubbi circa i rapporti tra l'art. 114 Cost. e il concetto di Gesamtstaat è evidente che queste infelici formulazioni nascondono la duplice funzione del Senato federale nel bicameralismo asimmetrico accolto nel progetto governativo di riforma. Innanzitutto il Senato federale "assicura la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica" (secondo la definizione dell'art. 24 della Costituzione francese vigente); e inoltre svolge funzioni di garanzia nella dinamica della forma di governo secondo un modulo già fatto proprio nel progetto di riforma a suo tempo elaborato dalla Commissione bicamerale D'Alema. Quelle singolari formulazioni che giustappongono Nazione e Repubblica non trovano nella relazione governativa alcuna spiegazione o motivazione.
Quanto al Senato federale dirò che l'eliminazione del rapporto fiduciario col governo costituisce una razionalizzazione del bicameralismo italiano, più volte richiesta anche in dottrina. Senza entrare nel merito del riparto di competenze tra Camera e Senato, mi limito a rilevare che il recupero del bicameralismo procedurale, già previsto nel disegno di legge costituzionale approvato dal Senato nella X legislatura, assume nel testo finale della proposta governativa un carattere spiccatamente maggioritario: perché la richiesta di riesame nella camera priva di competenza a deliberare deve partire non già da un terzo dei suoi componenti, come era previsto nel testo originario, bensì dalla maggioranza dei suoi membri (art. 70, comma secondo).
Ma a questo punto è necessario porsi una domanda cruciale che i critici della soluzione proposta per la composizione del Senato federale risolvono di solito in una contestazione del suo "effettivo" carattere federale. Forse, in un'ottica di politica costituzionale, è meglio porre il problema in questi termini: le regioni e gli altri enti locali territoriali si sentono veramente rappresentati dal Senato costruito dalla riforma del governo? Sentono questo Senato come loro "espressione"? La domanda cosi definita non si esaurisce con una risposta di carattere psicologico (sia pure di psicologia collettiva!). Perché se la risposta fosse sostanzialmente negativa, la conseguenza gravissima sarebbe l'estromissione di fatto di entrambe le camere dal processo di sviluppo del federalismo italiano. Anche se i rappresentanti delle regioni e delle autonomie "faute de mieux" mostrassero di rassegnarsi alla soluzione del progetto governativo, è chiaro che quel processo di sviluppo si svolgerebbe nella Conferenza in cui si confrontano governo, regioni ed enti locali territoriali, lasciando al Senato un ruolo puramente ratificatorio (come per i trattati!) degli accordi raggiunti col governo in quella sede o in altra ancor meno formalizzata. E' certo scartata in base al principio di realtà l'ipotesi di un Bundesrat italiano; perciò è inutile stare a discutere sul carattere parlamentare o meno di questo Consiglio federale nell'ordinamento tedesco perché conta l'esistenza di un organo costituzionale mediante il quale i Länder cooperano con il Bundestag partecipando ad alcuni procedimenti legislativi che li riguardano. Certamente non sono "surrogati" sufficienti di questa partecipazione né le norme di dubbia costituzionalità sui requisiti "localistici" per l'elezione al Senato, né le proposte per la simultaneità delle elezioni senatoriali con quelle regionali, né, tantomeno, la creazione di raccordi di carattere meramente consultivo: si tratta di pannicelli caldi, anzi tiepidi, privi di reale efficacia ai fini di una rappresentatività del Senato cosiddetto federale.
Allora scartato questo (Bundesrat), scartato quello (Senato statunitense composto di un numero pari di senatori per ogni stato membro) non rimane che puntare su una composizione mista, già avviata dall'accettazione da parte del ministro Bossi dell'appartenenza di diritto al Senato dei presidenti delle Regioni, estensibile ad una presenza più ampia di eletti dei consigli regionali e di esponenti degli enti locali.
I rischi di politicizzazione delle istituzioni
Certo, la mancata attuazione dell'art. 11 della legge cost. n. 3/2001 esprime di per se stessa una forte resistenza alla composizione mista anche in dimensioni più modeste (pur dovendosi tener conto del maggior ostacolo rappresentato dalla composizione mista in sede bicamerale). Ma mi sembra che fermarsi di fronte a questo passaggio sarebbe piuttosto ingiustificato. Si ricordi, tra l'altro, che già il progetto di Costituzione della Commissione dei 75 (art. 55, terzo comma), sottoposto all'Assemblea costituente, prevedeva l'elezione di senatori da parte dei consigli regionali per un terzo dell'intero Senato. All'obbiezione che il Senato spagnolo a composizione mista abbia dato luogo ad un'esperienza piuttosto grigia, si può replicare osservando che ciò è dipeso più che dalla struttura, dal conferimento di funzioni e poteri troppo deboli, al contrario di quanto si propone per il Senato federale italiano. Se la scelta di una notevole inserzione di senatori di origine autonomistico-territoriale riuscisse a ricondurre in area parlamentare (con la partecipazione a procedimenti legislativi) il processo di attuazione e di sviluppo del federalismo italiano, varrebbe la pena di tentare questa strada. Dare effettività al carattere federale del Senato è importante anche per la composizione della Corte costituzionale. Se questa effettività facesse difetto sarebbe difficile non concordare con chi in questo potere così sovradimensionato ravvisa lo strumento usato non già per accrescere il tasso di sensibilità autonomistica nella Corte ma piuttosto per incrementarne la politicizzazione (così Marino Bin).
Infatti la questione non riguarda soltanto la funzionalità della Consulta (due sezioni, sezioni unite? contrasti giurisprudenziali?) ma tocca la sua struttura e il suo ruolo nell'ordinamento costituzionale. E' grave alterare il delicato equilibrio raggiunto faticosamente dall'Assemblea costituente per coniugare preparazione giuridica e sensibilità politica; ricordiamo che il progetto della Commissione dei 75 prevedeva che tutti i giudici sarebbero stati nominati dall'Assemblea nazionale (parlamento in seduta comune). Solo l'impegno illuminato di Mortati, Calamandrei, Leone e Perassi riuscì ad evitare il rischio di un peso eccessivo attribuito a scelte di organi a componenti partitiche. Tra i sei nominati dal Senato e i tre nominati dalla Camera si arriverebbe a ben nove giudici eletti da un parlamento di partiti. Inoltre nella situazione attuale accrescere il tasso di politicizzazione significa accentuare il trasferimento di una dialettica bipolare in seno all'organo di giustizia costituzionale:una sede del tutto impropria.
Da ultimo non posso tacere il regresso, rispetto ai progetti della bicamerale D'Alema, della normativa sullo statuto dell'opposizione, che non può certo esaurirsi in un vago rinvio al regolamento della Camera (art. 64, comma 5).