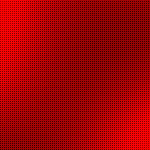Appunti 5_2003
Sommario
Dalla lista Prodi al partito unico riformista
Guido Formigoni
Una lista unitaria per un riformismo pluralista L’esigenza dell’unità e l’eredità di un’esperienza In un suo forte editoriale intitolato Berlusconi e l’indegnità di governare , Leopoldo Elia ritiene infatti sbagliato il «voler mettere tra parentesi e considerare meritevole ormai soltanto di silenzio l’attacco alla magistratura e ai magistrati lanciato dal presidente Berlusconi». Ciò proprio ora che la stessa Costituzione viene svillaneggiata ogni giorno da quei politici estremisti. E non ci può più essere dubbio che la pervicacia del premier «è in larghissima misura fondata – continua Elia – sull’amnesia degli elettori e sulla presunzione della loro smemoratezza». Perciò ricordo che anche da monaco, nel crepuscolo della sua vita, Giuseppe Dossetti si decise ad impegnarsi a difesa attiva della Costituzione, promuovendo un largo movimento di opinione pubblica. E non si dica quindi che puntare ad una lista unitaria, ma ricca al suo interno di tradizioni pluraliste , possa danneggiare il consenso dalla dialettica tra diverse tradizioni.
Achille Ardigò Leggi tutto
Qualche rischio in tale direzione sembra presente pure nei dibattiti in corso alle formazioni politiche dell’Ulivo e dei loro associati. Anche tra chi ha raccolto l’annuncio «dalemiano» in favore di una nuova formazione politica del centrosinistra – come lista unitaria o come «partito riformista europeo» e d’intesa con Romano Prodi – c’è chi ha ecceduto nel suo entusiasmo. Gad Lerner ad esempio, in un suo recente editoriale sulle pagine di «Europa» ha intravisto il superamento del rifiuto, da una parte dei Ds, a fondersi con altri partiti qualora questi non aderiscano all’internazionale socialista. Lerner vede con piacere che tale auspicato superamento unitario può rilanciare la proposta di un partito democratico, tout court, fatta nella primavera scorsa da Michele Salvati.
Sennonché, privata dei richiami ai valori riformisti e pluralisti, la convergenza verso la grande, e però difficile da realizzarsi, formazione politica di centrosinistra (senza più trattino), potrebbe incoraggiare l’inesorabile riduzione della politica a «politichese». Se persino la Chiesa cattolica si sta aprendo alla teologia del pluralismo, non vedo perché dei politici impegnati nella ricerca del bene comune non possano invece operare una integrazione unitaria nell’essenziale, riconoscendo, entro il quadro politico unitario, il pluralismo con radici nelle tradizioni riformiste. Teniamo presente, in caso contrario, che oggi sacrificare la ricchezza delle tradizioni migliori può anche danneggiare la nostra efficacia nella denuncia degli attentati alla democrazia e alla Costituzione.
Di recente ho rievocato la forza del riformismo civico di Dossetti espressa per le amministrative di Bologna del 1956 e quale fu l’efficacia verso le «opere di concordia» del «discorso per il bene della città», prodotta dall’impegno dossettiano a confronto col riformismo di Giuseppe Dozza. Questi due riformismi, quello civico cattolico e quello social-comunista, sono stati di recente riconosciuti da Sergio Cofferati, quali forze tuttora vitali a Bologna. Il richiamo di quell’evento del 1956 si concentra, occorre precisarlo, nel monito dossettiano di allora: «rianimare il volto spirituale della città». «Qualsiasi programma di rianimazione e di sviluppo della città – ha scritto Dossetti – sul piano economico non meno che sul piano culturale, deve prima dire che cosa può e deve essere fatto per liberare e rinvigorire la personalità morale della città».
Chi scrive, insieme con un gruppo di riformisti civici dossettiani bolognesi, ha ritenuto opportuno, in vista del primo ciclo elettorale, previsto per il 2004 a Bologna, tentare di far rivivere ed aggiornare la tradizione riformistica civica dossettiana. Constatiamo che diventa sempre più difficile vivere un’ispirazione spirituale e insieme un impegno di concreto riformismo politico-sociale. E’ al riguardo significativo che in una situazione sociale di diffuso impoverimento della popolazione, e di profonda crisi del welfare state, dopo due anni di governo berlusconiano, il richiamo del Libro bianco su Bologna stia peraltro portando qualificati politici, operatori sociali e studiosi, a riproporre il rinnovamento delle funzioni sociali dei quartieri degradati grazie anche all’azione del sindaco attuale.
Dalla luce ai lumini: la crisi energetica italiana
Giovanni Colombo
Focus: L’America latina, tra vecchie crisi e nuove speranze
L’infinita crisi dell’Argentina La lunga germinazione della crisi Negli ultimi mesi si è diffuso un «mito» secondo cui l’economia argentina sarebbe crollata per non aver voluto seguire i dettami del Fondo monetario internazionale. Certo nei mesi precedenti alla crisi i dirigenti del Fmi e i responsabili del dicastero economico argentino erano ai ferri corti; gli analisti invitavano il governo a presentare conti conformi alla realtà e, dopo il crack del dicembre 2001, le negoziazioni bilaterali per il rimborso dei prestiti si sono svolte all’insegna della tensione. Questo non può però far dimenticare che fino a pochi anni orsono l’Argentina era indicata dagli stessi responsabili dell’istituto finanziario come un «paese modello» nel contesto latinoamericano. Possibile che un’improvvisa inversione di rotta nelle politiche macroeconomiche nazionali abbia potuto provocare un tale sfracello e che non si potessero frapporre correttivi, quantunque in corsa, al declino generale di un sistema a lungo considerato tra i più solidi del subcontinente? Il veranito: ovvero la difficile transizione La caduta del governo di centro sinistra di de la Rúa, mai troppo amato dagli Argentini e simbolicamente conclusasi con la sua fuga in elicottero mentre la gente protestava nelle piazze, apriva la strada al ritorno dei peronisti. Adolfo Rodríguez Saá è stato il primo a provarci, assumendo l’interim in dicembre, ma ha subito dovuto desistere, all’indomani della contestata scelta di sospendere il pagamento del debito estero. E’ tornato così prepotentemente sulla scena uno dei «pezzi da novanta» del Partito giustizialista (Pj), l’ex governatore della capitale, Eduardo Duhalde, già collaboratore e poi storico rivale di Menem all’interno del partito, che ha puntato a gestire l’emergenza, per traghettare il paese fino alle elezioni presidenziali previste per la primavera 2003. In attesa di una ricostruzione La sfida elettorale è iniziata in questo quadro complesso, in una fase di ridefinizione dei canali di raccolta del consenso e di riequilibrio delle forze in campo. Praticamente scomparso il centrosinistra di de la Rúa, poco compatto il fronte dei partiti di sinistra (divisi nella Sinistra Unida di Patricia Walsh, socialisti radicali e trotzkisti), la partita per la presidenza si è giocata all’interno dei peronisti del Pj. Già il mancato appoggio del partito a Saá durante il suo brevissimo interim aveva evidenziato quanto l’unità del partito fosse una chimera; le primarie non sono quindi mai giunte a compimento e all’inizio dell’anno è venuto chiaramente alla luce il dualismo insanabile tra Duhalde e Menem. Ma se il primo ha preferito mantenere una linea di «basso profilo», annunciando la sua intenzione di rispettare il passaggio di consegne con un presidente eletto, accontentandosi (si fa per dire) di mantenere la leadership della sua corrente e consolidando l’asse con Cavallo, la ricandidatura di Menem al suo terzo mandato è apparsa a molti una scelta contraddittoria. Nonostante l’ostinazione dell’ex presidente, che si è gettato nella mischia ventilando il ritorno ad una nuova stagione di successi, la sua candidatura ha infatti subito incontrato una serie di ostacoli, a cominciare dal riemergere di vecchi scandali giudiziari (dal caso delle vendita d’armi alla Croazia, alle accuse di depistaggio relative all’attentato del 1994 contro il centro ebraico della capitale). Alla fine il Pj è giunto alle elezioni lacerato in tre tronconi: il Fronte per la lealtà di Menem, il Fronte della vittoria di Néstor Kirchner e il Fronte per il movimento popolare di Saá, come ha scritto Chierici, tutti e tre presentatisi come eredi di Perón, evidentemente una «parola magica» ancora viva nell’immaginario collettivo nazionale nei momenti di difficoltà.
Massimo De Giuseppe Leggi tutto
La crisi in effetti parte da lontano e ha visto svilupparsi un profondo e spesso poco chiaro intreccio tra cause interne, regionali e internazionali, assurgendo a simbolo delle contraddizioni della globalizzazione, evidenziando i limiti del Mercosur e l’impatto della politica «latinoamericana» di Washington e degli istituti internazionali. Le specifiche problematiche interne vanno infatti collocate in un più generale quadro che ha contrassegnato il subcontinente nell’ultimo ventennio e che si è legato, come ricorda Marcello Carmagnani in un suo recente saggio, alle difficoltà di trasformazione della «funzione di produzione» e alle dinamiche del rapporto tra economia di libero mercato e distribuzione del reddito, evidenziando una crescente disattenzione di gran parte dei governi latinoamericani verso quelle che si potrebbero definire strategie di controllo della povertà .
Come dire che si sono applicati in molti casi, politiche radicalmente neoliberiste in assenza però di un effettiva e matura economia di mercato e in presenza di una situazione socio-politica segnata da questioni sociali storicamente irrisolte. I processi innescatisi negli anni Ottanta e Novanta hanno quindi non solo evidenziato le crescenti difficoltà strutturali dell’economia reale di produzione argentina in un contesto sempre più globalizzato, ma messo in luce da un lato la debolezza di un sistema che non riesce a tassare i redditi e le rendite dei privilegiati, dall’altro la profonda contraddittorietà sottesa a impianti finanziari fragili e volatili.
In Argentina, gli anni di Menem sono stati quelli della grande deregulation, in linea con la lezione che il reaganismo aveva imposto negli Stati Uniti e tra i partner latinoamericani nel corso del decennio precedente. In dieci anni il governo ha privatizzato praticamente tutto quello che poteva privatizzare, dal gas all’acqua, dall’elettricità ai porti, dalle telecomunicazioni alle linee aeree, attirando ingenti investimenti stranieri (tra cui molti italiani e spagnoli) ma senza esigere quelle garanzie di controllo che un’operazione di tale portata avrebbe richiesto.
Nel corso degli anni Novanta il neoliberismo argentino, solo esternamente ammantato di caratteri di nuovo populismo (slegato dalla tradizione del populismo tradizionale d’impronta peronista, ancorato invece a modelli di massiccio intervento pubblico e di politiche protezioniste), si è basato su radicali riforme macroeconomiche e piani d’aggiustamento che hanno messo in evidenza un crescente allargamento della forbice sociale (nel 1974 il 20% della popolazione più ricca del paese percepiva un reddito 7,8 volte superiore al 20% più povero; nel 2002 questo rapporto è salito al 14,6), erodendo così quello che da sempre era stato un patrimonio originale del paese: la presenza di una corposa, articolata e regionalmente diffusa classe media.
Come è accaduto quindi che quello che era considerato uno dei sistemi socio-economici più stabili dell’America latina, passato attraverso dittature militari e regimi autoritari, sia stato eroso dal suo interno senza che nessuno se ne accorgesse. Forse non è stato proprio così o meglio molti se ne sono accorti (sia dentro che fuori l’Argentina) ma hanno preferito non darlo a vedere. In fondo il crollo del dicembre 2001 è arrivato sotto il peso di un incontrollabile debito estero, dopo cinque anni consecutivi di recessione e sull’onda della svalutazione del real introdotta dal governo brasiliano nel 1999 che diede un colpo decisivo al sistema delle esportazioni argentine.
Alla ricerca delle cause del crollo molti economisti si soffermati però anche su un altro nodo cruciale, da inserire in un quadro complesso di crisi concatenate: il mantenimento ad ogni costo della parità valutaria tra peso e dollaro. La scelta compiuta durante la presidenza Menem dal ministro delle finanze Domingo Cavallo, di agganciare il peso alla moneta statunitense rappresentò una svolta significativa rispetto al piano Austral di rafforzamento della valuta nazionale voluto dall’amministrazione Alfonsín alla fine degli anni Ottanta. La parità peso/dollaro si rivelò uno degli elementi chiave della politica liberoscambista condotta dall’Argentina negli anni Novanta, aumentandone però al contempo gli elementi di rischio.
Fin dalla seconda metà del 1999 i segnali di crisi cominciarono a manifestarsi e il debole governo De la Rúa, successo a Menem (dopo il fallimentare tentativo di questi di modificare la Costituzione per ottenere un terzo mandato) non è parso in grado di far fronte alla situazione. Mentre il rendimento dei fondi argentini continuava a rimanere altissimo e ad attirare capitali, cresceva la volatilità del sistema e parallelamente la sfiducia dei grandi investitori che cominciavano a spostare i propri capitali su mercati a rischio più contenuto. La modernizzazione del sistema economico si è così trasformata in una falla senza fine e la recessione ha messo in luce una «mongolfiera» del sistema finanziario argentino, facendo luce su una serie di zone d’ombra del «sistema paese».
Le speculazioni e la debolezza del sistema produttivo e d’esportazione sono venute gradualmente alla luce nel corso del 2001. La legge del luglio di quell’anno, ribattezzata «deficit zero», che puntava a ridurre la spesa pubblica per allentare il debito estero, non ha invertito la tendenza, indebolendo ulteriormente le reti di protezione sociale e mettendo in luce un crescente divario tra città e campagne. L’implosione, del sistema è arrivata quindi in inverno, travolgendo la classe media e trascinando con sé anche il governo che si ostinava a non voler abbandonare la parità con il dollaro per ridare un po’ di fiato alla valuta nazionale. Risultato è stato che in poche settimane si sono letteralmente bruciati nelle tasche degli investitori decine di miliardi di euro del debito estero argentino, sollevando dubbi sul ruolo giocato da banche e finanziarie nella divulgazione di «sane» informazioni ai risparmiatori.
In questa fase di transizione, ribattezzata dagli argentini veranito, il governo ha cercato di muoversi con equilibrio, evitando nuove scosse politiche ma restando sul filo del rasoio per tutto il corso dell’anno. Già il 5 gennaio 2002, cinque giorni dopo il suo insediamento, il governo Duhalde varava una legge finanziaria d’emergenza con cui sospendeva la parità con il dollaro, svalutando il peso. Quindi in febbraio il ministro delle finanze Remes Lenicov, lasciava fluttuare la moneta, ottenendo qualche spiraglio di manovra.
Iniziavano intanto pressanti e complesse negoziazioni (più volte interrotte o sospese) con il Fmi da una parte e con banche e creditori stranieri dall’altra. I tamponamenti finanziari hanno dato un po’ di respiro, senza predisporre però gli strumenti per un effettivo risanamento. D’altra parte l’improvvisa intransigenza mostrata dai dirigenti del Fmi (che sospendevano un prestito di 9 miliardi di dollari), dopo le accuse di lassismo accumulate in precedenza, rischiava di trasformare le rinegoziazione del debito in una sorta di tragica pantomima. Fallito il plan Bonex, chiusa temporaneamente la borsa di Buenos Aires, cambiata la guida del dicastero delle finanze (con l’avvento di Roberto Lavagna) e della Banca nazionale, la situazione finanziaria si è poi parzialmente stabilizzata, fino alla fissazione del rapporto dollaro-peso a quota 2,90. Alla fine il Fmi ha dato il via libera a un nuovo accordo per un credito di 3 miliardi dollari, con una proroga per la parte restante.
Sul fronte interno intanto, chiusasi rapidamente la fase più violenta delle agitazioni (gli scontri tra manifestanti e polizia hanno lasciato sul terreno 30 vittime in gennaio), si è puntato a contenere la pressione sociale, salita più volte oltre i livelli di guardia. Con un’inflazione balzata oltre al 20%, una disoccupazione al 25%, i salari reali strozzati, i poveri nelle strade e i primi bambini «morti per fame», la disperazione quotidiana cominciava a riempire le prime pagine dei giornali. Della crisi argentina i mezzi d’informazione si sono occupati con dovizia di particolari come non accadeva dall’epoca delle Malvinas e delle «madri di plaza de mayo», rompendo per alcuni mesi il silenzio informativo che sempre più sembra avvolgere il subcontinente latinoamericano. Più ancora dei saccheggi dei supermercati e dei bambini senza cibo che tanto scalpore hanno fatto sui media internazionali, a livello interno sembrano però aver pesato le proteste di piazza organizzate dei piqueteros, esponenti di una classe media improvvisamente risollevatasi da un lunghissimo torpore, con il suono del cacerolazo e le contestazioni urlate da chi aveva visto prima bruciati e poi bloccati dal governo i propri depositi. Tutto ciò mentre prendeva il via un significativo flusso emigratorio, da quello che da sempre è stato un paese d’immigrazione. Particolarmente colpiti sono risultati i pensionati e i dipendenti pubblici. In marzo la Corte suprema ha quindi stabilito che i conti bancari svalutati venissero ridollarizzati a spese dello Stato, mentre il Lavagna puntava al graduale riequilibrio macroeconomico in attesa dell’esaurimento della fuga di capitali.
Alla fine del 2002 i dati erano comunque impressionanti: oltre il 50% degli argentini viveva oltre o lungo la soglia della povertà, con 8 milioni di disoccupati e 15 milioni di persone definite in situazione di povertà assoluta . Come ha scritto il giornalista Ulyses Araucho Tehuelche «Per scienziati e curiosi della politica, ma anche per chiunque voglia sapere di che morte si può morire nell’Occidente globalizzato, l’Argentina è come il monte Palomar per gli astronomi: permette di vedere tutto a distanza ravvicinata. L’Eldorado promesso lungo un secolo a milioni di emigranti italiani, è oggi un paese che vive senza anestesia la crisi del sistema democratico» .
Il crack ha infatti messo a nudo la profonda crisi del sistema partitico argentino e più in generale la fragilità delle democrazie latinoamericane ma anche portato alla luce un’inaspettata vivacità della «società civile» balzata all’onore delle cronache internazionali non solo per le proteste di piazza ma anche per iniziative quali il treque (sorta di sistema di baratto di beni e servizi), i mercati solidali, le fabbriche autogestite da cooperative di operai; elementi che hanno colpito certo l’immaginario collettivo ma anche contribuito ad articolare il quadro della ricostruzione nazionale.
L’esito del voto del 27 aprile non ha contribuito a chiarire la situazione; il sogno di Menem di vincere al primo turno senza ricorrere a un pericoloso ballottaggio (in cui molti voti di sinistra avrebbero potuto confluire su Kirchner) è andato in frantumi, anche se questi ha ottenuto la maggioranza relativa con il 24,3% dei voti, seguito da Kirchner con il 21,9%. Al liberale Murphy è andato il 16,3%, alla socialista moderata Elisa Carrío dell’Union civica radical (assurta negli ultimi anni a «paladina» della lotta alla corruzione) il 14,1%, a Saá il 14%. In attesa del ballottaggio del 18 maggio, l’attenzione si è concentrata sulle mosse di Menem che a quattro giorni dal voto ha deciso di ritirarsi, puntando così a minare fin dall’inizio l’azione del candidato rivale, trovatosi nella poco simpatica condizione di presidente meno votato nella storia del paese.
Di Néstor Kirchner non si sa molto: avvocato, sposato con la senatrice Cristina Fernández, è stato dal 1991 governatore di Santa Cruz, ai confini con la Terra del fuoco. La sua campagna elettorale è stata all’insegna di richiami al New Deal keynesiano ma la sua esperienza di governatore si è svolta in sintonia con le iniziative dei governi nazionali e nella sua elezione è risultato decisivo l’appoggio dello zoccolo duro dei peronisti della capitale.
Il 25 maggio il neopresidente si è però insediato alla Casa Rosada, annunciando un programma ambizioso di ripresa economica, rinegoziazione del debito, lotta alla corruzione e rilancio del Mercosur che fa venire alla mente i proclami di Fox all’indomani del suo insediamento in Messico dopo 71 anni di dominio del Pri. Che si tratti di una nuova forma di populismo, diversa dal populismo neoliberale di Menem (che con il populismo tradizionale ha in comune, secondo Loris Zanatta, solo «taluni caratteri politici – la leadership carismatica, il loro richiamo al popolo contro determinate élites, l’insofferenza verso i vincoli istituzionali in nome del mandato popolare,…» ), o di una vera svolta politica lo scopriremo nei prossimi mesi.
Kirchner intanto ha confermato la propria fiducia in Lavagna e mostrato una certa disinvoltura nel muoversi sullo scenario internazionale. Rinfocolando le critiche del fronte menemista, il 18 giugno ha incontrato Lula con cui ha discusso una serie di strategie comuni per il rafforzamento del Mercosur; i due hanno stilato un accordo che prevede una possibile ridefinizione dell’unione sul modello europeo, ipotizzando un consolidamento degli istituti comunitari e la creazione di una moneta comune, fissando accordi per le negoziazioni con Washington sul Trattato di libero commercio. Un mese dopo è volato in Europa per il vertice dei partiti progressisti, organizzato nel Surrey da un Tony Blair in debito di credibilità, per approdare poi il 15 luglio a Bruxelles dove si è incontrato con Romano Prodi, con cui ha discusso del possibile rafforzamento dei rapporti tra Mercosur e Ue. Sul fronte interno è stato intanto stabilito un aumento delle pensioni minime del 10% e del salario base del 50%, da scaglionarsi nei prossimi sei mesi. Nel nuovo clima, a fine agosto, il senato ha quindi votato l’abolizione delle leggi (Obediencia debida e Punto final) che avevano introdotto l’amnistia per centinaia di militari sospettati di crimini durante gli anni della dittatura militare e il 25 settembre il discorso di Kirchner all’Assemblea generale dell’Onu è stato incentrato sulla difesa dei diritti umani con un riferimento all’eredità delle «madri» di Plaza de Mayo.
Le prime mosse del nuovo presidente appaiono interessanti; resta l’incognita dell’effettivo sostegno in seno al suo partito a programmi di ampio respiro e, sul fronte internazionale, di come Washington prenderà i progetti di rafforzamento del Mercosur e di un possibile asse con l’Europa; il paese saprà reagire agli impulsi economici per uscire dalla crisi e il governo saprà offrirgli gli strumenti per farlo?
Alla fine delle nostre «piccole storie», la giovane madre vince un frullatore ma poi si accorge che a casa sua non c’è la luce; il commesso viaggiatore vede crollare il suo mondo e poi s’imbatte in una speranza inattesa; l’anziano signore ritrova il suo «facciabrutta». O forse non è proprio lui ma i due se ne vanno lo stesso insieme su un vecchio bus diretto a Sud, verso la Terra del fuoco.
Resistenza e resa degli indios della foresta amazzonica
Rosario Iaccarino intervista don Carlo Iadicicco
Padre Tamayo, allievo di Oscar Romero
Dario Paladini
Due recenti documenti della Congregazione per la dottrina della fede
Alberto Lepori
Avete una casa a Baghdad. Intervista a monsignor Shledon Warduni
Silvio Mengotto
Un’indipendenza da mantenere. A proposito di autorità di regolazione
Michele Passaro
La cultura della destra cattolica istituzionale e moderata
Lorenzo Gaiani
Prolegomeni ad una formazione aziendale
Pierluigi Mele
Libri: Sindacalismo senza memoria?
Gianni Avonto