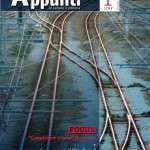Appunti 4_2003
Sommario
La Repubblica dell’impunità
Guido Formigoni
L’Ulivo non può attendere
Pietro Scoppola
Gasparri e Berlusconi: i peggiori ricorsi storici nella legge sulle telecomunicazioni Sulla legge Gasparri che nelle intenzioni dovrebbe riordinare il settore delle telecomunicazioni le parole definitive sono state gà state scritte da Salvatore Bragantini sul «Corriere della Sera» (9 luglio) e non ci sarebbe da aggiungere nulla di più: «Il disegno governativo è da buttare. Le sue falle sono talmente numerose che la barca va affondata al più presto. Costa molto meno partire da capo con un testo sensato che non cercare di rabberciare un relitto». Una sentenza senza appello, seguita da quelle pronunciate da Giovanni Sartori, sulle stesse colonne, e perfino da Luca Cordero di Montezemolo che nella sua veste di presidente degli editori si è spinto a dichiarare che sono in pericolo pluralismo e libertà di stampa, e non è certo un girotondino, anzi, è stato a un passo dall’ingresso nel governo Berlusconi come ministro. Non ci sarebbe molto da aggiungere. Se non che la battaglia parlamentare di queste settimane sulla Gasparri meriterebbe di essere accompagnata da una mobilitazione nella società pari almeno a quella che si scatenò giusto un anno fa sulla legge Cirami. Anche perché il disegno di legge che porta il nome del ministro di An, il più querulo del governo, il più berluschino dei post-camerati, in realtà è molto più pericoloso per gli equilibri della democrazia di quello sul giusto processo. Nel caso della Cirami si trattava di una legge ad personam, tagliata su misura per rivestire di impunità Silvio Berlusconi e Cesare Previti, ma almeno poteva essere disinnescata dal potere giudiziario, come infatti è avvenuto. Mentre il riordino delle telecomunicazioni viene a cadere in un settore, quello dei media, che da decenni versa in condizioni pietose, abbandonato alla legge del più forte, con incursioni, rapine, continue violazioni di regole, monopoli mascherati da concorrenza, crollo della qualità dei programmi e dell’informazione, eliminazione delle voci scomode, appiattimento, omologazione. Un Far west che molto difficilmente troverà in sé le risorse per riprendersi dall’ennesimo assalto della politica. La legge conferma ancora il potere La legge arriva alla fine e fotografa la situazione. Per decenni l’intero panorama dei media italiani è rimasto senza un provvedimento di sistema che fissasse diritti e doveri, limiti e possibilità prima del servizio pubblico radiotelevisivo e poi del sistema misto pubblico-privato. Senza, peraltro, abbandonare lo sviluppo dei media alla libera concorrenza e al mercato. Insomma, a inizio secolo, con le prime trasmissioni radiofoniche, si stabiliscono due modelli possibili. Il primo, quello americano, dove tutto è affidato alle regole del mercato e alle grandi corporations che guerreggiando tra loro a caccia di pubblico e audience sono anche costrette a darsi qualche regola di competizione. Il secondo, quello inglese, è fondato sul servizio pubblico, la mitica Bbc, senza pubblicità, di controllo governativo ma autorevolissima e di fatto indipendente (come dimostra, in queste settimane, il caso dello scienziato David Kelly che ha portato il governo Blair a un passo dalla crisi). In Italia, nulla di tutto questo: servizio pubblico, ma doppiamente spurio. Dal punto di vista economico, perché fin dall’inizio convivono il canone con la pubblicità. E dal punto di vista politico, perché l’ente concessionario è accomodato sotto padrone, prima il fascismo, poi la Democrazia cristiana e, a partire dagli anni Settanta, il sistema dei partiti nel suo complesso, senza una legge che fissi i confini. Quando arriva la riforma, nel 1975, è troppo tardi: la Rai viene tolta dal controllo dell’esecutivo e affidata al parlamento, sperando così di garantire il pluralismo. Ma dopo una breve, felice esperienza il pluralismo diventa lottizzazione e i partiti tornano a fare il bello e il cattivo tempo. Lo stesso avviene nel 1990 con la legge Mammì: anche in questo caso la legge arriva a babbo morto, quando la Fininvest di Silvio Berlusconi, ben appoggiata da Bettino Craxi che già nell’84 era ritornato precipitosamente da un viaggio di stato a Londra per varare il decreto salva-Berlusconi (il primo di una lunga serie, evidentemente), ottiene il congelamento dello status quo. Anche in quel caso ci fu una bufera politica, cinque ministri della sinistra democristiana arrivarono a dimettersi. Uno scontro violento che, c’è da giurarlo, questa volta non si ripeterà. Ma anche la legge Gasparri, in comune con le precedenti, arriva in ritardo e per cristallizzare l’esistente: non per aprire spazi nuovi, non per agevolare l’ingresso in campo di nuovi soggetti. Semmai l’esatto contrario. Rivoluzioni tecnologiche e monopoli appena mascherati Le rivoluzioni televisive sono sempre avvenute per via tecnologica, mai per via politica. Ma poi la politica è intervenuta pesantemente per controllare, indirizzare, frenare. Così è stato all’epoca della tv a colori, così è avvenuto con l’arrivo delle tv private, con la possibilità tecnica di dare l’assalto al monopolio Rai. Ora c’è la novità del digitale: la molteplicazione dei canali che dovrebbe portare con sé la moltiplicazione dei volti, delle voci, dei punti di vista, delle risorse. Invece, si sta mettendo in piedi l’ennesimo monopolio: dopo quello Rai all’epoca della prima Repubblica, dopo quello Mediaset degli anni Ottanta-Novanta, ecco l’ombra del magnate australiano Rupert Murdoch che con la sua Sky sarà il monopolista della tv satellitare. Con l’amico Berlusconi in posizioni complementare, monopolista della tv generalista e in chiaro: padrone di Mediaset e anche della Rai, ridotta a tv residuale, con audience in crollo, programmi pessimi, informazione asservita. «Una tv per le fasce povere della popolazione, gli anziani, i disoccupati, il centro-sud», ha scritto «Le Monde» (26 agosto), in un’inchiesta intitolata significativamente «In Italia il servizio pubblico è senza mezzi e senza libertà». Gli esempi si potrebbero moltiplicare: Berlusconi comincia il semestre europeo a Strasburgo insulando l’europarlamentare tedesco Martin Schultz e il caso fa il giro d’Europa? Il Tg1 fa sentire solo gli applausi, i fischi li racconta, si fa per dire, la brava inviata al seguito del Cavaliere. Berlusconi rifiuta di andare a Verona al vertice con Prodi e Schroeder? E i tg Rai fanno capire che la pacifica città di Romeo e Giulietta, in realtà, è un covo di brigatisti e ultras, con «il matto» pronto ad attentare alla vita del premier. A chi affidare la direzione artistica di Sanremo? A Tony Renis, il paroliere preferito di Silvio. Che, peraltro, ha già riempito i corridoi di viale Mazzini di uomini (e donne) cresciuti alla scuola del suo staff. Peggiorerà la crisi della carta stampata I rapporti tra tv e carta stampata sono sempre stati pessimi. Effetto, anche, di una tacita spartizione del territorio, per cui la stampa era di proprietà dei grandi gruppi industriali del nord, voce di una borghesia ricca e illuminata, forse a volte neppure tanto ricca e certo poco illuminata, la voce dei poteri forti e anche di un certo laicismo, mentre la Rai era in mano ai partiti, devota alla Chiesa, sensibilissima ai movimenti della politica e dei palazzi romani. Anche Berlusconi, quando ha cominciato a fare sul serio, si è affidato alle mani curate e esperte di Gianni Letta. Ma ora siamo al punto di non ritorno, perché la Gasparri rischia di squilibrare definitivamente il mercato a vantaggio della tv, anzi, della Raiset berlusconiana. C’è il blocco di fatto, per esempio, di ogni possibile ingresso di editori privati nella privatizzazione Rai, perché nessun azionista potrà avere più dell’uno per cento delle azioni. Una finta public company, che lascia inalterato l’assetto del servizio pubblico, a vantaggio dell’attuale proprietario, cioè la maggioranza di governo, cioè Silvio Berlusconi. Anzi, si prepara un grande ritorno: la nomina dei vertici aziendali da parte della commissione parlamentare di vigilanza e del ministero dell’Economia cui spetteranno i nomi di maggior peso, tra cui il presidente. Si prepara cioè uno spettacolo avvilente, i piccoli partiti a contedersi uno strapuntino nel consiglio di amministrazione e i grandi che manovrano a piacimento. Dall’altro lato, invece, c’è la possibilità degli editori radiotelevisivi di entrare nel mercato della carta stampata. In pratica: Mediaset potrà entrare nella proprietà dei giornali esistenti o fondarne di nuovi, mentre la strada opposta sarà impossibile. Finito? No, perché resta la questione della torta pubblicitaria: anche in questo caso la bilancia della Gasparri pende tutta dalla parte di Mediaset. E poi dicono che hanno fatto diventare Montezemolo barricadero. Il problema vero evidentemente sta nel manico Nonostante queste ricorrenze storiche l’anomalia italiana continua ad avere un nome e un cognome. E non basta dire che nonostante lo strapotere mediatico Silvio Berlusconi ha perso le elezioni amministrative, ha perso contro Romano Prodi nel 1996 e che, insomma, il suo governo non sta andando benissimo e la gente se ne accorge anche se i tg ogni sera affermano il contrario. Perché il sistema televisivo rimane l’arma più formidabile del Cavaliere: la sua stessa ragione d’essere, la sua identità, il suo patrimonio. Qualsiasi legge di sistema sulle telecomunicazioni si trova davanti questo macigno insormontabile.
Marco Damilano Leggi tutto
Il peggior prodotto del governo
Ma la vicenda Gasparri presenta qualche spunto di riflessione alla luce di tutta la tormentata storia dei rapporti tra il potere politico e i mezzi di comunicazione di massa. Il prossimo 3 gennaio la tv italiana festeggerà il mezzo secolo di vita: certo, dal monocanale in bianco e nero targato Rai all’invasione satellitare di Sky di Rupert Murdoch la strada sembra ancora più lunga, e dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica del mezzo le cose stanno esattamente così. Ma l’uso politico della tv, invece, è immutato. Ci sono più somiglianze che differenze. Basta un rapido esame per accorgersene.
Eppure un’altra via sarebbe possibile: quella indicata dalle sentenze della Corte costituzionale e dal messaggio alle Camere del presidente Ciampi di un anno fa. Non tanto la vicenda Rete4 sul satellite, che pure servirebbe a liberare frequenze e risorse. Sognare un sistema di media liberale, di pesi e contrappesi, un paesaggio libero di padroni e di tiranni. Il contrario di certe battaglie retrograde e reazionarie: costruire, dopo anni di letargo, un insieme di garanzie democratiche ma anche di stimoli e possibilità per nuovi soggetti imprenditoriali che si vogliano affacciare sul mercato. Una vera sfida riformista, questa. Poco più che un sogno, nell’Italia di Berlusconi (e di Gasparri).
Focus: contro-riforma scolastica
Tre tesi sulla riforma della scuola
Fulvio De Giorgi
La riforma della scuola: qualche punto sulle “tre i” Dopo l’approvazione della legge delega sulla riforma della scuola (28 marzo 2003, n. 53) è partito il cronometro dei ventiquattro mesi necessari per l’attuazione dei relativi decreti. E’ passato, apparentemente senza mutamenti di sostanza, un quarto del tempo a disposizione del governo e ancora poco o nulla è stato deciso. Il termometro della scuola, però, registra i primi segnali di insofferenza. Studenti, docenti, dirigenti e le stesse famiglie sono preoccupati e in allerta: «Che cosa ci aspetterà?» chiedono a politici e ad esperti, ma nessuno è in grado di dare esaustive risposte. E’ evidente che accanto alle domande, se vogliamo ingenue di genitori e alunni ci sono altri interrogativi, ben più allarmati, dell’universo degli amministratori locali, timorosi o ansiosi di fronte al protagonismo che gli scenari della riforma paiono loro configurare. Non mancano i dubbi del mondo economico e imprenditoriale e di quello dell’editoria scolastica. Una lettura culturale: istruzione o mercato? Il secondo conflitto: centralismo o decentramento? La riforma nasce, secondo alcuni, anche dalla necessità di dare risposta alle sfide del decentramento: in questa logica la scuola dev’essere spogliata da tutta la burocrazia centralistica. Giova ricordare che su questa materia, la recente revisione del titolo V della Costituzione impone la diversa considerazione delle competenze attribuite allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali. E’ probabile che il rispetto della nuova normativa comporti, nei prossimi anni, il «travaso» di giurisdizione dal centro alla periferia e, in assenza di un quadro più chiaro, non sono da escludere conflittualità e sovrapposizioni tra istituzioni. Tale processo di devolution, di per sé apprezzabile nel suo intento di alleggerire la Pubblica Istruzione da una serie di gravami finanziari-burocratici, rischia, se non sostenuto da adeguati correttivi, di scaricare alle amministrazioni periferiche antichi problemi dell’amministrazione centrale. Occorre quindi auspicare che anche il federalismo vada nella direzione dell’autonomia e si traduca in impegnativi passi di responsabilizzazione dei singoli istituti scolastici e non nella moltiplicazione di centri di poteri sul territorio. Quanto della prevista quota di curricolo affidata alle regioni si tradurrà in provinciale localismo e quanto in approfondimento delle proprie radici culturali? Che misure verranno poste affinché non si sostituisca alla burocrazia dello Stato quella, non meno insidiosa, delle regioni? Cosa si può salvare della tradizione centralistica della Pubblica Istruzione Italiana? Sono tutte domande su cui converrebbe avviare un dibattito ben più approfondito rispetto a quanto sta avvenendo. L’anticipo e i cicli Il sistema duale Conclusioni
Fabio Pruneri Leggi tutto
La lettura storica: come si è riformata la scuola in Italia.
Se si volesse semplificare, potremmo dire che le riforme della scuola sono avvenute in passato secondo tre modelli. Il primo che definirei dall’alto verso il basso, è quello che ha accompagnato lo sviluppo della Pubblica Istruzione alla nascita dello Stato italiano e che venne sostanzialmente confermato dalla riforma Gentile del 1923, anche questa approvata in regime di pieni poteri, nel primo governo Mussolini. Il secondo modello di riforma scolastica potrebbe essere definito come un accordo o compromesso dall’alto verso l’alto. Collocherei questo modello riformatore dalla Costituente fino ai primi anni Sessanta. I protagonisti delle riforme furono, in questa fase, i partiti, fortemente rafforzati nella loro legittimità dalle vicende resistenziali e dal grande consenso che essi esercitarono sulle masse. Verso la fine del decennio ’60 e, segnatamente, sulla questione della nascita della scuola materna statale (1968) della riforma dell’università e degli esami di stato (1969), abbiamo il consolidarsi di un modello nuovo dal basso verso l’alto, che pur mutando ha, a mio giudizio, caratterizzato tutte le riforme dagli anni Settanta alla fine degli anni Novanta. Gli interventi di riforma sono nati, prima, nella scuola e, poi, sono approdati nelle aule parlamentari, ricevendo una legittimazione legislativa a posteriori. La forma più spinta di questa evoluzione è, a mio giudizio, l’autonomia scolastica che sposta alle singole scuole responsabilità e, anche, conflitti gestiti in passato dall’amministrazione centrale o periferica.
La riforma Moratti appare, nonostante il goffo tentativo dello spot televisivo che recita «Abbiamo chiesto alle famiglie…abbiamo chiesto ai genitori… abbiamo chiesto agli insegnanti…», come la riproposizione del primo modello dall’alto verso il basso. Un alto che è pienamente legittimato dal voto popolare, ma che si è costruito sul sapiente impiego dei mezzi di comunicazione – penso all’efficace messaggio delle «tre i»: Inglese, Internet, Impresa – e sulla semplificazione. La politica scolastica della destra è nata anche da una ben orchestrata delegittimazione del tentativo di riforma Berlinguer – De Mauro. Il governo Berlusconi, fin dai primi cento giorni, avrebbe bloccato i bizantinismi della la riforma del centro sinistra: stop ai suoi perversi effetti «stalinisti», agli allarmismi suscitati dalla cosiddetta «onda anomala», all’ansia delle famiglie e all’incertezza degli stessi operatori per la chiusura della scuola media e la morte dei licei.
Per questo è necessario tentare una lettura, che forse un po’ enfaticamente, definirei culturale della riforma. Il centrodestra ha abilmente sfruttato i pregiudizi nei confronti della scuola pubblica, ritenuta obsoleta e improduttiva, prefigurando la nascita di un sistema competitivo e efficiente. Anche se gli articoli della legge 53 non si esprimono nettamente a favore di una privatizzazione del servizio scolastico sono emerse, principalmente dal ministro dell’economia, precise politiche di contenimento della spesa per l’istruzione pubblica, e, perfino, per la ricerca, che fanno comprendere come essa non sia considerata strategica. E’ chiaro, inoltre, che il minor impegno dello Stato in alcuni servizi alla persona non si è trasformato nella fine del bisogno, ma nell’introduzione di nuovi soggetti in grado di garantire prestazioni a pagamento alternative a quelle precedentemente offerte. Si pensi, tanto per fare dei casi, alla questione del taglio degli insegnanti di sostegno nelle scuole: i genitori hanno integrato il deficit di offerta formativa, con servizi riabilitativi presenti sul mercato. Qualcosa di analogo è avvenuto con gli asili 0-3 e, in alcune aree della Lombardia, con la scuola dell’infanzia. A fronte dell’impossibilità di prosciugare le liste di attesa da parte dei comuni (i quali non hanno risorse aggiuntive) e da parte dello Stato (che non può immettere in ruolo nuovo personale, anche se vi è un’aumentata richiesta di servizi all’infanzia) sono nate molteplici iniziative, gestite da privati, spesso di dubbia qualità, che hanno permesso alle famiglie di risolvere il problema dell’accudimento dei figli. Il mercato ha, in buona sostanza, prodotto servizi. In realtà questi non sono sorti in una logica di competizione, ma di supplenza di un servizio che in passato era gestito e sostenuto dagli enti pubblici e che ora viene «colonizzato» dai privati.
Anche ammettendo che a lungo termine ciò possa produrre un sistema più competitivo, cosa che non accade oggi, dove, semplicemente la famiglia si vede costretta a pagare due o tre volte ad un privato quello che ieri era concesso a costo inferiore dallo Stato, resta da verificare la validità dell’equazione competizione = miglioramento del servizio. Per molti settori, specie per i servizi alle persone, i trasporti, la sanità, la scuola, i mezzi di comunicazione, l’energia, una certa difesa di standard minimi rende più equo il sistema. Del resto l’insuccesso della deregulation, delle assicurazioni automobilistiche, delle tariffe dei carburanti e in parte della telefonia in Italia, dei trasporti e della sanità in Inghilterra, del sistema carcerario e, recentemente, anche della produzione d’energia elettrica negli Stati Uniti, tanto per fare degli esempi al di fuori della nostra penisola, invitano ad una certa prudenza.
Nella lettura culturale della riforma emerge l’esistenza di un primo «conflitto d’intessi» tra educazione e mercato. Il problema non è se funzioni meglio la scuola pubblica o la scuola privata, ma se ci possa essere un mercato sulla scuola. La formazione ha un costo elevato, i tagli in questo settore porteranno facilmente ad un beneficio per le casse dello Stato, ma faranno perdere beni non monetizzabili, come la cultura e la preparazione dei cittadini del paese. Da questo punto di vista, come si è detto, è molto più influente la politica finanziaria del ministro Tremonti che la riforma del ministro Moratti.
La scuola, in una fase in cui si bada a far quadrare i conti secondo la logica del tutto subito (si pensi alla vendita dei beni immobili dello Stato e ai vari condoni), appare un investimento a lungo termine non molto gratificante. Tuttavia è chiaro che perdere nel settore della formazione significa, in un mondo senza barriere, non solo arretrare in termini di competitività, ma addirittura in sovranità. Per fare un solo esempio: il numero di cellulari vede l’Italia ai primi posti nel mondo, ma la ricerca sulle tecnologie wireless è da noi all’ultimo posto. Come dire noi siamo solo consumatori passivi di prodotti studiati da altri. Inutile, quindi, invocare dazi e protezioni a tutela del made in Italy o pensare che, con la semplice introduzione dei buoni scuola, si possa improvvisamente avviare un ciclo virtuoso di ammodernamento e competizione nel sistema dell’istruzione.
Perplessità metodologiche: la delega e l’obbligo
Ad un primo sguardo, la riforma Moratti appare come la rassicurante conferma della situazione scolastica precedente (3 anni della scuola dell’infanzia, 5 anni della scuola elementare, 3 anni della scuola media, 5 anni dei licei, oppure 4 anni della formazione professionale). Si tratta però di verificare nei prossimi mesi come il governo darà attuazione ai paletti della delega, molto dipenderà dalle disponibilità finanziarie dello Stato. Se è possibile esprimere apprezzamento – sulla carta – per l’estensione obbligo, la formazione insegnanti e l’equiparazione degli istituti secondari in un sistema unico di licei, l’area d’incertezza investe moltissimi altri aspetti: la scelta della delega, l’obbligo scolastico, l’anticipo, i cicli, la formazione professionale.
Il metodo scelto dal governo: la legge delega potrebbe portare ad un abbraccio pericoloso tra riforme del sistema scolastico e maggioranze di governo, così che, un po’ come avviene alla Rai, ad ogni cambio di coalizione occorrerà procedere a modificare il sistema dell’istruzione. Cercare di determinare nella mediazione politica ciò che è più valido per l’istruzione e per la ricerca, non deve apparire, a mio giudizio, come un «inciucio», bensì come una responsabilità d’interesse nazionale. L’art. 2 comma 1 b della legge delega ribadisce che «è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età». Di fatto, scompare il termine obbligo, previsto nell’art. 34 della Costituzione: «L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»; è invece presente il concetto di «diritto all’istruzione». Il passaggio implica, come scrive il Gruppo ristretto di Lavoro: «l’eccezionale condizione di una società civile nella quale le famiglie e i soggetti agirebbero per il bene comune individuale e collettivo in nome dell’autonomia, della libertà, della responsabilità e dell’autogoverno, e non più per la deterrenza più o meno persuasiva della legge». Ma qui bisognerebbe sondare le ragioni che portarono all’obbligo. Resta da chiedersi se l’Italia possa permettersi di superare la concezione della scuola come «coscrizione obbligatoria», per introdurne una più moderna. Ciò in considerazione degli ancora alti livelli di dispersione scolastica e del fatto che molti comuni offrono servizi di trasporto e mensa scolastica sulla base dell’obbligo costituzionale, ben più prescrittivo del diritto-dovere. La prudenza dei padri costituenti aveva, infatti, suggerito di introdurre nella Carta fondativa della Repubblica solo quei diritti che avrebbero poi trovato la possibile traduzione sul terreno pratico-legislativo. Da questo punto di vista, il disegno di riforma appare debole in quanto al positivo innalzamento complessivo dei livelli d’istruzione non corrisponde un esplicito e quantificabile intervento a sostegno delle famiglie, degli studenti e soprattutto dei docenti. Spetterà infatti a questi ultimi motivare quegli adolescenti che, volenti o nolenti, saranno invitati a frequentare la scuola o altre agenzie formative, per tempi più lunghi. Si pone infine una questione di principio: mentre il concetto di obbligo, pur nella sua rigidità «napoleonica e carceraria» – per usare la colorita espressione del professor Giuseppe Bertagna – , determina con chiarezza l’effettiva uguaglianza delle opportunità formative, il diritto all’istruzione e alla formazione, prefigura due canali (istruzione e formazione) largamente da verificare sul piano della loro effettiva equipollenza.
Appare apprezzabile la volontà di assicurare la «generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia» (art. 2 comma 1 e), ma non risulta adeguatamente giustificata, sul piano pedagogico, la possibilità di anticipare l’iscrizione alla stessa «per le bambine e i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento». La facoltà di anticipare di circa mezzo anno l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e a quella primaria, con evidenti conseguenze nell’ingresso e nell’uscita dei diversi ordini scolastici, costituisce un discutibile compromesso tra il rispetto direttive comunitarie – favorevoli alla conclusione dell’istruzione secondaria a 18 anni – e le pressioni per il mantenimento della durata quinquennale dei licei. Su questo punto e sulle sue implicanze in termini di organizzazione della scuola, predisposizione del curricolo, profilo educativo dei diversi ordini dell’istruzione sembra opportuno l’avvio di maggiore confronto nell’opinione pubblica.
Il progetto governativo, dando un chiaro segnale di distacco rispetto a quanto prefigurato dalla riforma precedente, prevede la salvaguardia della specificità dell’istruzione elementare e di quella destinata ai preadolescenti (scuola media). Il DDL, inoltre, articola la prima secondo il modello 1+2+2, cioè si ribadisce la separatezza della scuola primaria rispetto alla scuola secondaria di I grado, benché, sul piano formale, entrambe vengano considerate facenti capo al medesimo ciclo ottennale. Resta così irrisolto il nodo del raccordo tra scuola elementare e media, con tutte le questioni connesse al tema della continuità verticale tra i due ordini. Ciò contraddice la costituzione, negli ultimi anni, di istituti comprensivi (materna, elementare, media) con un’unica dirigenza e le sperimentazioni condotte per integrare i diversi sistemi. L’ordinamento dell’istruzione secondaria inferiore (dagli 11 ai 14 anni) strenuamente difeso, soprattutto di fronte all’ipotesi della creazione della scuola di base unica prevista dalla riforma Berlinguer, costituisce un tassello problematico nel quadro del sistema scolastico italiano. E’ proprio nel raccordo interno al primo ciclo che si registrano i primi abbandoni e le prime forme di dispersione scolastica. Del resto, il passaggio dalla scuola elementare a quella secondaria inferiore segna generalmente la brusca accelerazione dalla prima alfabetizzazione culturale, tipica della formazione dai 6 agli 11 anni, a forme, talvolta molto spinte, di netto disciplinarismo. Da ultimo, la scelta, per certi versi decisiva della propria biografia personale, dell’orientamento scolastico, nel modello prefigurato dalla proposta Moratti, viene a coincidere con la conclusione dell’istruzione secondaria inferiore, cioè in una fase particolarmente delicata dell’evoluzione psicologica del pre-adolescente e non al termine del biennio secondario superiore, come invece auspicato dalla legge 30/2000.
La legge delega, anziché modificare l’articolazione interna al tassello istruzione primaria e media, investe molto sulla costituzione – per usare le parole del ministro – di un percorso graduale e continuo di istruzione/formazione professionale «parallelo a quello dell’istruzione secondaria e superiore». Si vorrebbe dare pari dignità al sistema dei licei e alla formazione al lavoro (scelta che condivido e ritengo di enorme portata per la storia della scuola italiana), ma si imbocca una strada quanto meno originale, cioè quella di prevedere «due canali diversi per durata (5 anni il sistema dei licei e quattro più uno facoltativo per l’istruzione formazione professionale)». La riforma Berlinguer stabiliva che al termine della scuola di base gli studenti si sarebbero iscritti ai licei quinquennali. La scelta dell’area di studio sarebbe avvenuta all’interno di tre macro aree (classico umanistica, scientifica e tecnologica, artistica e musicale) all’età di 13 anni, ma i canali sarebbero stati fortemente permeabili, almeno nel biennio. Non così appare per la riforma prospettata da Letizia Moratti, perché, come è stato autorevolmente spiegato, i due percorsi sono diversi per durata e «per la natura di programmi disciplinari» . Tant’è che nello stesso schema ministeriale, consultabile sul sito internet www.istruzione.it, si mostra, contraddicendo il testo della delega, che esiste un canale di accesso dai licei alla formazione professionale, ma non viceversa! (lapsus freudiano o constatazione di ciò che avviene nella prassi: «passerelle» sempre in discesa e mai in salita)?
Si discute molto e, opportunamente, della necessità di non trascurare l’enorme massa di studenti che si avviano precocemente al lavoro, oppure che vengono bocciati nelle scuole superiori, che si dimostrano poco rispondenti agli interessi degli adolescenti e alle richieste del mondo imprenditoriale. Se occorre aprire gli occhi su questa realtà e riflettere sulla necessità di una differenziazione dei percorsi formativi, è necessario però evitare la scorciatoia di pensare canali di mera qualificazione professionale che, presto o tardi, si riveleranno contenitori destinati alla preparazione dei soli giovani appartenenti ai ceti popolari.
E’ difficile scommettere sulla tenuta e sulla capacità di riforma dell’attuale maggioranza, c’è il rischio che anche quella dell’istruzione sia una riforma mediatica, apprezzata dall’opinione pubblica, poco propensa all’approfondimento, proprio perché riforma non ancora sperimentata in tutti i suoi effetti sulla pelle degli italiani. Ma c’è anche il pericolo che accanto ad una trasformazione non ancora attuata si costruisca una sterile opposizione che anziché pretendere di «vedere» le carte in mano agli avversari, mostrandone le molte contraddizioni, si ostini a sostenere che il mazzo è truccato. Guardo sempre con sospetto questa che mi pare una cattiva tattica, anche perché invocare al complotto suona indirettamente come la conservazione di vecchi paradigmi: difesa ad oltranza delle conquiste degli anni Settanta e Ottanta, egualitarismo e esasperazione delle rivendicazioni sindacali della categoria docente, sospetti nei confronti dell’autonomia didattica e organizzativa dei singoli istituti, chiusura verso tutte le forme di dialettica tra pubblico e privato.
E’ forse anche ora di abbattere qualche tabù della sinistra. E’ legittimo criticare il tempo pieno nella scuola elementare, se questo, anziché essere un’occasione per una didattica di ricerca diventa una dilatazione a quaranta ore della scuola tradizionale, con tante discipline non dialoganti tra loro? Ci si può impegnare nei settori border line (istruzione di base, integrazione del disagio, formazione professionale) avendo a cuore anche l’alta formazione? Si può difendere il numero chiuso nelle università, senza per questo sostenere lauree d’élite?
Ciò che dovrebbe interrogare tutti gli italiani, e in misura maggiore la coscienza cristiana, è infine il constatare la disaffezione della società e delle famiglie nei confronti della scuola. Occorre registrare una grave carenza, anche nell’opinione pubblica e nei media, che insistono moltissimo nella «pedagogia del consumatore attento» (un segnale allarmante in questo senso è l’introduzione nel curricolo di nuove educazioni: stradale, sessuale, alimentare), mentre non si preoccupano di aiutare ad approfondire, documentare, riflettere, ricordare. Così l’ultima e forse l’unica ideologia rimasta, quella del mercato, che attribuisce il valore delle cose in base alla loro resa economica e produttiva, la fa da padrona anche nelle aule scolastiche. Gli insegnanti piuttosto di trasmettere il sapere – sapore della cultura e di occupare il loro tempo nello studio, sono ormai catturati dalla stesura di progetti, dalle richieste di fondi, dalle certificazioni di qualità. Innovazioni semantiche, queste ultime, che dimostrano come gli obiettivi educativi passino ormai per strade diverse rispetto allo studio, alla comunicazione e al dialogo tra docente, alunno, famiglia. Affermare il primato dei rapporti umani e dello studio, rispetto agli obblighi di programmazione e di perseguimento degli obiettivi pianificati, non è tornare al passato, ma anzi un modo originale e controcorrente per costruire il nostro futuro.
La vera riforma del ministro Brichetto
Giuseppe Bonelli
Un insegnante affronta il cambiamento
Giuseppe Dallai
Valore della vita e pianificazioni belliche
Alberto Guariso
Il declino della concertazione. A dieci anni dall’accordo sulla politica dei redditi
Gianni Italia
La destra cattolica radicale
Lorenzo Gaiani
Libri: Aver cura della vita
Marcella Filippa