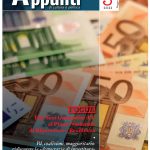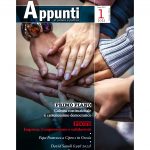Appunti 1_2003
Sommario
La crisi internazionale: angosce, speranze, impegni Inaspettatamente, l’Onu ha ritrovato le proprie funzioni Diciamo la verità: noi impenitenti sostenitori di una organizzazione internazionale multilaterale e giuridicamente organizzata, eravamo reduci da molte delusioni. Le ultime occasioni di rilevanti crisi internazionali – almeno a partire dal 1992 e dal fallimento dell’operazione somala e di quella jugoslava – avevano visto l’Onu sostanzialmente marginalizzata e impotente. La vicenda bosniaca e poi quella kosovara avevano trovato una sia pur precaria soluzione con le bombe della Nato, giustificate con l’appello a una necessità di ingerenza dovuta all’emergenza umanitaria, che aveva aggirato il probabile veto russo-cinese in Consiglio di sicurezza. L’intervento americano in Afghanistan dopo l’11 settembre è stato gestito sulla base di uno stiracchiato diretto richiamo al diritto di legittima difesa (secondo l’art. 51 della carta dell’Onu), peraltro con l’amplissimo sostegno delle massime potenze del pianeta, tanto da far apparire la nuova «grande coalizione» antiterroristica un fatto che spazzava via tutte le remore del post-guerra fredda. La superpotenza militare rischia l’isolamento politico L’Amministrazione Bush vive giorni di chiara difficoltà. Sono partiti con anticipo e decisione, mascherando appena, dietro alle risibili accuse all’Iraq di detenere armi di sterminio, la propria determinazione a fare un passo avanti in una strategia imperiale. L’obiettivo di «cacciare il satrapo di Baghdad» è il primo passo di una volontà di rifare direttamente il Medio oriente a propria immagine, dato l’intatto valore strategico della zona e date le delusioni della precedente scelta di appoggiarsi su regimi «clienti» locali. Troppe volte gli alleati scelti si sono rivelati infidi: soprattutto, la dinastia saudita – pilastro quarantennale di un ordine regionale nonostante il volto interno poco presentabile – appare ormai agli occhi americani troppo levantinamente ammanicata con le centrali del terrore islamista. Un nuovo dispiegamento di forza avrebbe così avviato una ristrutturazione profonda dell’area, secondo i «falchi» che guidano il governo americano. L’Europa s’è sciolta Non era imprevedibile la rottura sulla questione irachena tra i maggiori paesi dell’Unione europea. Rottura sanzionata dal documento degli otto paesi schierati con Bush, soltanto pietosamente coperta dalla dichiarazione del consiglio europeo di Bruxelles del 17 febbraio, che invocava la centralità dell’Onu e il disarmo iracheno, affermando di privilegiare modalità pacifiche per ottenere questo obiettivo. Subito dopo, infatti, l’unanimismo di facciata si è rotto di nuovo. I media americani insistono impietosamente sulla divaricazione tra la «vecchia Europa» franco-tedesca, e l’Europa «atlantica» che sarebbe raccolta attorno a Gran Bretagna, Spagna e Italia. In realtà, questa rottura ha un aspetto non sorprendente, dovuto all’assenza di una storia specifica dell’Unione come soggetto di politica internazionale. L’integrazione è sorta come strumento di difesa, allargamento e sviluppo delle sovranità nazionali, più che come costruzione di un nuovo orizzonte politico comune. Per cui, al momento della verità, i percorsi politici dei maggiori paesi europei si sono regolarmente divaricati, inseguendo ciascun paese un proprio posto al sole, nella miope illusione di poter contare da soli. La sensibilità per la pace è una realtà C’è però un soggetto nuovo sulla scena internazionale: dopo le grandi manifestazioni simultanee del 15 febbraio il «New York Times» ha parlato dell’opinione pubblica pacifista internazionale come l’unica altra superpotenza affiancabile agli Stati Uniti. Il mondo globale comincia a funzionare anche a vantaggio dei movimenti che invocano una svolta politica nella gestione dei problemi della guerra. La rete di iniziative, sorta con convergenze spontanee e molta auto-organizzazione, sta esprimendo un potenziale inedito. Si tratta di una evoluzione fondamentale, difficilmente sottovalutabile. Tanto che molti degli stessi statisti democratici dell’Occidente vacillano di fronte alla chiara manifestazione dell’esiguità del consenso che ricevono le posizioni più aperte allo sbocco militare della crisi. E checché ne dica lord Dahrendorf in una incauta incensazione di Blair apparsa su «la Repubblica», questo dissenso è un dato politico esigente e pesante. Che sa anche come farsi valere. Occorre un rilancio progettuale e politico E di approfondire c’è senz’altro bisogno. Non ci possiamo sottrarre a questa impressione: che nell’attuale mobilitazione per la pace ci sia anche qualcosa di ancora problematico e immaturo, che occorrerebbe affrontare di petto. Il rapporto tra sensibilità pacifista e canali della politica è ancora parziale, contraddittorio, interrotto. Sarebbe lungo andare a discernere responsabilità e ragioni di tutto ciò. Ma va registrato un punto di sofferenza: possibile che non si riesca a tradurre in lungimiranti e responsabili posizioni politiche – che dovrebbero appunto tentar di ricucire la forza e il diritto – tanta mobilitazione genuina, tante istanze critiche, tante esigenze di partecipazione? Possibile che la politica non si faccia interrogare a fondo da questa spinta collettiva? Eppure, se la ricerca della pace non fa i conti con la politica e le sue limitazioni, non faremo molti passi avanti.
Guido Formigoni Leggi tutto
La vicenda della determinazione americana a farla finita con il regime di Saddam Hussein e a punire l’Iraq per le sue attività da «Stato canaglia» è stata invece fin dall’inizio gestita diversamente. La presenza di forti prudenze e poi via via di opposizioni tra le maggiori potenze, unita alle pressioni europee e alle stesse esigenze della risvegliata opinione pubblica americana, hanno fatto scegliere di instradare il problema nella procedura dell’Onu. E una volta iniziato questo percorso, l’Amministrazione Bush ha ottenuto tutt’altro che un semplice percorso di legittimazione delle proprie posizioni. Dopo la risoluzione 1441 del novembre 2002 sul disarmo dell’Iraq e sul rilancio delle attività ispettive (languenti dopo anni di rigidi controlli), la volontà americana di alzare il tiro e di chiedere una seconda risoluzione che autorizzasse il ricorso alle armi è stata bloccata: sono mancati i voti favorevoli per ottenere la maggioranza in Consiglio di sicurezza e ancor più, si è delineata un’insolita posizione rigida di Francia, Russia (e forse anche Cina), giunta fino all’esplicito annuncio della disponibilità a ricorrere al diritto di veto.
Insomma, di fronte a una questione controversa, l’organizzazione internazionale in difficoltà è tornata a funzionare esattamente come le si chiederebbe: come camera di compensazione diplomatica e quindi organismo di controllo delle crisi. Almeno questo, se non ancora quello che auspicherebbero tutti gli internazionalisti fiduciosi nel diritto: che si realizzi quella sostanziale promessa della Carta del 1945 per cui il rifiuto della guerra nella comunità internazionale si tramuti realmente in un sistema di conferimento comune della forza a un organismo sopra le parti che sia capace di controllare e reprimere le aggressioni e le minacce ai diritti umani. Certo, se gli Stati Uniti e i più stretti alleati dovessero dar via a una guerra senza l’autorizzazione dell’Onu, sarebbe un grave colpo per l’organismo internazionale, ma più che l’Onu ne soffrirebbe probabilmente la posizione internazionale americana: si tratterebbe chiaramente di una sottrazione unilaterale alla procedura giuridica delle Nazioni unite, molto più esplicita e palese che nel recente passato, tanto da creare una condizione del tutto particolare per Washington.
E’ curioso che di fronte a questa nuova funzionalità, nel dibattito politico italiano ci sia chi abbia anticipato una posizione addirittura più realista del re: dobbiamo stare comunque con l’Onu. Il sottinteso era chiaro: ci si attendeva che alla fine gli Stati Uniti avrebbero ottenuto il richiesto via-libera giuridico per le operazioni militari. Così non è stato. E quindi molti di quei sostenitori occasionali dell’Onu ora vacillano. Penso invece che proprio per aiutare questa nuova (e incerta e fragile) autonomia dell’organizzazione, occorra un’opinione pubblica internazionale pronta a dire chiaro e forte quello che pensa. Anche eventualmente a criticare le procedure e le realizzazioni dell’Onu, proprio per dar maggior forza alle sue modalità operative più coerenti con la Carta fondativa e le attese di un ordine internazionale più giusto. Per ora, comunque, l’organizzazione ha funzionato: teniamocela stretta, pur con tutte le sue insufficienze.
I problemi di questa strategia sono però due: in primo luogo è irrealizzabile e in seconda istanza crea crescenti antagonismi. Da una parte, infatti, non si vede come una sola potenza, seppure di gran lunga unica vera potenza militare dotata di mezzi soverchianti, possa controllare e governare da sola ogni angolo del globo, costruendo soluzioni politiche a lei gradite di segno democratico. E’ un overstretching – come dicono gli americani, una eccessiva estensione – addirittura inimmaginabile. Si traduce quindi in una posizione necessariamente sottoposta alla sgradevole necessità di scegliere le priorità. E allora perché oggi è decisivo democratizzare a suon di bombe l’Iraq mentre si può blandire la Corea del Nord del tirannello comunista ? Perché si può tollerare il fatto che le risoluzioni dell’Onu siano disattese da Israele e invece si devono adempiere fino all’ultima virgola da parte dell’Iraq? Come imporre la democrazia in contesti che appaiono al momento refrattari? Sono contraddizioni insanabili, che creano per forza reazioni di sconcerto e di opposizione. La superpotenza se ne accorge: ha voluto porre l’agenda della crisi e si è ritrovata politicamente isolata quanto mai era successo in questi anni: tranne un riluttante Blair in nome della special relationship, gli sgambettanti Aznar e Berlusconi, e una pletora di paesi di seconda fila dell’Europa dell’Est, tutti gli altri hanno fatto dietrofront. Non si tratta di osannare le ragioni delle scelte critiche di Chirac o di Schroeder, ma di registrare che la maldestra operazione politica americana ha spezzato la «grande alleanza» antiterrorista, ha allargato l’Atlantico oltre ogni limite immaginabile solo qualche anno fa, ha riallontanato molti governi del Terzo Mondo. Ogni strategia imperiale saggia deve ricomprendere in sé le ragioni di un numero consistente di soggetti, se non vuole rendere antagonista la periferia dell’impero. Di questo non c’è traccia nella sicumera operativa della cerchia di Bush.
Ora, di fronte a un’opzione militare incombente, da condurre senza l’autorizzazione dell’Onu, Washington non avrà particolari difficoltà contro l’inesistente nemico militare iracheno. Ma comincerà a trovare ostacoli crescenti per completare la sua strategia nei passi successivi alla vittoria militare. I contraccolpi di una guerra unilaterale potrebbero essere drammatici. Già adesso ambienti vicini all’Amministrazione parlano dell’opportunità di coinvolgere nuovamente l’Onu nella ricostruzione politica ed economica del paese, una volta cacciato Saddam. Curiosa visione dell’organizzazione internazionale, come forma di tutela a posteriori delle popolazioni, una volta esercitata la volontà del più forte. Curiosa forma di socializzazione dei costi delle operazioni imperiali, la cui gestione è rigidamente privata.
Aggrava il quadro la motivazione dell’attuale spaccatura. Nel caso della Gran Bretagna siamo solo di fronte a una pedante interpretazione blairiana di un tema storico della posizione internazionale inglese, sempre orientata a costruire l’anello di congiunzione – o il metro della distanza – tra Stati Uniti ed Europa. Nel caso della Francia, assistiamo a un gollismo di ritorno da parte di Chirac, che accoppia l’idea dell’autonomia europea alla visibilità di posizioni di guida francesi. Ben più fragili, contrassegnate da scarse radici storiche e da deboli prospettazioni di interesse nazionale appaiono le motivazioni politiche delle scelte degli altri paesi. Non merita più di una parola l’ondivaga e opportunistica linea del governo italiano. Ragioni di schieramento interno, tatticismi e piccoli opportunismi prevalgono sulle grandi prospettive del discorso europeo.
Il quadro è così ulteriormente autodistruttivo, rispetto alle enormi potenzialità internazionali che potrebbe avere un’Unione rinsaldata nelle sue strutture economico-finanziarie dalla moneta unica. Nessuno statista e nessun paese intende invece assumersi seriamente il ruolo di mediazione interna, prospettando un grande disegno di responsabilità e impegno comune verso le sorti del pianeta. E in queste condizioni, la sola ipotesi del prossimo allargamento non potrà che diluire ulteriormente ogni ruolo europeo comune sulla scena del mondo. Questione seria, questa: forse la più drammatica per chi pensa possibile riequilibrare la scena internazionale oltre l’unilateralismo degli Stati Uniti.
In questa diffusione di una sensibilità ampia attorno al valore minacciato della pace mi sembrano dati importanti sia l’ampiezza della mobilitazione (per molti versi inedita: stiamo assistendo una svolta rispetto all’età del disimpegno e dell’individualismo?), sia la crescente maturità delle forme ideali e politiche di manifestazione della protesta. C’è un concretismo che non indulge troppo né a vecchi schemi antagonisti né a nuove posizioni apocalittiche. La riscoperta del simbolo capitiniano della bandiera della pace arcobaleno è in questa direzione un segnale confortante di superamento di angusti limiti concettuali e di obsolete divisioni, in una sorta di comune lotta di civiltà condotta da diversi. Ma possibile che non dica niente l’impressionante unanimità e coincidenza di posizioni nella Chiesa cattolica contro questa guerra, come non si registrava da anni tra sensibilità anche molto diversificate (dal papa alla «Civiltà cattolica» a Pax Christi, dagli episcopati nazionali ai movimenti di ogni colore)?
Ci sono stati anche in questo caso critici ed ipercritici: ma come non vedere che la nettezza delle posizioni su cui i movimenti si sono espressi (no a questa guerra «senza se e senza ma») è stato esattamente uno dei motivi del successo della mobilitazione? Senza implicare discorsi ipotetici e spaccature in quattro del capello ideologico tra pacifisti ad oltranza e pacifici moderati, tra sostenitori del diritto umanitario e critici dell’imperialismo americano. Intanto, un punto fermo: no a questa guerra, a queste condizioni. Poi approfondiremo il discorso.
Forse ancora più profondo è il discorso culturale. Giungiamo come sempre al punto dolente. Per costruire sintesi politiche, occorre uno sforzo molto maggiore sul piano intellettuale. Occorre formulare una prospettiva credibile di riduzione della violenza e di avvicinamento del traguardo ideale della pace nella giustizia: attraverso un severo tirocinio di realismo (studiare nel concreto e nel profondo gli ostacoli alla pace e i suoi avversari, senza giudizi schematici ed abborracciati), creatività (valorizzare in un quadro complessivo quanto si è sperimentato e costruito sul terreno delle forme nonviolente di controllo dei conflitti e di soluzione delle crisi, riconnettere sempre azione istituzionale e azione informale), responsabilità (indicare vie che consentano di tenere insieme il massimo delle esigenze e delle priorità), senso del limite e del provvisorio. Passione e discernimento, insomma, che si devono trovare di nuovo uniti. Solo allora tutti gli amanti della pace nel mondo potranno diventare «costruttori di pace», e si realizzerà l’aspettativa per cui l’agenda della politica potrà essere istruita dalle istanze pacifiche, che si riscatteranno dalla loro apparente condanna di essere solo forze reattive, di protesta e critica nei confronti delle decisioni dei «signori della guerra». Riprendere in mano le fila di questo lavoro chiede uno sforzo collettivo di dimensioni inaudite. Ma la crisi attuale è rivelatrice proprio perché chiede questa radicalità, non di meno.
Democrazia e decisioni urbanistiche
Achille Ardigò
La riforma fiscale Tremonti I caratteri della riforma Tremonti Su cosa interviene la riforma fiscale di Tremonti, quali sono le modifiche introdotte? Nella Finanziaria 2003, seguendo lo schema sopra indicato, le modifiche riguardano gli oneri deducibili, le aliquote e detrazioni d’imposta. In pratica viene introdotta una «deduzione» di 3.000 euro che riguarda tutti i redditi, aumentata fino a 7.500 Euro per i lavoratori dipendenti, a 7.000 euro per i pensionati, a 4.500 euro per i lavoratori autonomi. Attraverso un calcolo, abbastanza complesso, deve essere determinata la quota di questa deduzione che spetta ad ogni contribuente, sulla base del proprio reddito complessivo. L’effetto di questa deduzione aggiuntiva è quello di abbattere il reddito imponibile, con una diminuzione delle imposte: con la Finanziaria si prevede che le deduzioni abbiano effetto fino a un reddito di 25.000 euro. Possibili effetti ed elementi critici La valutazione dell’insieme di questi provvedimenti deve essere duplice: da un lato bisogna comprenderne gli effetti concreti, dall’altro deve essere collegata al complessivo processo di riforma fiscale. Indubbiamente i contribuenti che hanno un reddito compreso tra gli 8.000 e i 20.000 euro avranno un effettivo risparmio di imposte, che andrà decrescendo avvicinandosi ai 25.000 euro: in termini percentuali, la diminuzione maggiore sarà a 8.500 euro con un abbattimento del 6,86% (pari a 583 euro), che scende all’1,44% a 15.000 euro (215 euro), per arrivare allo 0,25% a 25.000 euro (63 euro). Viene poi innalzata la quota del reddito esente da imposte che dai 6.000 euro precedenti, arriva a 7.500 euro. Prospettive e rischi di medio periodo: il futuro del welfare state e la logica dei condoni A questo punto è necessario allargare l’orizzonte, passando dai contenuti della finanziaria 2003, al tentativo di comprendere quello che potrebbe o dovrebbe essere il risultato finale, alla luce anche delle ripetute affermazioni del Ministro Tremonti sulla volontà di proseguire nel processo di riforma. Ci soffermiamo brevemente su quattro punti. Come afferma la delega fiscale, la progressività della imposizione fiscale, in presenza di due sole aliquote, sarà affidata alle deduzioni: queste, oltre a quelle collegate al lavoro, riguarderanno «famiglia, casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza» e contributi vari a enti no profit o simili; inoltre saranno concentrate «sui redditi bassi e medi». Partendo dai problemi collegati alla sperimentazione delle deduzioni previste dal 2003, e prevedendo che esse dovranno, sia pure in modo diversificato, riguardare i redditi che arrivano fino a 100.000 Euro (soglia dell’aliquota al 23%), la prima impressione immediata è quella di una notevole complessità, a rischio, ancora una volta, della chiarezza, semplicità e conoscibilità. I dilemmi della redistribuzione fiscale L’ultimo aspetto, contenuto, in particolare nella Finanziaria, è la previsione di una redistribuzione delle risorse derivanti dalle imposte, tenendo conto del territorio dove sono state prodotte: il riferimento attualmente è al reddito ai fini Irpeg, quindi per le imprese-società di capitali, ma appare diffusa la volontà di ampliare questa previsione. Anche in questo caso è importante fare attenzione agli effetti di queste decisioni: in pratica una distribuzione delle risorse che non tenga presenti i necessari meccanismi solidali tra le diverse realtà del nostro paese, avrà effetti sulla effettiva cittadinanza, per cui in alcuni territori – regioni saranno garantiti alcuni servizi, in altri no; ed inoltre potrebbe scatenarsi una competizione, non proprio nobile, per accaparrarsi le fonti di produzioni del reddito, leggasi le imprese, al di fuori di ogni progetto di sviluppo. Questo che viene presentato come federalismo, è tutt’altra cosa; ma nemmeno la «compartecipazione» alle imposte, previste in finanziaria è il federalismo. Per semplificare, dato che continuerà ad essere lo Stato a decidere le aliquote dell’Irpef, dell’Irpeg, dell’Iva, e così via, il governo continuerà a decidere le «dimensioni della torta»: la compartecipazione, per regioni e gli enti locali, si tradurrà in una discussione, che potrebbe non essere amichevole, per accaparrarsi la fetta più grossa.
Fulvio ColomboLeggi tutto
Per favorire un confronto chiaro, è importante partire dall’attuale sistema fiscale, e quindi dal percorso che porta alla determinazione dell’imposta che ogni contribuente deve versare.
Ogni persona/cittadino deve determinare:
1) Il proprio reddito complessivo, che rappresenta la somma di tutti i redditi soggetti a imposizione fiscale (redditi da lavoro e pensione, immobiliari esclusa la casa dove si abita, redditi finanziari), a questo reddito vanno sottratti alcuni
2) Oneri deducibili, che di fatto riducono l’importo del reddito complessivo (spese mediche per disabili, assegni al coniuge in caso di separazione, contributi previdenziali dovuti per legge, contributi a Ong o alla Chiesa cattolica) permettendo così di individuare il
3) Reddito imponibile; su questo reddito, in base a un meccanismo progressivo che comporta una maggiore imposizione fiscale al crescere del reddito, si applicano diverse
4) Aliquote, sulla base delle quali viene individuata
5) l’Imposta lorda; dalla imposta lorda vengono tolti-detratti alcuni importi, le
6) Detrazioni d’imposta, che sono legati alle proprie situazioni reddituali (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo), alla situazione familiare, ad alcune spese (soprattutto mediche) da calcolare in percentuale, normalmente il 19%; si ottiene così la
7) Imposta netta, che rappresenterebbe l’importo da versare allo Stato, salvo che per le persone che hanno
8) Ritenute alla fonte, che devono essere sottratte all’imposta netta; la differenza, positiva o negativa, rappresenta l’importo effettivo da versare o di cui si chiede il rimborso.
Dopo questa lunga premessa tecnico-metodologica, due ulteriori precisazioni. Il fisco non è un sistema perfetto, non è pura teoria: è invece uno strumento attraverso il quale ogni cittadino in base alla propria capacità contributiva, partecipa alle spese pubbliche necessarie per rendere reale e garantita la sua cittadinanza. Quindi ogni riforma fiscale, prima di essere una scelta tecnica, rappresenta una scelta politica, perché con una riforma si decide cosa, come, in che quantità, deve essere garantito ad ogni cittadino. La seconda precisazione, che è conseguente, riguarda la natura di un sistema fiscale perché sia accettabile e trasparente: ogni cittadino deve sapere, a priori, quante imposte deve versare sulla base di un dato reddito; a chi sono destinate queste imposte; per cosa saranno utilizzate queste risorse.
Il secondo intervento riguarda le aliquote: rimangono cinque ma le prime tre cambiano. La prima aliquota sale al 23%, ma vale per i redditi fino a 15.000 euro (rispetto al 18% fino a 10.329 euro); la seconda è del 29% fino a 29.000 euro, contro il 24% fino a 15.500 euro circa, la terza è del 31% fino a 32.600 euro, rispetto al precedente 32% valido fino a circa 31.000 euro.
La terza modifica è sulle detrazioni d’imposta: sono cancellate quelle per le spese di produzione del reddito, di fatto sostituite dalle nuove deduzioni; vengono rimodulate alcune detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi per evitare che il nuovo meccanismo risulti penalizzante.
A questi dati positivi si affiancano alcuni rilievi critici. Prima di tutto la complessità del calcolo, come già richiamato, che permette di individuare la quota di deduzione spettante: è addirittura previsto che si possa utilizzare il precedente sistema se più favorevole, il che, oltre a costringere di fatto ad un doppio calcolo, desta molte perplessità, perché dimostra che alla riforma Tremonti vengono a mancare proprio i presupposti di «chiarezza, semplicità, conoscibilità» che la dovrebbero caratterizzare.
Motivo di questa situazione è proprio la natura degli interventi previsti: modificare contemporaneamente oneri deducibili, detrazioni e aliquote, comporta inevitabilmente l’impossibilità pratica di controllare precisamente tutti gli effetti. Per dimostrare questa affermazione, basta considerare che per un lavoratore dipendente a 15.000 euro il risparmio di imposta previsto sarà di 215 euro (1,44%), a 16.000 salirà a 251 (1,57%), a 17.000 sarà di 275 euro (1,62%), a 18.000 euro di 299 (1,66%), ed infine a 19.000 euro sarà di 322 euro (1,70%), prima di ritornare a scendere: in pratica si creerà un meccanismo inverso, per cui in questa fascia di reddito il risparmio di imposta crescerà, anziché diminuire, con l’aumento del reddito. Questo non è dovuto ad una volontà precisa del legislatore, ma proprio al mescolarsi degli interventi, il che fa nascere una domanda: visto che l’obiettivo dichiarato nel Patto per l’Italia era quello di una diminuzione dell’IRPEF per lavoratori dipendenti e pensionati pari a 5,5 miliardi di Euro, non era più «semplice» intervenire unicamente sugli oneri deducibili aggiuntivi in alternativa alle detrazioni, lasciando invariate le aliquote? Per rispondere a questa domanda bisogna rifarsi al processo complessivo di riforma fiscale: prima però altre due annotazioni critiche.
Per un motivo non comprensibile, la deduzione massima per i pensionati è stata fissata in 7.000 euro: come conseguenza, a parità di reddito, un pensionato verserà più imposte (una media di 100 euro in più) raggiungendo il pareggio con i lavoratori dipendenti attorno a un reddito di 30.000 euro. Altro rilievo critico riguarda da un lato l’impegno, contenuto sia nel Patto per l’Italia che nella delega, a favore di interventi fiscali a sostegno della famiglia, di cui attualmente non esiste traccia; dall’altro, impegno preso e anch’esso non soddisfatto a risolvere il problema della cosiddetta «incapienza». In pratica, una persona che ha un reddito di 7.500 euro è esente da imposte: soprattutto se si tratta di un anziano, è probabile che questa persona debba sostenere delle spese mediche che non sarà in grado di recuperare, sia pur parzialmente, proprio perché non soggetto a ritenute. Questo problema si aggrava nel caso di carichi familiari, perché le relative detrazioni innalzano la soglia dall’incapienza.
Passando ora alla seconda valutazione, possiamo tranquillamente affermare che la riforma fiscale contenuta in finanziaria è decisamente inserita nel quadro più complessivo della delega fiscale. Quest’ultima infatti prevede la «progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzione», con una articolazione tra cui rientrano i «costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro»: le deduzioni aggiuntive, fino a 7.500 Euro, sono la prima concreta attuazione di questo progetto. Altro obiettivo della delega fiscale è la riduzione a due sole aliquote per le imposte sul reddito, di cui la prima sarà del 23% fino a un reddito di 100.000 euro: la modifica delle precedenti aliquote, introducendo come prima nuova aliquota proprio il 23%, ha quindi un significato preciso. Se questo è il disegno complessivo, è comprensibile perché siano state messe nel conto tutte le contraddizioni sopra elencate: sono il prezzo da pagare per raggiungere l’obiettivo finale.
Inoltre se con questo sistema si punta a ridurre la pressione fiscale, quale sarà il costo finale di questa operazione? Non ci sono dubbi sul fatto che tutti i cittadini, almeno quelli che pagano le tasse, siano d’accordo per una loro riduzione: bisognerebbe anche spiegare loro cosa succederà dei servizi (sanità, sociale, istruzione, previdenza) che vengono finanziati con le imposte. I riferimenti previsti per le nuove deduzioni potrebbero far pensare che alcune prestazioni, ad esempio quelle sanitarie, oggi fornite a tutti i cittadini in quanto la salute è ritenuta un diritto universale da garantire, diventeranno spese da sostenere e poi da recuperare come deduzioni. Se così fosse, il problema non sarebbe tecnico o fiscale, ma politico, perché si creerebbero inevitabilmente delle diseguaglianze e si modificherebbe radicalmente, senza dirlo chiaramente, l’attuale modello di stato sociale, sicuramente da riformare ma non da demolire.
Una conferma in questa direzione, ed è il secondo punto, sono i condoni, che definiamo come «di tutto, di più»: al di là della loro inaccettabilità in termini etici e della loro ingiustificabilità (ne usufruiranno soprattutto i contribuenti che non saranno toccati dalle modifiche previste in finanziaria!!!), saranno la fonte, anche se non sicura al 100%, degli 8 miliardi di euro necessari per la riduzione delle imposte. Come sarà finanziata questa riduzione della pressione fiscale, che dovrebbe ampliarsi, negli anni successivi? Non essendo possibile prevedere ulteriori condoni, l’unica cosa che risulta possibile è una riduzione delle spese, e quindi interventi su sanità, sociale, formazione, previdenza, pubblico impiego!
Il terzo punto riguarda invece le imprese: anche per loro è previsto un abbattimento dell’imposizione fiscale, tramite primi interventi su Irpeg e Irap. Gli sconti fiscali per le imprese sono il 25% di quelli per lavoratori dipendenti e pensionati: la previsione di ulteriori interventi in questa direzione, comporterà inevitabilmente ulteriori buchi.
Per concludere, dato che mi sembra chiaro che il giudizio complessivo sulla riforma Tremonti non possa essere positivo, ci sono tre temi, qui solo suggeriti, che dovrebbero essere invece affrontati ed approfonditi per un chiaro orientamento «federalista ma solidale» del nostro sistema fiscale.
Il primo riguarda il meccanismo di raccolta e distribuzione delle imposte: attualmente avviene a cascata dal centro alla periferia, con il risultato che il governo commissaria sempre più gli enti locali, sia sul versante delle entrate che delle spese. Un meccanismo inverso, dalla base al centro, costringerebbe tutti, ad ogni livello, a dichiarare le proprie necessità a priori; a definire i livelli di solidarietà; ad individuare una sede (il senato delle autonomie locali), dove le decisioni tecniche trovano le loro motivazioni politiche.
Il secondo aspetto riguarda la competenza nella gestione e definizione delle imposte, da legare alle competenze di tipo politico: la casa per esempio, è da ricollegare, per tutti i suoi aspetti, esclusivamente al comune, perché sarebbe il segnale evidente che la residenza in un dato luogo detta le regole dei costi e dei benefici ad essa collegati. L’ultimo riguarda la imposizione fiscale sulle imprese, ora fondamentalmente costruita sul modello delle grandi imprese: dovrebbe essere introdotta una diversificazione tra imprese di dimensioni diverse; distinto il destino fiscale dell’imprenditore da quello dell’impresa; valutata la possibilità di introdurre, sul modello Irpef, addizionali locali sulla base di una ridotta imposizione fiscale nazionale sulle imprese stesse.
Attualità del perdono sulla scena del mondo
Gianni Vaggi
Focus: Il ritorno delle riforme istituzionali
Per orientarsi nella complessità
Enzo Balboni
Il completamento della transizione
Stefano Ceccanti
Passato e futuro dei cattolici in politica
Lorenzo Santoro
Antonino Capponnetto: ricordo di un uomo giusto
Un simbolo dell’antimafia
Giancarlo Caselli
La memoria e l’impegno
Cettina Cammarata
Pinocchio, l’omino di burro e il paese dei balocchi
Silvio Mengotto
Libri: l’Unione europea tra gli scaffali
Gianni Borsa