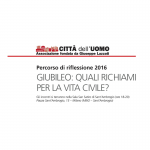Appunti 5_2002
Sommario
L’Ulivo, la pace e la guerra Nei prossimi mesi l’Ulivo sarà ancora sfidato nel compito impegnativo di consolidare la sua compattezza, sul terreno programmatico come su quello organizzativo. La dispersione dei luoghi, delle occasioni, dei soggetti (nel territorio, fra i vari interessi organizzati, nelle famiglie politiche e culturali) fra cui deve maturare questo obiettivo può essere una ricchezza, ma a condizione di fare tutti uno sforzo per costruire convergenze più che per accentuare incompatibilità. Fra i temi chiave di questa fase, sono destinati a restare importanti dal punto di vista dei contenuti la questione drammatica della pace e della guerra e, dal punto di vista del contenitore, le strutture di coordinamento e di decisione politica, cui ho già accennato nel numero precedente di questa rivista. Vorrei qui ritornare più distesamente sul primo.
Paola Gaiotti Leggi tutto
Pace e guerra: l’attualità del richiamo costituzionale
Aldilà delle diverse appartenenze storiche e ideali, dei radicamenti e delle memorie, ciò che ha accomunato l’Ulivo è l’ambizione di costruire una fase nuova della storia italiana che non cancelli ma esalti quanto di positivo è stato costruito in una dialettica non priva di convergenze forti nella storia della Repubblica, primo fra tutti il riferimento alla Costituzione come base comune del passaggio a una democrazia più piena. Questo riferimento non può non essere assunto da tutti come la ragion d’essere dell’alleanza; se l’Ulivo, così come è o allargato, fosse o fosse destinato ad essere un partito, non potrebbe che essere il partito della realizzazione piena della Costituzione repubblicana, in particolare nella sua prima parte. E questo tanto più, quanto più sia condannato ancora a trovarsi di fronte uno schieramento che, nelle forme più varie e contraddittorie (dai valori di riferimento, alla spregiudicatezza in materia giudiziaria, alla pressione scissionista, all’antieuropeismo), si muove per modificare la perentorietà del richiamo costituzionale.
E dunque è giusto che la base della concezione della politica internazionale dell’Ulivo resti fortemente ancorata al dettato costituzionale, possa o non possa essere esso, come da sempre auspicato, ispiratore di una politica bipartisan. E’ giusto dunque che, nel dibattito aperto nel centrosinistra sulle scelte drammatiche che sono di fronte a noi, sia stato evocato da più parti come criterio vincolante il richiamo all’articolo 11 della Costituzione che “ripudia la guerra come strumento di offesa… e mezzo di risoluzione delle controversie…”. Questo vincolo non può non restare, nella sua perentorietà, il punto fermo di convergenza di tutta l’alleanza, insieme segno di una cultura comune già consolidata ma anche anticipo di strategie future condivisibili.
Ma l’articolo 11, come sappiamo bene, non predica solo il rifiuto della guerra. Sarebbe stato segno di irrealismo rifiutare l’antico e barbaro ricorso alla guerra senza introdurre insieme una nuova logica di governo delle controversie internazionali. E, dunque, quel rifiuto non è separabile dal rimando alle cessioni di sovranità necessarie alla costruzione di un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuova e favorisca le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Sul piano della logica come dei principi, (stiamo ancora dicendo delle ovvietà costituzionali) no alla guerra e sì all’Onu insieme stanno e insieme cadono, non sono né separabili né distinguibili. Lo stesso significato del termine guerra ne esce più articolato e complesso; perché il no è alla guerra così come la storia degli uomini l’ha conosciuta, gestita dagli Stati nella loro logica autoreferenziale e separata; non può essere contemporaneamente no agli strumenti, tutti da inventare, di polizia internazionale volti ad assicurare pace e giustizia.
Debolezza degli strumenti del diritto internazionale
Il dramma che viviamo è che, a più di mezzo secolo dalla nascita dell’Onu e dall’approvazione della Costituzione repubblicana, non solo permane ma si aggrava lo scarto fra il disegno ambizioso di dare vita ad un’altra storia del mondo e la costruzione degli strumenti istituzionali e politici adeguati a realizzarlo. Da una parte il vincolo irrinunciabile del no alla guerra; dall’altra l’ambiguità, la fragilità, l’incompiutezza dello strumento internazionale. E si tratta di un’incompiutezza che spazia in tutti i campi. Le garanzie assicurate dalle procedure di decisione, sono insufficienti sia sul piano della rappresentatività, sia su quello dell’autonomia, sia su quello dell’efficacia; gli strumenti di intervento, ancora di fatto in mano ai singoli Stati, non solo si sono rivelati, in questi ultimi anni, ancora troppo più vicini alla vecchia logica distruttiva degli eserciti nazionali, che a quella preventiva e del minor danno delle polizie democratiche, ma sono andati risentendo, malgrado le pretese di intelligenza, dell’escalation tecnologica in forme tali da aggravarne la distruttività.
Occorre guardare in faccia il fatto che, dopo le eredità della guerra fredda, dopo il lungo stallo che ha ritardato lo sviluppo del sistema internazionale, almeno sul piano della sicurezza collettiva, si è aperto in pratica il conflitto fra il ritorno delle pretese di egemonia da parte di chi si sente “gendarme del mondo” e il disegno di una internazionalità basata sul diritto. La tentazione di usare l’Onu come copertura del diritto del più forte o di ignorarla, pure rischio a lungo latente, è il dato drammatico nuovo emerso in quest’ultimo scorcio di storia che non può essere ignorato e deve divenire problema politico esplicito. Si spiega così il rafforzamento di una linea di tendenza, già presente all’origine in un pacifismo ideologico e spesso troppo inerme, emerso, via via in occasione della guerra del Golfo, poi nei Balcani, volto a contestare anche l’intervento militare agito sotto l’egida Onu, come abbandono ipocrita del rifiuto della guerra, cui l’intervento finiva col somigliare troppo.
Dovrebbero essere riconosciuti da tutti con franchezza due fatti, solo apparentemente contraddittori. Sul piano dei principi astratti, quell’assimilazione non è, non può essere giustificata, deve essere considerata esiziale, perché porta con sé la caduta d’ogni ipotesi di governo internazionale della pace, consuma una rinuncia al principio stesso dell’organizzazione internazionale, condanna il pacifismo al nullismo e all’impotenza politica. Ma, sul piano della realtà, l’evoluzione delle cose che è sotto gli occhi costituisce un problema politico inevadibile, rappresenta la sfida in atto d’ogni politica internazionale democratica, va posto come la questione capitale a partire dalla quale si può e si deve costruire una strategia comune di chi vuole lavorare davvero per la pace.
In buona sostanza: il terreno di un dibattito interno al centrosinistra sulla congiuntura internazionale e sulle scelte da compiere non può essere il tema astratto sul consenso o meno dell’Onu alla guerra, né nel senso di un’accettazione della scelta militare, comunque strappata, comunque gestita, né nel senso di un suo rifiuto assoluto, ideologico, di principio. Deve essere sul come garantire i processi di politica internazionale che possano riqualificare, in un cammino certamente lungo e difficile, carico di difficoltà e incertezze, il ruolo autentico dell’Onu, bloccando e scoraggiando, quanto più possibile i trends contrari che caratterizzano questa fase. Occorre sapere tutti che non c’è altra via che la ripresa del disegno di un governo internazionale dei conflitti, quali che siano i conflitti in discussione, i pericoli che corre il mondo, e che questa via non è costruzione facile e immediata. L’internazionalismo delle lotte popolari per la pace e l’autodeterminazione planetaria non sarà mai vincente se non si coniuga con l’internazionalismo del governo dei conflitti e non ne approfondisce il senso complessivo.
Il governo dei conflitti suppone: la possibilità di delimitarli e definirli volta a volta nel loro nocciolo materiale concreto, con l’abbandono dunque della teoria dell’unico conflitto radicale metastorico; la fissazione di regole e poteri internazionali di intervento su di essi. L’approdo ad un “internazionalismo di governo” è l’unica forma politica, attinente cioè all’azione politica, capace di tradurre l’esigenza etica della pace fra gli uomini, del rifiuto della violenza, nella creazione delle condizioni socio-materiali della pace possibile. Va da sé che un tale risultato non può che essere a sua volta il frutto di un impegno politico diffuso, di una pressione popolare e democratica, non solo di una azione puramente diplomatica. Ma deve potersi coniugare con questa, quali ne siano i compromessi necessari, i passaggi parziali.
E occorre guardarsi dalle illusioni del perfettismo della politica; il ricorso al diritto internazionale, e dunque anche alle istituzioni internazionali che debbono garantirne l’applicazione, è sempre un ricorso datato e che esprime i rapporti di forza in campo. Quasi sempre leggi e istituzioni nascono da gruppi dominanti per garantire il loro dominio di fronte a pressioni esterne; ma esse non rappresentano per questo uno strumento solo coercitivo ma anche un limite oggettivo all’esercizio di un potere basato sulla forza, finendo col dare, proprio in ragione del loro dover essere fondate, legittimità e titolarità politica ad altri soggetti; ed è entro questa dialettica, finalmente pacifica, che si può e ci si deve inserire per modificare la natura dei rapporti politici basati sulla forza.
Il compito della politica di fronte alla violenza
La costruzione di un governo mondiale, accompagnata e rafforzata dalla costruzione di unioni politiche continentali o subcontinentali, è il massimo di utopia cui possiamo aspirare, tanto più forte in questa vigilia di angoscia e incertezza. Ma il ricondurre al livello internazionale il governo dei conflitti non salva da tutti i limiti della politica. Costruire sul terreno del diritto, cioè della legalità, i rapporti internazionali non può avvenire che scontando un certo tasso di convenzionalità su ciò che è legale o no. Costruire sulla democratizzazione dei rapporti internazionali non può affatto purtroppo escludere a priori che lo schema delle decisioni a maggioranza possa coprire ingiustizie. Non vedo alternative a questi limiti invalicabili se non la dialettica politica continua, la qualità del proprio impegno e della propria rappresentatività, la coerenza delle proposte e soluzioni istituzionali, volte a dare una sempre maggiore trasparenza alla democratizzazione del globo. In questa prassi realista dell’utopia internazionalista due cose mi sembrano da dover fissare preliminarmente.
Non si può usare lo stesso termine “violenza” insieme per ciò che governa ancora oggi i rapporti internazionali e per le forme eventuali di un intervento coattivo guidato da una istituzione internazionale al fine di garantire il rispetto del diritto e delle singole entità statuali. Si può certo attestarsi su una concezione teorica per cui violenza è ogni impresa che tenta di regolare la convivenza, violenza è lo Stato come tale, comunque rappresentato e governato, violenza è la legge, comunque motivata e proclamata. E’ una dottrina che ha una sua dignità storica e una sua funzione ideale incontestabile di costante rimessa in discussione del diritto, di provocazione feconda. Ma la ha in quanto resta fuori della esperienza politica con la quale è radicalmente in contrasto: non si dà, non si può dare attività politica, non si può avere cittadinanza politica attiva, sulla base del principio che nulla è regolabile della convivenza, che la collettività non ha mai il diritto di imporre con la forza comportamenti coerenti con il bisogno di sicurezza e stabilità della grande maggioranza degli uomini.
E tuttavia, se l’azione di forza esercitata in nome del diritto internazionale da un soggetto internazionale non merita la condanna che colpisce un’azione di guerra in senso classico, non è sufficiente un’etichetta improvvisata a qualificare un’azione di forza come espressione di un soggetto e del diritto internazionale. Anche la normale azione di polizia è profondamente diversa quando la esercita uno Stato democratico o un’arrogante dittatura; è diversa nei suoi obiettivi e nelle sue regole, ma lo è inevitabilmente anche nelle tecniche di scontro cui ricorre per garantirsi. Un’azione di polizia internazionale che si ponesse davvero sotto l’egida Onu dovrà pure, anche sotto l’urgenza immediata delle scelte da compiere, inventarsi i codici compatibili con le sue bandiere, almeno nel segno della forza minima e comunque tollerabile, del limite degli obiettivi da raggiungere, garantirsi le forme di una gestione effettivamente internazionale del conflitto in tutti i suoi passaggi. Qui si avverte tutta la gravità dei ritardi nella formazione di una forza militare regolare dell’Onu e la carenza politica e diplomatica di governi che non accompagnano la rimessa in gioco dell’Onu con un soprassalto di riqualificazione complessiva del suo protagonismo: una carenza che denuncia quanto è rimasto di cinico e opportunistico nel richiamo di facciata all’Onu.
Dietro il rinvio all’Onu ci può ben essere dunque anche una rilegittimazione di egemonie e interessi nazionali se questo non è accompagnato da una strategia complessiva di rilancio e riqualificazione di essa. Ma è appunto questo il punto. Tutta la vicenda riflette certamente il carattere di transizione della politica internazionale e il tasso di ambiguità che permane. La questione è se di fronte a questo braccio di ferro si vuol fare solo da spettatori critici, per vedere come va a finire, avendo già deciso che non cambierà nulla o se si deve tentare di essere presenti per determinarne l’esito e garantirsi le condizioni materiali di un diritto a intervenire e a partecipare alle decisioni. In sintesi questa non è una partita che si può giocare e vincere se i cosiddetti antagonisti e i cosiddetti riformisti giocano l’uno contro l’altro. Pressione popolare e responsabilità istituzionali e diplomatiche devono saper puntare insieme a esiti convergenti; è questo almeno il compito dell’Europa se davvero vuole essere soggetto determinante del sistema internazionale, coerente con la logica di superamento delle sovranità assolute da cui è nata.
Politica socio-sanitaria: banco di prova per l’Ulivo
Achille Ardigò
Una nuova stagione del “movimento cattolico”? Due iniziative da discutere
Franco Monaco
Focus: I movimenti “globali”: chi sono, dove vanno? Da movimenti no global a movimenti antiliberismo
Il movimento dei movimenti
Eugenia Montagnini Leggi tutto
No global (= contrario alla globalizzazione): è con questo termine che da Seattle in poi i media hanno etichettato una serie di movimenti sociali, di cui frequentemente riportano “spettacolari” immagini e notizie. In Italia se ne è iniziato a parlare, con insistenza e spesso con molta imprecisione, dai primi mesi del 2001, preparando gli italiani a ciò che sarebbe avvenuto nel mese di luglio a Genova, in occasione del vertice del G8. Dal quel momento i media hanno proposto volti e storie dei no global fino ad arrivare alle ultime settimane nelle quali è stata loro concessa nuovamente attenzione in occasione dell’incontro di Firenze e in concomitanza con l’arresto di 20 militanti. Ma chi sono questi movimenti no global?
Innanzitutto si tratta di movimenti sociali, ossia gruppi di persone che si trovano coinvolte nell'”essere contro” e nel tentativo di cambiare qualcosa, spesso provocando un mutamento sociale (un cambiamento, cioè, dell’ordine interno a una società, dei modi di interpretare sia le istituzioni sia i codici – intesi come norme, valori, culture – di quella società). Se allora i movimenti sociali si pongono sempre contro a qualcosa, a che cosa si dicono contrari questi movimenti? Sono contrari a quel tipo di globalizzazione che Luciano Gallino descrive con le seguenti parole: “ci si riferisce al fatto che negli ultimi decenni del Novecento lo spazio del mercato sembra aver raggiunto i confini demografici e territoriali del mondo (onde il sinonimo, preferito dagli studiosi francesi, di mondializzazione). […] agli inizi del Duemila non e’ rimasto alcun angolo di alcun continente, alcun gruppo umano o popolazione, le cui condizioni di vita non subiscano direttamente o indirettamente, per il meglio o per il peggio, l’influenza del mercato mondiale” .
Sono quindi contrari all’influenza del mercato su tutto e su tutti e perciò contrari alla globalizzazione economica di stampo liberista (o neoliberista). Il filo rosso, che unisce tali movimenti, è quello di dirsi contrari a “quel tipo” di globalizzazione e non alla globalizzazione in toto. Il termine no global è dunque fuorviante perché suggerisce una visione di contrarietà ad ogni globalizzazione, quando invece, tra le altre, è molto forte l’istanza di globalizzazione dei diritti umani.
I movimenti insistono molto sulla richiesta e affermazione di diritti umani, preferendo il termine più generico di diritti umani, piuttosto che diritti civili, diritti sociali, diritti politici, addirittura utilizzano la definizione di “diritti globali”. Si inseriscono all’interno di un dibattito attuale nel quale si suppone la necessità di passare dall’enunciazione formale di diritti attraverso dichiarazioni e Carte all’affermazione concreta dei medesimi spesso negati nella prassi quotidiana. L’idea di diritti umani globali è dettata dalla volontà di riconoscere che ciascun individuo è interprete di diritti, indipendentemente dal suo status di vita (civile, sociale, politico) ma proprio in quanto persona. Inoltre l’idea di diritti globali, o globalizzazione dei diritti umani, evoca il riconoscimento dei diritti che nascono all’interno di differenti culture e la necessità di porre in relazione culture diverse che già vivono fianco a fianco all’interno delle città globali.
A fronte di tutto ciò, è corretto definire tali movimenti come movimenti antiliberismo. I movimenti antiliberismo costituiscono una rete globale che si è andata incrementando e rafforzando sia a livello locale sia a livello internazionale; questa rete ha così preso il nome di “movimento globale”. Il “movimento globale” è un insieme eterogeneo di anime e di realtà molto diverse; è costituito da movimenti sociali quali: sindacati, movimenti per i diritti umani, ambientalisti, di tutela dei consumatori, gay, femministi, centri sociali,…, o più semplicemente da associazioni, Ong o singoli che si sentono parte di differenti movimenti e in ultima analisi dello stesso “movimento globale”. Restringendo la realtà del “movimento globale” all’Italia, per poter comprendere di che si tratta, è possibile distinguerlo, attraverso macrosemplificazioni non rigide, in due sottoinsiemi.
Il primo sottoinsieme, di tradizione nonviolenta, ha trovato spunto e origine nelle campagne contro la povertà, il debito, a favore della sicurezza alimentare, della pace. Le campagne sono dunque un suo strumento di lotta, di informazione, di formazione e sensibilizzazione. Movimenti pacifisti e femministi costituiscono il sottoinsieme; un nome per tutti: la Rete di Lilliput , che nel suo essere rete dà l’idea di una certa eterogeneità del “movimento globale”. La Rete di Lilliput vede, nel suo atto costitutivo, all’inizio del 1999, la presenza del Tavolo delle campagne (a sua volta promossa da: CoCoRiCo – Consumatori coscienti riciclanti compatibili, Chiama l’Africa – campagna nazionale di solidarietà con i popoli africani, campagna Sdebitarsi, campagna “Dire mai al Mai – Stop Millennium Round”, Ctm Altromercato, Nigrizia, Campagna per la riforma della Banca mondiale, Mani tese, Aifo – Associazione italiana amici di Raoul Follereau, Pax Christi, Beati i costruttori di pace, Rete radiè resch – Associazione di solidarietà internazionale, Wwf Italia, Associazione botteghe del mondo Italia, Bilanci di giustizia, Centro nuovo modello di sviluppo, Ired nord – Innovazioni e reti per lo sviluppo) e da un’infinità di realtà locali. Già nel suo piccolo, rispetto a quella che è la dimensione mondiale del movimento, è possibile trovare nella Rete una serie di presenze che in altro ambito sono difficilmente accostabili e accomunabili.
Nel secondo sottoinsieme è possibile collocare organizzazioni quali l’Arci, la Rete contro i G8, i Disobbedienti (coordinamento costituitosi durante le giornate genovesi e formato da: Rete noglobal, Tute bianche, Giovani comunisti di Rifondazione, la rete Rage di Roma e alcune realtà straniere), i Cobas e Rifondazione comunista.
Contadini e riforme
Un esempio ulteriore per comprendere la complessità del movimento globale e la sua struttura a rete, è quello di Via campesina, un’organizzazione che anima a livello internazionale il movimento contadino, che a sua volta fa parte del movimento globale. Via campesina nasce attraverso un’intuizione del più forte movimento sociale presente in America Latina in questi ultimi anni: il movimento dei lavoratori rurali senza terra del Brasile, conosciuto come Movimento dei Sem terra (Mst) e nato nel 1984 in piena dittatura brasiliana. Via campesina, prendendo spunto dalla realtà brasiliana dei Sem terra, si è costituita ufficialmente nel 1992 a Managua quando, in occasione del congresso dell’Unione nazionale degli agricoltori e ganaderos, vari leader contadini del centro e nord America e dell’Europa si diedero appuntamento per riflettere sugli effetti del neoliberismo sull’agricoltura. Via campesina si è poi articolata e strutturata in modo tale da raccogliere l’adesione di contadini e di organizzazioni di agricoltori che si trovano non solo nel continente latinoamericano ma addirittura spaziano da El Salvador alla Thailandia, dall’Estonia al Pakistan, dal Canada all’India, in un intreccio di organizzazioni nazionali e regionali (attualmente 70, per un totale di circa 63 milioni di agricoltori) che ricoprono l’intero continente americano, quello europeo e alcune nazioni di quello asiatico; in questo ultimo periodo si stanno consolidando contatti anche con il continente africano.
Dal momento della sua costituzione, Via campesina si riconosce come “movimento mondiale che lotta contro la globalizzazione dell’economia e la fame nel mondo e conseguentemente contro il modello neoliberista” e, sempre nel documento costitutivo, si legge che considera “necessario lottare per la costruzione di una nuova società in questo mondo che stronca le speranze e le aspirazioni dei più deboli”; è promotrice della campagna globale per la riforma agraria. La presenza al suo interno di voci differenti (e le diversità a ben vedere, al di là del fatto che si tratta sempre di agricoltori, sono veramente notevoli: basti pensare a ciò che può essere il lavoro per un contadino in Germania e quello che può essere il lavoro per un contadino in Honduras, il paese più povero dell’America latina), espressioni di culture diverse, di istanze diverse, di società diverse, dà l’idea di quanto il movimento globale sia poliedrico ed eterogeneo.
Questo deriva dal fatto che il movimento globale non solo è formato da movimenti sociali, associazioni, sindacati, partiti, ong, singoli cittadini differenti, fra loro, per origine, struttura, credo politico e anche religioso ma anche perché a loro volta i differenti popoli che lo compongono sono, strutturalmente, nella loro stessa anima, eterogenei, così come, a livello locale, la Rete di Lilliput, e, a livello globale, Via campesina.
Tale eterogeneità è vincolata al differente impatto che il neoliberismo e le decisioni economiche hanno nei diversi paesi e sopra numerosi aspetti della vita umana. Il movimento, incarnato nelle realtà locali complesse e diversificate, dà così risposte differenti, eterogenee, alla globalizzazione neoliberista. Da questo punto di vista il movimento globale è “un movimento di movimenti”. Un’esperienza di confluenza e articolazione di resistenze e lotte sociali che, oltre alle loro particolarità in termini di composizione sociale, portata, modalità di protesta e peculiarità territoriale, coincidono con il combattere e lottare contro gli effettivi devastatori della globalizzazione capitalistica nella sua fase neoliberale”. L’eterogeneità è percepita dai militanti del movimento come una ricchezza, non sempre facilmente gestibile, ma comunque tale.
Questo, tutto sommato, ci dà l’idea di quanto complessa sia la vita di un movimento sociale, ma anche di quanto sia errato inquadrarlo, come si fa tante volte, in schemi fissi e molto rigidi. Oltretutto, questo movimento – e parlando al singolare intendo proprio l’insieme dei movimenti antiliberismo – ha alle spalle le storie dei singoli movimenti, storie che sono veramente di spessore, come quelle del movimento pacifista o di quello ecologista.
Da popolo di Seattle a popolo di Porto Alegre
Nella storia di questo “movimento di movimenti”, che via via si consolida e che costruisce la propria identità, sono comparse anche definizioni come: il popolo di Seattle o il popolo di Porto Alegre. Cosa è avvenuto, dunque, in quelle città?
Il 30 novembre 1999 segna un momento importante per la vita del movimento globale. In quell’occasione l’organizzazione mondiale del Commercio (Wto) si autoconvoca a Seattle per dibattere una serie di accordi definiti Millennium Round ; sempre quel giorno migliaia di persone provenienti principalmente dagli Stati Uniti ma anche dal resto del continente americano, dall’Europa e anche dall’Italia, dopo mesi di dibattiti e organizzazione via internet (il grande strumento della globalizzazione ma anche del movimento globale) si danno appuntamento per manifestare il proprio disappunto contro le politiche economiche adottate dalla Wto. È un grande successo: una catena umana blocca l’accesso al quartiere dove il vertice della Wto ha luogo, impedendone l’avvio dei lavori.
Qualcuno afferma che a Seattle è nato un nuovo movimento sociale: ciò non è propriamente vero; a Seattle per la prima volta, su scala così ampia, persone e realtà, fra loro molto differenti, si sono incontrate per negare le logiche non solo della Wto ma di tutte quelle istituzioni, quali il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, promotori di una globalizzazione economica e finanziaria liberista; a Seattle, inoltre, sempre per la prima volta, i media si sono accorti del dissenso espresso da migliaia di persone contro quel tipo di globalizzazione. A Seattle, infine, i movimenti antiliberismo hanno dato vita a una rete, quella del movimento globale.
Porto Alegre è l’alter ego di Seattle; è la seconda faccia, sicuramente meno mediatica, che i movimenti scoprono. “Quello che è successo a Porto Alegre nel 2001 ha rappresentato una svolta significativa. Nella loro grande diversità, i movimenti d’opposizione alla globalizzazione neoliberista – cioè a una globalizzazione concepita da e per il potere del denaro, parafrasando la fortunata espressione inglese corporate-led-globalization – d’ora in avanti non continueranno solo a contestare, nei controvertici, forum e manifestazioni, i decisori dei destini del mondo riuniti nei summit del Fmi, del Wto, della Banca mondiale, dell’Alca (l’Accordo di libero scambio delle Americhe), o nel Consiglio europeo (come a Nizza, Göteborg, Bruxelles e Barcellona). I movimenti avranno modo di portare all’opinione pubblica mondiale proposte risultanti da un consenso Nord/Sud. Il secondo Wsf del 2002 ha confermato queste speranze” . Con queste parole Bernard Cassen, presidente di Attac e vicedirettore di “Le Monde diplomatique”, descrive il ruolo assunto dal Wsf per il movimento globale.
Il Wsf è un punto di svolta che il movimento imprime al proprio percorso, convocando i movimenti antiliberismo di tutto il mondo. Così a Porto Alegre, dal 25 al 30 gennaio 2001 (come avviene un anno dopo, dal 31 gennaio al 5 febbraio 2002) alcune organizzazioni, quali il comitato organizzatore brasiliano (formato da: Abong – l’associazione brasiliana delle ong, Attac, la Commissione giustizia e pace della Conferenza episcopale brasiliana, Cives – l’associazione brasiliana degli operatori per la cittadinanza, il sindacato Cut, Ibase – l’Istituto brasiliano di analisi sociali ed economiche, il movimento dei contadini Sem terra e la Rete di giustizia sociale e diritti umani con l’appoggio della prefettura di Porto Alegre, del governo dello stato del Rio Grande do Sul, e del Partito dei lavoratori, Pt) e il consiglio internazionale (che vede la presenza di delegati provenienti da molti paesi del mondo e da organizzazioni, che avevano già dato vita in passato al Forum delle alternative, quali il mondo che ruota intorno al mensile “Le Monde diplomatique”) convocano tutte quelle realtà e persone che da anni si oppongono al neoliberismo, cercando di dar vita a nuovi progetti di vivibilità e di sostenibilità.
Porto Alegre, come luogo in cui organizzare il Forum, non è scelto a caso; risponde a due precise caratteristiche: è una città del “sud del mondo”, ossia è rappresentativa di tutte le grandi città povere dove si raccolgono i tre quarti dei disperati del mondo; ed è una città che ha molto da insegnare al Nord, alla parte ricca del mondo. Il Sud di Porto Alegre è un Sud che provoca le istanze di equità, di integrazione sociale e soprattutto di globalizzazione dal basso che muovono il movimento e che permettono alle realtà che lo compongono di percorrere un tratto di strada insieme. Da anni a Porto Alegre, e all’interno dello stato di cui è capoluogo, il Rio Grande do Sul, è in atto una forma di partecipazione politica definita “democrazia partecipativa”, che ha nello strumento del bilancio partecipativo il suo punto di forza. Questa modalità prevede una forte valorizzazione e presenza della società civile e di tutte le realtà che la compongono all’interno delle istituzioni governative e municipali. A Porto Alegre, con tutte le difficoltà che comunque ciò comporta e che un sistema in fase di collaudo può provocare, si sta testando un altro mondo.
Um outro mundo è possivel è lo slogan che anima i militanti là convenuti e che si contrappone all’acronimo Tina (There is not alternative) attraverso il quale viene identificato il mercato globale. Anche la collocazione durante l’arco dell’anno non è casuale: volutamente il Forum si è sovrapposto nei suoi giorni di lavoro alle giornate del Forum Economico Mondiale, più familiarmente conosciuto come il Forum di Davos. I temi che il movimento ha dibattuto in occasione del I e del II Wsf (il tema della ricchezza e quello della democrazia, analizzando in particolare, per quanto concerne la ricchezza mondiale, la sua formazione, la concentrazione, la distribuzione in riferimento anche al tema del lavoro, dell’ambiente, della libertà del capitale finanziario; mentre per quanto riguarda la democrazia, dibattendo sulla limitazione democratica degli Stati nazionali di fronte alla libertà di operazione del capitale finanziario e al peso di organismi sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale) sono temi intorno ai quali realmente si interrogano i movimenti antiliberismo a livello locale e che coinvolgono anche la società civile globale.
L’anno decisivo: il 2001
Fra il I e il II Wsf è trascorso un anno particolarmente significativo, il 2001, per tutta una serie di eventi che hanno toccato profondamente sia i movimenti sociali, sia la società civile, come infine la comunità politica internazionale: è stato l’anno della marcia zapatista, l’anno di Göteborg, l’anno di Genova, l’anno dell’11 settembre e della guerra in Afghanistan, l’anno della più partecipata marcia della pace Perugia-Assisi, l’anno di Doha e di tanti altri eventi, più piccoli ma sicuramente importanti per i contesti locali. Eventi che hanno provocato, nei movimenti presenti al II Wsf, un forte sentimento di autoanalisi e di autocritica; il riferimento a Genova, dove ha preso vita il Genoa Social Forum (un mix di Seattle e Porto Alegre), è d’obbligo.
A Genova il movimento è arrivato proprio perché c’è stato il I Wsf, così come se non ci fosse stato Genova, il II Wsf sarebbe stato differente. Genova è il culmine, l’apogeo del ciclo del movimento da Seattle fino al II Wsf, frutto di un lavoro organizzativo iniziato nei primi mesi del 2000; è la chiusura di una fase e l’apertura di un’altra; è la fase di disincantamento rispetto al proprio essere movimento globale e alle appartenenze che la rete include o esclude. Con ciò intendo dire che il movimento a Genova viene posto di fronte al tema della propria eterogeneità e complessità non più in termini di considerazione teorica sul proprio essere ma nei termini, più faticosi, dello stare insieme, del far parte di un unico movimento, anche quando ciò non piaccia.
È in questi termini che parlo di disincantamento, che non vuol dire disaffezione, come ben dimostrano le manifestazioni e i forum che hanno fatto seguito a Genova, ma che intendo come modo nuovo del movimento di porsi di fronte a se stesso e di fronte alle sue molteplici anime. Seattle, Porto Alegre, Genova, fino ad arrivare alle giornate del Forum sociale europeo di Firenze (versione continentale del Wsf) mostrano come i movimenti non riducono la loro pratica movimentista alle manifestazioni di piazza ma sono tesi, fra una manifestazione e un’altra, nella ricerca e sviluppo di alternative al sistema liberista, al quale si contrappongono spesso con la consapevolezza di farne parte e quindi di essere vittime e promotori (con il proprio stile di vita e soprattutto di consumo) del sistema stesso.
Il breve excursus che ho tracciato rispetto alla definizione dei movimenti antiliberismo e rispetto ad alcuni momenti della vita movimentista (purtroppo senza accennare a ciò che avviene nei contesti più quotidiani e locali, quali i local forum o i “nodi” della Rete di Lilliput, per esempio) apre una serie di interrogativi sul ruolo politico che questi movimenti stanno svolgendo all’interno dell’attuale contesto storico e sociale. I due interventi che seguono (quello di Anna Fazi, che si inserisce come militante nel dibattito violenza/ nonviolenza, e quello di Andrea Calori, che apre uno sguardo sugli strumenti che i movimenti antiliberismo individuano per instaurare meccanismi di democrazia partecipativa) offrono la possibilità di andare oltre l’immagine mediatica più diffusa dei movimenti antiliberismo.
Il senso della “nonviolenza” nel dibattito sul futuro
Anna Fazi
Globalizzazione dal basso: forme partecipative e azione locale
Andrea Calori
Diritti sociali e contrattazione
Gian Primo Cella
La povertà a Milano. Un’indagine della Caritas ambrosiana
Elisabetta Larovere
Dibattito: La storia di “Appunti” e la democrazia dell’alternanza
Leonardo Benevolo
Libri: Parti uguali fra diseguali
Rosario Iaccarino