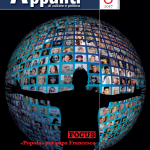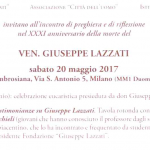Appunti 4_2002
Sommario
Diritto all’informazione e pluralismo dell’informazione Nel linguaggio dei giuristi il termine “informazione” assume un significato ambiguo o quanto meno, polisenso. Esso vale infatti a designare sia la posizione attiva di chi gestisce lo strumento informativo (stampa o televisione), sia la situazione alternativa di chi, dal lato passivo, chiede di essere informato. La prima accezione si colora, in chiave giuridica, in termini di libertà, trattandosi di garantire la più ampia possibilità di accesso all’acquisizione e alla gestione di mezzi comunicativi; la seconda chiede invece di essere qualificata in termini di diritto, offrendo a ciascuno l’instrumentario giuridico idoneo a garantirgli la possibilità di essere correttamente e compiutamente informato. Il raccordo tra questi due profili rappresenta l’ossatura portante dell’intero sistema democratico, essendo ormai pacificamente riconosciuto che le più radicali disparità (la cui rimozione è compito fondamentale della Repubblica, per la concreta affermazione del principio di eguaglianza sostanziale enunciato dall’art. 3 cpv. Cost.) si fondano sulla diversità delle informazioni di cui effettivamente si dispone. Senza dire che, se ciascuno di noi è tanto più libero quanto maggiore è l’ampiezza delle scelte che gli è consentita, questo ampliamento delle opzioni possibili necessariamente si riconnette alla consapevolezza delle situazioni reali. La realtà si è venuta comunque progressivamente modificando e, come sempre accade, ciò ha implicato un corrispondente mutamento dei significati comunemente assegnati ai testi normativi, anche di livello costituzionale. Il baricentro dell’art. 21, si è andato così via via spostando dal profilo della “libertà di manifestazione del pensiero” a quello dell'”informazione”, in tal modo ponendo l’accento non solo sull’interesse di chi utilizza il mezzo di diffusione ma altresì sull’utilità di un prevedibile destinatario della comunicazione. Si potrebbe anzi soggiungere che, secondo l’interpretazione prevalsa del testo costituzionale, nessuna tutela del trasmittente può giustificarsi, se non in vista della garanzia del destinatario. E’ ovvio che, in linea di principio, se ciascun evento comunicativo fosse connotabile in termini di correttezza e di completezza, in modo tale da offrire al destinatario, con riferimento al fatto comunicato, un panorama esauriente e non inquinato, in ipotesi consentendo a ciascuno forme giuridiche di reazione contro l’informazione scorretta, il risultato sarebbe garantito. L’esperienza ha dimostrato, nonostante i tentativi di quanti (ed io sono tra quelli) hanno cercato, con coraggioso velleitarismo, di costruire un “diritto all’informazione”, che un esito di questo tipo sfiora assolutamente l’utopia. E’ già difficile immaginare che la libertà del giornalista (o di chi gestisce lo strumento di comunicazione) incontri un limite in sfere autonomamente tutelate del destinatario della comunicazione (quelle attinenti, ad esempio, all’onore o alla riservatezza), ma è assolutamente impensabile che un limite possa essere colto all’interno del messaggio comunicativo, quale ne sia l’oggetto specifico. Anche il più elementare criterio di verifica del contenuto, quello che attiene per esempio ad una visibile distinzione tra la notizia e il commento, risulta assolutamente impercorribile. Il tentativo compiuto, più di vent’anni fa, da Zavoli di comporre un radiogiornale caratterizzato dalla distinzione tra i “fatti” e le “opinioni” appare, alla luce dell’esperienza contemporanea, quasi preistorico. Le “informazioni” (politiche o giudiziarie, economiche o di semplice cronaca) sono oggi sempre più colorate di aggettivazioni e di allusioni, di ambigui accostamenti e di indici valutativi che rendono sempre meno trasparente il fatto rappresentato. Non si chiede al destinatario dell’informazione di farsi un giudizio autonomo, ma di aderire alla scelta già operata dal trasmittente. I giornali di partito sono praticamente scomparsi, ma ciascuno di noi, guardando la testata del giornale letto dal suo vicino di posto in treno o in metropolitana, è in grado di collocarlo politicamente. Lo strumento comunicativo finisce dunque per diventare, anziché una garanzia di imparzialità, un criterio di verifica della parzialità.
Nicolò Lipari Leggi tutto
La libertà di informazione e il diritto all’informazione
All’inizio dell’entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, la garanzia offerta dall’articolo 21 è stata prevalentemente letta nel primo senso dell’alternativa richiamata. L’uscita dalla stretta compressiva del fascismo induceva a valorizzare il profilo della libertà di manifestazione del pensiero, specie entro un contesto culturale in cui la rinnovata dialettica delle idee non risultava ancora pesantemente strumentalizzata da organizzate centrali del consenso. Lo stesso rapporto politico era affidato, sia pure entro definite rigidità ideologiche, al rapporto diretto, al comizio. L’alternativa tra giornali di partito e giornali di opinione risultava ancora indicativa di una diversità della forma comunicativa e il giornale d’opinione, pur raccogliendo prese di posizione differenziate affidate a firme prestigiose, si sforzava di non schierarsi, di non assumere (all’interno di quello che veniva definito il cosiddetto “pastone” delle notizie politiche) posizioni preconcette. In questa chiave l’attenzione ad un diritto dell’utente (in ipotesi azionabile in funzione delle modalità del messaggio) appariva del tutto sfumata, nonostante non siano mancate nel dibattito dei giuristi voci preveggenti ed anticipatrici.
L’utente e i dilemmi dell’informazione televisiva
Quest’uso scorretto dell'”informazione” appare ancora più evidente e drammatico se si guarda al mezzo televisivo, dove la maggiore forza d’impatto della forma comunicativa, legata ad una fruibilità non necessariamente completa di una determinata comunicazione, rende ancora più alto il rischio che singoli profili distorsivi vengano amplificati. Il tentativo di qualificare il servizio televisivo gestito dallo Stato come “servizio pubblico” è miseramente fallito, non essendo nessuno di noi in grado di valutare la maggior oggettività della comunicazione dal medesimo gestita, rispetto a quella fornita da fonti private.
E’ ormai evidente dunque che la tutela dell’utente può essere realizzata solo attraverso la massima moltiplicazione delle fonti, essendo assolutamente impercorribile la via alternativa che scenda all’interno del singolo strumento comunicativo offrendo ai destinatari della comunicazione (o ad organizzazioni collettive che li rappresentino) idonei strumenti di reazione. Basti pensare, per limitarsi al più evidente degli esempi, che il semplice timore di rendere azionabile la pretesa degli utenti radiotelevisivi alla ricezione dei programmi diffusi dall’emittente nazionale, ha indotto a configurare il canone radiotelevisivo come tassa dovuta per la detenzione dell’apparecchio e non come corrispettivo del servizio (cfr. Cass. 16 gennaio 1971, n. 164, Cass. 1° febbraio 1983, n. 864). L’escamotage escogitato dal ministro Gasparri nel suo recente disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo di qualificare tutta l’informazione radiotelevisiva (anche quella gestita dai privati o da una futura Rai privatizzata) come servizio pubblico non sposta dunque di una virgola la realtà complessiva, essendo davvero impensabile che si possa imporre a tutti (non si comprende poi attraverso quali strumenti), ciò che non è stato possibile ottenere da alcuni.
Chi gestisce lo strumento televisivo sa benissimo quanto siano difficili e delicati i percorsi che conducono ad un certo risultato nei confronti dell’utente. Un accostamento può valere più di un ragionamento, un ammiccamento o un particolare tono di voce mentre si legge una notizia più del contenuto della notizia comunicata. Quale che sia stato l’oggetto del cosiddetto “contratto con gli italiani” sottoscritto da Berlusconi dinanzi a Bruno Vespa (nemmeno un italiano su cento oggi ne saprebbe riassumere a memoria tutti i punti), ciò che è contato, ai fini della comunicazione, è stata la messa in scena, la ritualità di un tavolo e di una pergamena che nessuna delle controparti aveva avuto: per il comune spettatore è diventato importante ciò che era ridicolo.
In definitiva, secondo i corretti modelli di un tempo, l’informazione dovrebbe essere l’opposto della pubblicità. Quest’ultima chiede da chi la propone un’adesione totale ed è tanto più riuscita quanto più il destinatario si adegua al messaggio e lo fa proprio. L’informazione dovrebbe supporre invece nell’utente una scelta critica, un confronto; non pretendere adesioni simpatetiche o emotive, ma semmai giudizi e valutazioni. La pubblicità si ripromette programmaticamente di ridurre le possibilità di scelta del consumatore, canalizzandole verso un esito predeterminato; l’informazione (quando è corretta) si propone invece di ampliarle. Nel momento in cui l’informazione si assimila alla pubblicità, l’unica garanzia possibile si può realizzare nella moltiplicazione degli strumenti comunicativi.
Dalla tutela del destinatario alla pluralità del sistema
L’ambiguità del nostro sistema giuridico che ha cercato, per così dire, di tenere il piede in due staffe, guardando all’un tempo anche al versante della tutela dell’utente ma lasciando tuttavia che – secondo logiche politiche e di mercato – il sistema evolvesse verso una progressiva restrizione dei soggetti gestori della comunicazione, va dunque superata in radice. Tutta la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre ribadito il valore costituzionale della tutela del destinatario della comunicazione quando, ad esempio, nella sentenza n. 105 del 1972 ha parlato di “interesse generale dell’informazione” protetto dall’art. 21; quando, nella sentenza n. 225 del 1974, ha qualificato come essenziale il servizio pubblico radiotelevisivo, “in quanto adempie a fondamentali compiti d’informazione”; quando ha caratterizzato tutte le sue decisioni in materia radiotelevisiva nell’ottica dell’obiettività dell’informazione che si realizza attraverso il pluralismo-confronto delle voci (cfr. sentenze n. 59/1960, 225/1974, 226/1974, 202/1976, 148/1981 e specialmente 826/1988). Più di recente, tuttavia, anche la Corte si è resa conto che l’ottica del risultato era in definitiva perdente e che per garantire il valore costituzionale era meglio porre l’accento sulla pluralità delle fonti informative.
Così, nella sentenza n. 420 del 1994, esplicitamente si afferma che la Costituzione impone al legislatore il vincolo di assicurare il pluralismo delle voci (espressioni, in quanto tali, della libera manifestazione del pensiero), posto che in tal modo è possibile garantire il fondamentale diritto del cittadino all’informazione. Quando dunque, nella sua sentenza più recente (la n. 155 del 2002), la Corte ha fatto sintesi di tutta la sua giurisprudenza, affermando che il diritto all’informazione garantito dall’art. 21 della Costituzione deve essere “qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”, l’accento va necessariamente posto sul primo punto, che risulta condizione necessaria perché possa comunque avviarsi una seria dialettica riferita agli altri. Non a caso la Corte ha opportunamente specificato che la presenza di un’emittenza privata (in ipotesi affidata a dialettiche di mercato) accanto ad un’emittenza pubblica (in qualche modo espressione delle voci rappresentate in parlamento) non è di per sé garanzia di pluralismo politico, perché è altresì necessario che, all’interno di ciascun veicolo comunicativo, siano garantite misure “sostanzialmente ispirate al principio della parità di accesso delle forze politiche”, in modo tale da assicurare anche quel cosiddetto “pluralismo interno” che è condizione necessaria perché nessuno strumento cessi di operare a garanzia dell’informazione dei destinatari, funzionando invece da megafono del suo gestore.
L’attuale paradosso: massima concentrazione del controllo sull’informazione
Del resto, non va mai dimenticato che il procedimento interpretativo, attraverso il quale si assegna significato agli enunciati normativi, va sempre raccordato ai modelli di valore e ai criteri di comportamento presenti nell’esperienza. All’interno della nostra realtà sociale è oramai convincimento diffuso che nel sistema televisivo non esista (o comunque costituisca eccezione) un professionismo dell’informazione esercitato in funzione esclusiva dell’interesse dell’utente. Prova ne sia che sia il governo di centro-sinistra che quello di centro-destra, appena investiti del ruolo, hanno provveduto ad un radicale cambiamento, all’interno della Rai, di tutti i direttori di rete e di testata, in tal modo chiaramente dimostrando di non credere ad una garanzia del diritto all’informazione valutato in funzione dei risultati, ma esclusivamente alla tranquillità offerta dal rapporto con una sodale del quale si conosce la collocazione politica e dal quale si possono fornire indicazioni o minacciare sanzioni.
Il nodo cruciale del problema dell’informazione sta dunque oggi solo nella massima garanzia del pluralismo delle fonti. In questa chiave va letto il recente messaggio del presidente della Repubblica “in materia di pluralismo e imparzialità dell’informazione”. Al di là di talune accortezze verbali (inevitabili per aggirare accuse di debordamento del ruolo) l’esplicito invito al parlamento ad emanare una “legge di sistema” (diretto a sostituire la cosiddetta “legge Mammì” del 1980 parzialmente integrata dalla cosiddetta “legge Maccanico” del 1997) non può esser di per sé giustificato né dalle indicazioni della Corte costituzionale (che non rappresentano una novità) né dalle direttive comunitarie (che non enunciano principi diversi rispetto a quelli che la nostra corte ha da sempre ribadito). Quell’invito si giustifica di fronte alla constatazione che la normativa antitrust attualmente in atto non è di per sé sufficiente a garantire il risultato del pluralismo e che d’altra parte se il sistema politico si affida esclusivamente alla logica della maggioranza può diventare compressivo degli interessi (e dei diritti) di chi in quella maggioranza non si riconosce o, ancor di più, di quanti si rifiutano di esercitare il voto, pur appartenendo alla collettività nazionale che deve essere tutelata nella sua globalità. Un’informazione gestita soltanto da chi è riuscito ad affermare la propria forza sul mercato o a prevalere politicamente secondo regole di segno maggioritario non è, per definizione, un’informazione pluralista e non garantisce quindi il diritto dei cittadini ad acquistare quell’ampio panorama di orientamenti e valutazioni che è presupposto indispensabile per compiere responsabilmente le proprie scelte.
E’ chiaro che il problema diventa, più che patologico, drammatico, quando si constata – come accade purtroppo oggi in Italia – che il presidente del Consiglio (punto di riferimento pressoché esclusivo delle scelte governative e parlamentari) è all’un tempo proprietario del massimo polo televisivo privato e controllore della Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Rispetto all’aberrante anomalia di una tale realtà non basta evidentemente trincerarsi dietro formalismi giuridici (il consiglio d’amministrazione della Rai è nominato dai presidenti delle due Camere, quasi che questi non fossero stati a loro volta eletti dalla maggioranza) o dietro l’alchimia delle percentuali di presenza sul teleschermo di singoli personaggi politici rilevate da apposite centrali di ascolto (per giunta senza tenere conto delle modalità di ciascuna presenza e degli effetti in chiave di audience). Come si è visto, quel che è essenziale è assicurare la pluralità delle fonti e il pluralismo delle voci all’interno di ciascun contenitore. La “nuova legge di sistema” invocata dal presidente della Repubblica non può dunque limitarsi a scimmiottare la “Mammì” e men che meno può pensare di aggirare il nodo di fondo addirittura eludendo i problemi (come accadrebbe se si fingesse di aumentare artificiosamente il numero delle emittenti in modo di evitare lo spostamento sul satellite di Rete 4, così come previsto dalla Corte costituzionale). Essa deve porre all’un tempo rigorosi limiti al mercato delle fonti informative (sul presupposto che la loro moltiplicazione inevitabilmente migliora il complessivo prodotto informativo) e precisi condizionamenti alle forze politiche affinché si eviti il rischio che l’esito elettorale si rifletta automaticamente nei meccanismi della comunicazione in tal modo compromettendo gli interessi degli sconfitti e di coloro che hanno rifiutato di partecipare al voto.
So bene che una cultura di questo tipo non appartiene al mondo dei nostri politici. Non a quello dell’attuale maggioranza (che infatti non si è vergognata di sfornare una proposta come quella del ministro Gasparri, che è offensiva per il Capo dello Stato e oggettivamente ridicola); ma nemmeno a quello della minoranza, che non solo non è stata in grado (quando le posizioni erano invertite) di risolvere il problema di fondo della nostra traballante democrazia proponendo un serio testo di riforma, ma che non ha ancora attivato nemmeno un gruppo di lavoro incaricato di studiare un progetto serio ed efficiente. Si ipotizza così (in un disegno di legge di fonte governativa cui non mi risulta sia stato contrapposto un serio progetto alternativo da parte dell’opposizione) che possa addirittura superarsi il limite previsto dalla legislazione in vigore in ordine alle possibili intersezioni tra proprietà dei giornali e proprietà delle reti televisive; si lascia del tutto in ombra il problema dell’incidenza sul sistema comunicativo del mercato pubblicitario (la cui forza condizionante ha pesantemente inciso sulle qualità del prodotto, come possono facilmente verificare, ripescando nella memoria, coloro che hanno conosciuto, in anni lontani, la tanto vituperata Rai di Bernabei); non si prevedono pesanti sanzioni, fino al limite della revoca della concessione, a carico di coloro che, gestendo uno strumento tremendamente pericoloso in funzione della sua invasività, attentano alla serenità e all’equilibrio psicologico dei minori; non si costituisce un serio sistema antitrust, artificiosamente introducendo il modello secondo il quale l’ingresso di un nuovo soggetto fra i gestori dei mass media, compromette le potenzialità economiche degli imprenditori già presenti sul mercato, anziché arricchire le potenzialità degli utenti.
Alla ricerca di un vero pluralismo informativo
Le prospettive del futuro che si intravede non sembrano le più rosee. La politica gestita secondo tecniche pubblicitarie è ormai assurta alla presidenza del Consiglio. Per essa, ovviamente, nessuna informazione è pensabile se non in chiave propagandistica (e quindi intrinsecamente di segno pubblicitario). Peraltro un’opposizione debole (che preferisce gestire l’inevitabile sconfitta legata agli espedienti regolamentari di tipo parlamentare, anziché creare i presupposti per un dialogo costruttivo con i cittadini) risulta incapace di costruire una seria piattaforma alternativa valendosi delle molte competenze disponibili e finisce per scimmiottare le tecniche del suo interlocutore. Accade così, sempre più di sovente, che la parte sana di una società civile, che non è disponibile ad essere equiparata ad un suddito consumatore, non ha altra possibilità d’espressione che la protesta dei “girotondi”, senza peraltro trovare interlocutori politici capaci di tradurre quella protesta in proposte concrete, in iniziative plausibili supportate dal parere di qualificanti esperti dei diversi settori. Qui non si tratta di “dire qualcosa di sinistra”, secondo la celebre battuta di un film di Moretti, ma di fare qualcosa di serio uscendo dall’impasse di una semplice passiva contestazione delle iniziative di Berlusconi. Speriamo che il messaggio del presidente in tema d’informazione possa funzionare, almeno su di un tema così delicato, quale scossa elettrica per un’opposizione in stato di quiescenza.
E’ chiaro che non sono più sufficienti tecniche dilatorie o contestazioni di facciata. Se si intende criticare l’apparente oggettività del criterio di designazione dei consiglieri di amministrazione della Rai, non si può passare sotto banco ai presidente delle Camere, un foglietto con due nomi secchi (rimasti infatti invariati durante tutto il periodo di gestione), ma si deve quantomeno offrire al controllo della pubblica opinione un’ampia rosa di nominativi al di sopra di ogni sospetto e soprattutto non riconducibili ad alcuna etichetta (o amicizia). Se si vuole davvero avviare l’introduzione di una legge di sistema non ci si può limitare a criticare le iniziative del ministro Gasparri, ma bisogna essere capaci di buttare sul tavolo della discussione un progetto serio, uscito da un dibattito sollecitato fra gli esperti del settore e sottratto ad ogni convenienza di partito (anche se sarà ormai gioco forza accantonare ogni impossibile giustificazione sulle inerzie del governo di centro-sinistra). Se si vuole progressivamente reintrodurre il modello di un’informazione oggettivamente corretta, attenta a potenziare le possibilità critiche del destinatario al di fuori di ogni sollecitazione epidermica, non ci si può limitare ad una semplice alternativa fra nomi, che vale semmai a ratificare il modello di un’informazione qualificata a priori in funzione di chi la gestisce e non a posteriori in base al risultato, ma si deve semmai educare la gente a capire dove sta il vizio dell’altrui comunicazione e in cosa consiste la sua ambiguità. Se si vuole seriamente opporre alla logica omologante del partito-azienda, non si può cadere nella trappola di contrapporre, nei consueti dibattiti televisivi, ai soliti Schifani di turno gli altrettanto soliti personaggi della gerarchia di centro-sinistra (scelti in funzione esclusiva di un dosato equilibrio tra Ds e Margherita), ma si deve invece pescare a piene mani nella società civile, quella società seria e responsabile che ormai rappresenta la spina nel fianco del sistema berlusconiano e che sarebbe in grado di fare contagio fra i più pigri e inerti con la forza di specifiche competenze non inquinate da aprioristiche appartenenze. Se vogliamo uscire da ogni tecnica omologatrice, dobbiamo creare i presupposti perché si rompa la logica di uno “stile” di far politica che è buono soltanto ad incrementare il disamore e il rifiuto.
In sostanza, il problema dell’informazione, mentre da un lato chiede interventi di quadro non si sottrae neppure alla responsabilità di ciascuno di noi. Nella difficile stagione che stiamo attraversando nessuna passività può più essere giustificata, neppure quella apparentemente innocua, di subire (incrementandone l’audience) un programma televisivo sottilmente subdolo od acquiescente. Ritornano ammonitrici, anche a questo proposito, le parole di M. Buber quando diceva: “se ci fosse il diavolo, non sarebbe colui che decide contro Dio, ma colui che eternamente non sa decidersi”.
Non solo flessibilità: qualità del lavoro e occupabilità
Eugenio Zucchetti
Focus: La crisi dell’Ulivo: le politiche, i leader, le procedure
Che sarà?
Giovanni Colombo
Crisi dell’Ulivo o crisi politica?
Paola Gaiotti
Prodi e soltanto Prodi
Fulvio De Giorgi
Quattro tesi sulle primarie dell’Ulivo
Stefano Ceccanti
La bambina e le voci della Sierra Madre. Intervista a Lila Downs Pluriculturalità indigena, modernizzazione e vocazione comunitaria Lo Stato messicano di Oaxaca rappresenta una significativa cerniera nel panorama indigeno messicano, tra i diversi tempi che solcano questo paese; una cerniera cronologica, storica, linguistica e culturale, cucita oggi attorno a quella lunga e polverosa striscia nella terra che è la carrettera panamericana, lungo cui si dipanano, specie dall’entrata in vigore del trattato Nafta (1994), flussi di merci, uomini, donne e bambini. Una risorsa e ferita nel susseguirsi di valli arcigne, con i loro cactus che vegliano silenziosi come antichi guerrieri, le foglie di nopal coperte ancor oggi di cocciniglia per tingere i tessuti e le ombre della storia in lontananza. Una raccoglitrice di storie Proprio a questo patrimonio culturale, fatto di appartenenze diverse (al clan familiare, alla comunità di villaggio, al ceppo etnico-linguistico, al ceto sociale, alla realtà metropolitana, alla nazione divisa), attinge da tempo Lila Downs, una delle più interessanti ed autentiche artiste provenienti dall’area di Oaxaca. Lila è stata capace di innestarsi, con un proprio linguaggio che non rinnega le contraddizioni della modernità, su una tradizione culturale antica quanto poliedrica, fatta sia di letteratura popolare che di racconti musicali, mantenutasi viva nel cuore di un territorio sospeso tra la sua matrice indigena e la sua capacità di fornire esperienze di avanzata sintesi culturale. Poetessa e cantante, figlia di padre anglosassone e di madre mixteca, Lila è cresciuta in queste valli incessantemente battute dal sole e dal vento, prima di trasferirsi negli Stati Uniti dove si sarebbe laureata in antropologia sociale presso l’università del Minnesota, specializzandosi nello studio della condizione della donna zapoteca. Cantante fin dall’infanzia, tornata in Messico, Lila si è dedicata al recupero della tradizione folklorica oaxaqueña, avviando un personale processo di rielaborazione della tradizione, grazie anche ad una voce particolarmente suggestiva, capace di passare con disinvoltura dai toni più gravi e cantilenanti a quelli più acuti e delicati. L’intervista La questione indigena attraversa la storia mesoamericana dall’epoca della conquista spagnola. Dopo secoli di violenze e politiche contraddittorie questa si è riproposta con forza nell’età contemporanea, diventando un elemento con cui confrontarsi sia sul terreno politico che socio-economico. Oggi in Messico la questione indigena appare quanto mai aperta, dal Chiapas al Chihuahua ed ha assunto volti diversi, dallo scontro armato alla resistenza silenziosa. Cosa pensi della situazione attuale di oltre dieci milioni di indigeni messicani, vedi concretizzarsi una qualche possibile soluzione della crisi? O, questa è una domanda molto grande cui rispondere. Io credo che il tema sia estremamente complicato perché tocca diversi ambiti: una dimensione sociale, una economica ed una culturale. Le difficoltà sul terreno sono molte, però io ho la sensazione che le cose vadano in qualche modo migliorando. Credo infatti che il movimento armato (ndr. il riferimento è agli zapatisti del Chiapas), nonostante diversi limiti, abbia aiutato a tirar fuori qualcosa che teniamo dentro di noi, perfino nelle comunità più incorporate nel sistema nazionale. Però credo anche che non si possa parlare di un solo gruppo indigeno come di entità indistinta, perché ogni gruppo possiede una visione estremamente particolare del suo ruolo e del suo destino. La particolarità del contesto oaxaqueño è in realtà qualcosa già in atto da secoli prima della conquista. La storia di questo Stato nasconde infatti l’eredità di una lunga tradizione di sintesi culturale, tra zapotechi e mixtechi, tra mixes e nahua, ancor prima che tra indigeni e spagnoli. Come tu dicevi, le diverse comunità indigene, nonostante i problemi ricorrenti (povertà diffusa, alcolismo, emigrazione) mantengono una forte capacità di conservazione e rielaborazione del proprio patrimonio culturale. Ci sono cooperative di turismo gestite da indigeni, piccoli musei locali, realtà molto distanti ad esempio dal Chiapas dove gli influssi esterni (dagli industriali del legno a quelli del turismo) hanno avuto un impatto più radicale. Cosa ne pensi di queste iniziative che, pur senza grandi risorse, riescono a partire dal basso? Io credo che nell’Oaxaca si sia verificato un caso molto particolare e curioso di sintesi; una combinazione di etnie diverse, sviluppatasi culturalmente e linguisticamente, dovuta forse anche alla particolare conformazione geografica della regione. L’Oaxaca infatti non era una naturale riserva ecologica come ad esempio il Chiapas, non possedeva tali ricchezze naturali e forestali, non attirava certi interessi e quindi, pur possedendo molti elementi simili, il suo destino nella stagione delle grandi trasformazioni economiche fu differente. Allo stesso tempo credo che nell’Oaxaca, anche nelle comunità indigene, si sia sviluppato nel tempo un processo di nazionalismo politico più accentuato (ndr. non è un caso che l’unico presidente messicano d’origine indigena sia stato, nel XIX secolo, lo zapoteco Benito Juarez) e credo che in questo senso sia stata decisiva la riforma agraria che ha contribuito ad un cambiamento molto significativo nel nostro Stato. Fu l’effetto degli ejidos? Credo proprio di sì. Io non ho letto molto di questa epoca ma so che gli ejidos ebbero un forte impatto sulla distribuzione delle terre e lo so grazie ai racconti di mia nonna. Mia nonna visse la stagione della rivoluzione e quindi la fase più calda della questione terriera. Assistette a diverse incursioni nel suo villaggio delle truppe Carranziste. Credo che proprio a causa dell’esperienza di questi attacchi dell’esercito di Carranza, ci raccontava che i «buoni» erano gli zapatisti . Vedi io credo che per lei, così come per gli abitanti delle comunità indigene, fosse molto importante l’idea che la terra continuasse ad appartenere alla comunità. In Messico ed in America latina più in generale colpisce la capacità organizzativa e di reazione delle donne che spesso vivono le situazioni socio-culturali più difficili. Ad Oaxaca mi colpì un cartello dell’associazione delle Madres magonistas che diceva «siamo sfruttate tre volte perché siamo donne, siamo povere e siamo indigene». Tu hai scritto una canzone (La Niña) dedicata a tutte le donne che lasciano le loro comunità in cerca di fortuna e che spesso non possono aspirare ad altro che a divenire maquiladoras o badanti che per mantenere una famiglia (nella stragrande maggioranza in America latina i figli restano sempre a carico delle madri) non guadagnano più di 30 pesos al giorno. Io credo che spesso noi pensiamo in termini di democrazie avanzate, che siamo tutti uguali e che tutti abbiamo pari opportunità per affrontare la vita ma basta l’esempio delle donne latinoamericane per vedere, io temo, una forte distanza da reali forme di uguaglianza. Bene io so che la donna latinoamericana ha però anche dei caratteri propri di forte originalità; è un discorso molto complesso, perché oggi ci sono anche donne di successo che rivendicano la propria differenza è questo è un fatto positivo ma la situazione è molto articolata. So anche che vi sono molte donne che cercano di lasciare i propri villaggi dove sopportano a fatica mentalità totalmente chiuse; spesso però escono dalla comunità alla ricerca della libertà e vanno incontro a nuove incognite. Non so se tu sei a conoscenza di un caso molto triste e tragico che si è registrato a Ciudad Juarez. Il caso iniziò con la scomparsa di venti ragazze immigrate; poi, dopo cinque anni, furono quaranta, quindi passarono a cinquanta ed oggi sono oltre 250, tutte di un certo tipo, attraenti e giovani. E’ stata naturalmente aperta un’inchiesta ma nessuno è ancora riuscito a stabilire chi ha ucciso queste ragazze. C’è purtroppo una negligenza del sistema legale ma questa tragedia è anche il frutto di una combinazione di elementi sociali. Nel nord la cultura machista è ancora fortemente radicata e la maggior parte di queste giovani veniva dal sud del paese, da un altro contesto culturale, perlopiù da comunità indigene. Molte di queste ragazze si sono sentite libere dai vecchi vincoli, hanno indossato vestiti più sexy e, in un altro contesto, in un’altra situazione si sono ritrovate assassinate. Questo certo è un caso tragico ed estremo ma la mia canzone è stata scritta pensando alle difficoltà quotidiane che tutte le donne che lasciano le proprie comunità vengono ad affrontare in una realtà nuova e magari sconosciuta. Però non voglio mai abbandonare una speranza, una vena di ottimismo e pensare che un giorno saremo uguali, dopotutto, all’altra parte dell’umanità. Il tuo ultimo lavoro, La Linea (il confine) è dedicato ad una delle questioni più scottanti di questo mondo «globalizzato»: il fenomeno migratorio. In Italia è stata recentemente approvata dal governo di centro-destra una nuova legge molto rigida nei confronti degli immigrati extracomunitari. Eppure l’Italia è stata per lunghi decenni un paese di emigranti. Gli USA stanno attuando una politica di chiusura, eppure sono un paese nato da popoli immigrati. Mentre l’industria chiede manodopera a basso costo, cresce la paura dei ricchi verso i poveri, su di essa speculano partiti politici e si fortificano le frontiere. Tu che conosci bene sia la realtà messicana (urbana e rurale) che quella nordamericana, cosa pensi di queste preoccupanti tendenze? Vedi, io credo di essere oggi una persona incredibilmente fortunata, perché posso andare e venire e condividere esperienze e viaggiare ma non per tutti è così. Anche per questo io voglio comunicare le distinte prospettive che possiedo di mondi diversi, di appartenenze diverse e credo che sia un dovere morale raccontare o portare alla luce storie che molte volte la gente non vuole ascoltare, come le storie di persone che muoiono tentando di valicare clandestinamente una frontiera . Per come io concepisco l’arte, penso sia importante che questa nasca da un’esigenza di dar voce, da una radice sociale. Quando mi trovavo nell’Oaxaca a volte alcune persone mi chiedevano di tradurre dall’inglese i certificati di morte di loro giovani figli o parenti emigrati negli Stati Uniti e questa esperienza mi ha lasciato il segno. La poesia, la musica tradizionale e l’arte mixteca e zapoteca resta ancor oggi fortemente connessa ad una dimensione religiosa e più in generale spirituale. Una caratteristica che colpisce è la particolare capacità di mescolare elementi drammatici e poetici con un forte senso dell’umorismo se non addirittura del comico. La vita unita alla morte, entrambe dipinte con mano magica e con uno stile molto singolare, come nelle feste popolari o negli scheletri danzanti. Tu che hai reinterpretato con passione tale patrimonio cosa pensi di questo mondo espressivo singolare senza confini né linee all’apparenza razionali? Credo che un po’ come è avvenuto in molte altre culture popolari, qui da noi si sia sviluppato nel tempo un modo di comunicare, che appare forse particolare perché ha mantenuto molto di un’antica concezione della vita propria delle civiltà mesoamericane. Mia nonna ad esempio diceva che quando un animale si feriva o si ammalava e iniziava a mandare un cattivo odore, per il principio della decomposizione della vita, non bisognava spaventarsi; quella era una cosa buona perché quell’animale stava iniziando a offrire il suo frutto (del suo stesso corpo) alla terra. Penso che in fondo sia questo il concetto che ancora conserviamo della morte. Per questo i nostri cimiteri sono così colorati e quando andiamo a trovare i nostri morti e a parlare con loro, spesso suoniamo, beviamo e cantiamo; perché la morte rappresenta un momento di cambiamento per tutta la comunità, per i morti ma anche per i vivi.
Massimo De Giuseppe Leggi tutto
Nonostante una serie di contraddizioni aperte, l’Oaxaca ha mantenuto anche in questa stagione che i giornalisti amano definire «globalizzata» i tratti di un complesso crogiolo etnico-culturale. Nelle sue vallate vivono ancora almeno 16 gruppi etnico-linguistici autoctoni: dagli Zapotechi, Mixtechi e Nahua (Aztechi), a piccoli gruppi come gli Zoques, i Tacuates e Triquis. Gli indigeni continuano generalmente a vivere nei loro ejidos o nelle loro comunità rurali, di cui spesso gestiscono ancora comunitariamente (secondo un sistema di rotazione delle cariche non retribuite) i pubblici ayuntamentos , anche se non è difficile vederli in città (nella stessa Oaxaca o nel grande mercato domenicale di Tlacolula), nelle periferie povere dove si sono trasferiti per necessità, o per le vie del centro, dove le donne giungono per vendere fiori, verdure, tortillas, cavallette fritte, manufatti tipici artigianali o piccoli oggetti di produzione cinese (dalle lamette da barba alle pile di ricambio).
Oaxaca era ed è però soprattutto un «ponte nel ponte», in quel Messico diviso (socialmente, economicamente e culturalmente) tra le tentazioni del modello statunitense e la cultura mesoamericana, tra un ruolo di paese in via di sviluppo che esporta uomini, donne e bambini al nord e quello di potenza regionale che deve bloccare i flussi provenienti da altri «sud» più poveri: dalle sue stesse montagne rotonde del Chiapas, dalle verdi valli depauperate da trent’anni di violenza del Guatemala, dai vulcani rossi del Salvador o dalle terre d’acqua del Nicaragua. Mentre la globalizzazione fa sentire sempre più i suoi effetti, in questa terra di antica sintesi pluriculturale nascono strazianti corridos contemporanei che non parlano più di eroi popolari della rivoluzione messicana o di eredi di antiche civiltà guerriere, bensì di giovani zapotechi e mixtechi che hanno dovuto lasciare il loro villaggio e la loro famiglia per cercar fortuna lontano dalla comunità e che in molti casi non vi hanno più fatto ritorno.
Nei suoi lavori Lila ha saputo quindi unire una cura filologica dello studio delle sedimentazioni culturali del mondo indigeno messicano (lungo un tragitto complesso che parte dalla cosmogonia mixteca, passando per il patrimonio folklorico delle feste religiose, consolidatesi nella prima metà del Novecento, per approdare alla quotidianità dell’oggi) ad una costante attenzione verso i temi sociali, cui ha saputo aggiungere una non comune capacità di denuncia delle situazioni più scottanti. Lila nei suoi lavori racconta (in mixteco, zapoteco, nahuatl, spagnolo e inglese) il Messico di oggi, con le sue leggende antiche di animali e personaggi mitologici, capaci di convivere in modo naturale con le storie di ragazze indigene che migrano in cerca di fortuna, di contadini scomparsi, di clandestini che solcano nudi le frontiere e di giovani che sognano mondi sconosciuti, utilizzando una commistione di umorismo e tragedia che è la linfa stessa di una terra che nel corso dell’anno per solo due volte si cambia le vesti della natura.
In questo senso io penso che il movimento armato abbia permesso di mantenere alta la visibilità della questione, innanzi tutto presso il governo. La questione indigena ora non è scomparsa, è tra le priorità nel dibattito pubblico, è viva, specialmente dopo iniziative come la marcia dello scorso anno , e quindi, nonostante tutte le difficoltà, credo che ora sia difficile tornare indietro.
La situazione è però al tempo stesso estremamente articolata. Io conosco intellettuali e studiosi del mondo indigeno ed ho amici che si occupano del legame tra le comunità ed il pensiero nazionalista messicano e molti di essi hanno proposte e idee molto diverse gli uni dagli altri. Ho ad esempio un amico dell’etnia zapoteca, che vive nella Sierra madre, che considera che la cosa più importante sia che le comunità posseggano una propria radio o magari una televisione per poter diffondere gli ideali ed i valori comunitari; al tempo stesso ho altri amici della comunità triqui, che è un gruppo etnico molto piccolo, puro lo definirei (mantengono una struttura sociale estremamente chiusa alle influenze esterne, come in certe comunità degli altopiani del Guatemala) e loro conservano una concezione dell’autonomia politica, legale ed educativa, molto forte e radicale. Quindi bisogna tener conto di tutte queste diversità, della pluriculturalità delle comunità indigene, ma nonostante la complessità della questione io ora la vedo positivamente e dal mio canto cerco di contribuire con un piccolo granellino di sabbia. Credo infatti che solo in questo modo, ricostruendoci a poco a poco una coscienza calata nell’oggi si possano aiutare le comunità a rinascere.
Questo processo lo vedo quotidianamente nell’Oaxaca, per esempio nella grande solidarietà che esiste tra gli abitanti delle comunità. Si va registrando una sorta di rinascita; c’è tutta questa forza in giro che molte volte resta latente e a tratti comincia ad uscire.
Ciò vale ancor oggi: la terra è della comunità, è un bene comune, è di tutti. E’ dalla milpa (il campo di mais) che discende tutto. Io credo che in fondo questa idea è quella che ci ha salvati nell’Oaxaca, nonostante tanti problemi restino aperti. Questo è un fatto personale ma ancor oggi quando torno lì per un po’ di tempo mi sento in una situazione di tranquillità particolare, perché sembra quasi che il mio ego se ne vada scomparendo. Non so se questo è possibile ma certo qualcosa cambia in me, perché lì non importa tanto il singolo individuo, perché tu fai parte di una tessitura, di un complesso lavoro al telaio, in cui tutte le parti sono collegate. Questo lo trovo molto interessante e penso che valga per tanti gruppi indigeni, non soltanto nell’Oaxaca.
Oggi siamo di fronte ad un mondo globalizzato che chiede lavoratori ma non vuole uomini e donne in carne ed ossa, con i loro problemi. Bene, io credo che sia chiaro che si sta diffondendo un razzismo strisciante secondo modalità che mi fanno impressione. Perché io ho avuto in sorte un padre bianco e una madre indigena e non ho una preferenza per uno rispetto all’altra, né viceversa. Credo poi anche che esista una sorta di responsabilità storica: perché alcuni possono andare a colonizzare un paese, però quando la gente di pelle scura bussa alla loro porta, per entrare in questi stessi paesi che li colonizzarono, non viene accettata. Lo so che può sembrare ingenuo e d’altrocanto non conosco bene i complessi meccanismi del sistema economico-commerciale internazionale ma non posso non manifestare il mio disagio di fronte a questa situazione.
Ciò non significa certo che siamo contenti della morte, che ci fa paura come a tutti gli umani, però esiste questa sorta di rispetto dell’anima; la morte non viene nascosta o occultata, è come un processo che permette di onorare gli antenati defunti; è una dimensione della religiosità molto importante che credo abbiamo in buona parte dimenticato nella società contemporanea, perché preferiamo dimenticare rapidamente chi fu Martin Luther King, chi fu il Mahatma Gandhi, chi furono tutte quelle persone note o sconosciute che ci hanno aiutato a crescere, perché rapidamente dimentichiamo molte cose.
Lo sviluppo sostenibile dopo Johannesburg Ai primi di settembre il sipario del palcoscenico mediatico si è chiuso repentinamente sul Summit mondiale di Johannesburg dedicato allo “sviluppo sostenibile”, per aprirsi sulla nuova emergenza: la guerra all’Iraq. Ma una riflessione su quanto è successo a Johannesburg merita di essere fatta, anche perché le questioni che nel vertice si sono affrontate o non si sono volute affrontare, sono il brodo di coltura di tante emergenze, compresa quella del terrorismo o dell’Iraq. Questi squilibri tendono a riprodursi anche all’interno dei singoli paesi, per cui si parla di società mondiale a “due standard”. Uno sviluppo a “due standard” è chiaramente un fattore di instabilità globale e non è sostenibile. D’altra parte, come ha ricordato anche Chirac, i paesi ricchi si comportano come se in prospettiva l’umanità potesse avere a disposizione numerosi pianeti Terra per mettere i rifiuti e trovare risorse. La percezione di questo squilibrio e della minaccia tragica che la sottende, credo sia la motivazione di fondo della straordinaria attenzione e partecipazione al Summit di Johannesburg.
Giuseppe Volta Leggi tutto
I nodi cruciali dello “sviluppo sostenibile”
Il Summit è stato un evento di dimensioni straordinarie: il più grande concorso di uomini di stato, di politici, di organizzazioni economiche e di espressioni della società civile che si sia mai verificato nella storia: 104 capi di governo o capi di stato, 21.000 tra delegati e osservatori ufficiali, 8.000 Organizzazioni non governative (Ong), 4.000 giornalisti e almeno 30.000 altri convenuti. Questa grande convention, è stata attesa da molti con grandi speranze. Per tanti era un fallimento scontato o addirittura programmato, vista per esempio la preannunciata posizione degli USA, l’assenza di Bush e l’incertezza, fino all’ultimo momento, della partecipazione di Berlusconi.
Il termine “sviluppo sostenibile” era stato in qualche modo istituzionalizzato nel celebre rapporto Our common future diffuso nel 1987 a cura di una commissione dell’Onu presieduta dal primo ministro pro tempore del governo norvegese, signora Brundtland. Il termine è poi entrato nel lessico economico, politico, sociale e anche scientifico, a partire dal Summit sull’ambiente di Rio del 1992 ma non era mai direttamente divenuto oggetto specifico di un vertice mondiale. Il Summit sudafricano lo ha reso più popolare e ci offre l’occasione di riflettere su tre questioni:
1) Perché il tema ha avuto una risonanza così profonda nella opinione pubblica mondiale da motivare una assemblea tanto straordinaria ?
2) Che cosa ci ha comunicato Johannesburg?
3) Chi è veramente interessato allo sviluppo sostenibile?
Un po’ di storia e le ragioni della risonanza
Il Summit di Johannesburg si colloca sulla scia di una serie di iniziative dell’Onu avviate fin dagli anni Settanta. Alla fine degli anni Sessanta e nei primi anni Settanta i paesi del “Nord del mondo”, e cioè i paesi di prima industrializzazione, avevano scoperto il problema ambientale, e in particolare ne avevano riconosciuto la dimensione planetaria. Così fu convocata a Stoccolma, nel 1972, la Conferenza internazionale sull'”Ambiente umano”. Già in quella sede, i paesi del “Sud del mondo”, avevano sollevato il problema del legame tra questione ambientale e sviluppo, benché il tema dello “sviluppo”, di per sé, non fosse in agenda. Vale la pena di ricordare l’icastica affermazione di Indira Gandhi a Stoccolma: “la povertà è la peggiore forma di inquinamento”.
Nei vent’anni successivi la questione ambientale è andata continuamente crescendo di importanza, interconnettendosi con le crisi ricorrenti dell’ordine economico mondiale (crisi finanziarie nel Sud-est asiatico, America latina e paesi africani) e con la globalizzazione della economia. Quando, vent’anni dopo Stoccolma, nel 1992, è stata convocata la Conferenza di Rio, i paesi del “Sud del mondo”, hanno chiesto e ottenuto a fatica di mettere in agenda insieme al tema dell'”ambiente” anche quello dello “sviluppo”. Così, dopo la prima conferenza mondiale sull'”ambiente” tenutasi a Stoccolma, è stata convocata una conferenza mondiale su “Ambiente e sviluppo”. Un evento storico per la partecipazione di delegazioni governative ma anche di organizzazioni rappresentative della società civile. Anche con la benedizione di Bush padre, a Rio si ottenne l’approvazione della nota “Agenda 21”, una strategia globale di gestione delle risorse del pianeta, oltre alla definizione di alcuni accordi multilaterali precisi. Tra questi possiamo citare, per esempio, l’impegno dei paesi principali responsabili, i paesi ricchi, di contenere le emissioni di gas ad effetto serra, decisione che ha poi generato il processo di approdo al protocollo di Kyoto. Ci fu anche l’impegno dei paesi ricchi (i membri del G7) di assegnare un contributo pari allo 0,7 % del proprio Pil allo sviluppo dei paesi poveri (quelli del G77).
La difficile eredità di Rio e la società mondiale a “due standard”
Nei dieci anni successivi i sogni di Rio si sono trasformati però in delusioni. Gli Stati Uniti per esempio non hanno ratificato il protocollo di Kyoto; la corsa verso il traguardo dello 0,7% del Pil è ancora ferma allo 0,22%; la convenzione sulla protezione della biodiversità boccheggia e in generale gli impegni assunti in Brasile sono scivolati all’ultimo posto della agenda politica mondiale. Perché?
Possiamo azzardare alcune cause. I cambiamenti geopolitici sopravvenuti al crollo del bipolarismo politico Usa-Urss. L’accelerazione dei processi di globalizzazione economica. Il conflitto tra prospettive locali e prospettive globali. L’ingenua fiducia nella capacità di regolare a livello mondiale con accordi separati e spesso contraddittori i tre sistemi economia-società-ambiente. Le imponenti trasformazioni nel frattempo avvenute a livello demografico (raddoppio della popolazione mondiale negli ultimi cinquant’anni e conseguenti flussi migratori) e tecnologico. Il crescente potere sugli affari mondiali delle istituzioni internazionali economiche figlie di Bretton Woods cioè il Fondo monetario internazionale e la più “giovane” Organizzazione mondiale del commercio (Wto), oltre alla crescente debolezza delle istituzioni competenti per le questioni ambientali che fanno capo all’Onu.
Senza entrare nel merito delle cause, sta di fatto che a dieci anni da Rio si constata che le condizioni del pianeta globalmente non sono migliorate sia dal punto di vista ambientale che sociale. Il pianeta è diventato sempre più squilibrato ed si è trasformato in uno spazio di “guerra diffusa”. In preparazione di Johannesburg si sono tirate le somme e si è fatta una fotografia dello stato del mondo sconfortante:
– Nei prossimi venticinque anni la popolazione mondiale aumenterà verosimilmente di circa 2 miliardi di abitanti, passando dai 6 miliardi attuali a 8 miliardi e l’aumento sarà interamente concentrato nei paesi in via di sviluppo.
– La povertà estrema (cioè uno standard di vita corrispondente a un reddito inferiore a 1 dollaro al giorno) affligge circa il 50% della popolazione dell’Africa subsahariana, circa il 40% della popolazione del Sud-est asiatico, mentre a livello mondiale globalmente non è praticamente scesa negli ultimi 10 anni restando al livello del 20% della popolazione.
– Le disuguaglianze di reddito tra i cittadini all’interno dei paesi continuano a crescere, in particolare nei paesi della America latina e nell’Africa subsahariana.
– La dipendenza dei paesi in via di sviluppo dai paesi sviluppati continua ad aumentare: l’importazione di cereali, che era insignificante negli anni Sessanta del secolo scorso, da allora è continuamente aumentata e si prevede che continui a crescere nei prossimi trent’anni.
– I consumi sregolati di acqua tendono ad aumentare e nel 2025 si prevede che metà della popolazione mondiale, cioè circa 4 miliardi di persone, concentrate in prevalenza nell’area del Mediterraneo meridionale, nell’America centrale, in Medio oriente e in Asia centrale, avrà difficoltà di approvvigionamento di acqua.
– La deforestazione negli ultimi dieci anni ha avuto un rallentamento nella America del sud, ma ha avuto una accelerazione continua in Africa.
– Globalmente i consumi energetici sono basati per l’80% sui combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) e questa percentuale continua ad aumentare. Il consumo di questi combustibili è concentrato nei paesi sviluppati, mentre nei paesi del “Sud del mondo” i combustibili dominanti sono ancora le biomasse tradizionali: 2,5 miliardi di persone dipendono per i bisogni energetici fondamentali esclusivamente dall’uso di legna, scarti dell’agricoltura, escrementi di animali.
Che cosa ci ha comunicato Johannesburg?
I giudizi sugli esiti del Summit sono molto vari: chi l’ha giudicato un insuccesso, e chi l’ha giudicato, date le premesse, un successo. Chi si è augurato un fallimento, chi l’ha snobbato, e chi l’ha preso molto sul serio e l’ha trasformato in una opportunità per far crescere una coscienza collettiva mondiale sulla non sostenibilità del modello si sviluppo dominante, quello dei paesi del G8. Schematicamente colgo tre cose importanti che Johannesburg ci ha comunicato.
1) L’equilibrio mondiale poggia su tre sistemi: il sistema economia, il sistema ambiente e sistema società degli uomini (chiamiamolo sistema umanità?). L’ordine mondiale, la sua stabilità e persistenza dipende dalla relazione tra questi sistemi. A Johannesburg si è parlato più di società che di ambiente.
2) Le visioni sull’ordine mondiale, e quindi sullo sviluppo sostenibile, e sui modi di costruirlo sono orientate da interessi locali. La compatibilità tra sviluppo locale e sviluppo globale è un nodo che non si può sciogliere senza una visione condivisa. Nonostante l’apparente egemonia del capitalismo americano, non esiste nel mondo una visione dominante sull’ordine mondiale, ma diverse visioni che provengono da diverse coalizioni di paesi, e anche da diverse coalizioni di culture. A Johannesburg ha impressionato, per esempio, il discorso di Chirac, che si è fatto portatore della visione europea e anche della visione di una grande coalizione di paesi in via sviluppo. Se Johannesburg non è stato un fallimento, nonostante il sostanziale disimpegno Usa, questo si deve all’emergere di coalizioni abbastanza forti da mettere in risalto l’esistenza di una pluralità di culture. Comunque Johannesburg ci ha comunicato anche una preoccupante realtà: la distanza tra chi vede nell’Onu (debitamente riformata) il perno della governance mondiale e di chi invece ormai punta su politiche unilaterali di stati sovrani.
3) Il problema più critico di relazione tra economia, ambiente e società, e quindi quello più critico per la sostenibilità, è il problema della proprietà dei beni comuni (i commons in inglese): aria, acqua, suolo, etere, conoscenze, patrimonio genetico naturale. L’idea riduttiva di proprietà (diritto di usare e di distruggere) canonizzata dall’economia capitalistica e funzionale allo scambio e al mercato, non sembra compatibile con una gestione sostenibile dei commons. Per esempio la “privatizzazione” di risorse vitali comuni come l’acqua è uno dei temi di dibattito più caldi portati alla ribalta a Johannesburg.
Chi è veramente interessato allo sviluppo sostenibile?
Abbiamo iniziato sottolineando lo straordinario interesse suscitato da un Summit sullo “sviluppo sostenibile”. Per molti, quelli che hanno guardato al vertice con sufficienza, con ironia o con motivato dissenso, questo interesse è mal posto, perché l’espressione “sviluppo sostenibile” non ha un contenuto chiaro.
“Sviluppo sostenibile” esprime infatti un concetto molto complesso. Da una parte sta il termine “sviluppo”: una parola che ha come sinonimi “crescita” (anche se alcuni contrappongono i due termini), oppure “evoluzione” quantitativa e/o qualitativa. Una parola entrata nel lessico politico ed economico in un particolare periodo storico, il cui inizio si può datare con il discorso del 20 gennaio 1949 del presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, in cui si definiva l’area “Sud del mondo” come “area sottosviluppata”.
Dall’altra parte sta la parola “sostenibile”. Un aggettivo che suggerisce l’esistenza di un limite allo sviluppo, che evoca l’idea di un carico che la terra non può sopportare. Aggettivo che lascia ipotizzare traiettorie di sviluppo “insostenibili”. Quindi l’idea di sviluppo viene valutata anche in una prospettiva temporale lunga, sulla base della conoscenza che abbiamo degli equilibri del nostro pianeta, dei suoi ecosistemi e della società umana, cioè delle interazioni dinamiche tra l’uomo e il suo ambiente. E’ pertanto implicita, nell’uso dell’espressione, l’assunzione che possano esserci diversi tipi di sviluppo.
Le traduzioni in altre lingue della espressione inglese sustainable development, mostrano la pregnanza della espressione linguistica originale, sottolineandone diverse accezioni: “sviluppo durevole” (francese), “capace di futuro” (tedesco), “sviluppo continuo” (russo). Anche l’accoglienza della espressione da parte di diverse correnti culturali ha suggerito qualche distinguo. Per esempio in un documento del 1998 dei vescovi italiani la parola “sostenibile” è stata criticata per il sapore malthusiano, e si è proposto di sostituirla con l’espressione “sviluppo solidale”. Un’analoga censura è venuta dai fautori di una visione economicista e tecnocentrica dello sviluppo, che considera irrilevanti e sempre superabili i limiti ambientali. Tuttavia, oltre che nella letteratura scientifica e nei documenti politici, anche negli ultimi documenti ecclesiastici ufficiali l’espressione è stata ampiamente accettata ed addirittura il “principio di sostenibilità” è stato proposto come principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa.
In conclusione possiamo dire che l’espressione “sviluppo sostenibile” negli ultimi quindici anni è comunque entrata definitivamente nell’uso comune per interpretare sinteticamente un imperativo normativo: la responsabilità dell’utilizzo e della gestione dell’ecosistema e del nostro habitat planetario nel rispetto dei diritti dell’uomo di oggi e di quelli delle future generazioni.
A chi interessa un imperativo etico di questo tipo? La partecipazione massiccia e ben organizzata a Johannesburg delle espressioni della società civile (le oltre 4.000 Ong più altri gruppi e associazioni non censiti), provenienti prevalentemente dai paesi sviluppati, ha mostrato chiaramente l’emergere di un attore internazionale sul campo della sostenibilità, che non è riconducibile ai movimenti ambientalisti né a frange radicali di movimenti politici, ma al cuore della società civile.
Antonio Papisca, in un convegno del 1999 delle associazioni che si rifanno al pensiero di Giuseppe Lazzati sul tema Costruire la Pace sottolineava il nuovo ruolo della società civile mondiale, e precisava: “Oggi, diversamente da altre epoche della storia, abbiamo tutto il movimento transnazionale della società civile globale, cioè esiste un associazionismo che opera a fini di promozione umana al di là e al di sopra delle frontiere, che non c’era nei decenni passati con la consistenza e pervasività di oggi. E’ tutto un mondo che non rende facile la strategia veterostatualistica e statocentrica dell’attuale classe governante a livello mondiale”.
Questa osservazione di Papisca, fatta a proposito dei problema della pace, ritengo sia pertinente anche per il problema dello “sviluppo sostenibile”. Ed è sicuramente una traccia per cercare di diradare la nebbia che avvolge il futuro dopo Johannesburg.
In ricordo di Angelo Gaiotti
Beppe Tognon
Libri: Una critica del “pensiero unico” dall’interno delle istituzioni economiche internazionali
Francesco Timpano