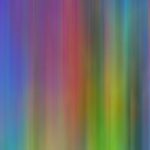Appunti 2_2002
Sommario
Paure e speranze di una città Il Cardinal Martini ha salutato Milano il 28 giugno scorso con un bel discorso in Consiglio comunale. Chi, milanese e non, ha interesse a conoscere cosa pensa, crede, spera il Cardinale sui temi della città troverà una risposta qui di seguito (il testo è in versione quasi integrale). Pubblicare queste parole a mo’ di editoriale è anche un modo per noi della Redazione di dire grazie ad un Cardinale molto intelligente e molto buono, che è stato la figura religiosa più importante – insieme con don Giuseppe Dossetti – per il nostro impegno culturale e politico di questi anni. Un gran pittore tedesco, Mathias Grünewald, ha dipinto una crocifissione con un Giovanni Battista che ha una vistosa anomalia nella mano: un dito enorme che indica il Cristo. Per noi Martini è stato quel gran dito indicatore. Per di là! Verso la Parola che annuncia una fraternità senza terrore e che impegna a costruire, laddove marcì Tangentopoli, una città degli onesti e degli uguali. (g.c.) Pubblichiamo il testo dell’intervento all’incontro tenuto a Monteveglio (BO) il 28 aprile 2002, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria conferita al giudice Antonino Caponnetto. L’amicizia che lega la nostra rivista a quest’ultimo e la rilevanza dell’intervento, ci conducono a ringraziare sentitamente l’amministrazione comunale di Monteveglio per l’iniziativa e per averci affidato la pubblicazione. Lui, con una ventina di altre persone che poi si sono ritirate, ha chiesto di andare a Palermo a combattere la sua battaglia e per quattro anni e quattro mesi ha condotto una vita di assoluto sacrificio e isolamento, una vita blindata, pagando caramente questo gesto ma pagandolo con entusiasmo. Pagando carissimamente questo gesto, perché si deve a lui tutto quell’assiduo lavoro di organizzazione ed armonizzazione che ha portato, non soltanto, alla creazione del pool antimafia, ma alla creazione, all’interno di quel pool, di un clima di collaborazione reciproca che, sappiamo benissimo, in certi uffici non sempre si riesce a mantenere. Pagando un prezzo altissimo anche in termini personali, perché sappiamo che Caponnetto, in quel periodo, per poter scaricare i magistrati dal lavoro ordinario, si è auto-assegnato moltissimo lavoro che ha portato avanti personalmente, mentre noi sappiamo che i capi degli uffici, ben di rado, affrontano direttamente le istruttorie. E quando è andato via Caponnetto? Lui che quel gesto di volontariato aveva compiuto in un’età non più verdissima e tuttavia lo aveva compiuto e portato avanti fino alle estreme conseguenze con uno slancio giovanile che è d’esempio e ammonimento per tutti noi, quando ha chiesto di poter tornare nella sua Firenze? Quando si era profilata la possibilità, anzi la quasi certezza, che il suo posto potesse essere preso da Giovanni Falcone, e fino all’ultimo momento, è stato disposto a revocare la sua richiesta di trasferimento a Firenze se non fosse stata assicurata questa successione. Soltanto quando Falcone, contando su appoggi che evidentemente poi gli sono stati tolti, gli ha assicurato la successione, Caponnetto ha accettato il suo trasferimento a Firenze. Sappiamo come sono andate poi le cose: a Falcone, per una serie di motivi, per una certa opacità, una certa inerzia del Consiglio superiore della magistratura nel seguire criteri, se vogliamo consolidati, ma non rispondenti al massimo ad esigenze di razionalità ed efficienza, preferì a Falcone un altro personaggio che, di fatto, smembrò quel pool, sparpagliò le mille componenti della maxi indagine secondo le competenze territoriali, e questo fece sì che si perdesse di vista la prospettiva unitaria da cui il fenomeno della mafia, della mafia in Sicilia, poteva e doveva essere guardato per poter essere contrastato. Durante gli anni terribili della Sicilia, durante quegli anni di fuoco e di sangue, quelli degli attentati, il presidente Scalfaro, che fu forse l’unico uomo politico che dette un sostegno morale, e non solo morale, all’azione di Caponnetto e al quale io sono fortemente legato anche per ragioni familiari, ebbe a parlare di «nuova resistenza». Di «nuova resistenza» contro l’inquinamento, da parte della mafia, della pubblica amministrazione e dei meccanismi dell’economia. Resistenza già di per sé richiama l’immagine di un valore che fronteggia l’attacco del disvalore; richiama il concetto del bene che resiste, e che si oppone, all’avanzata del male; richiama il concetto dell’umanità, dell’umanesimo, contro la brutalità; richiama il concetto progressivo che informa tutta la parte generale della nostra Costituzione ed in particolare l’articolo 3. Questo articolo non è semplicemente l’enunciato, e il riconoscimento, di una situazione di astratta e virtuale uguaglianza che caratterizza tutti gli uomini e tutti i cittadini, ma costituisce il preciso invito al legislatore, all’interprete, affinché vengano rimossi gli ostacoli che impediscono l’effettivo raggiungimento di una situazione di uguaglianza in concreto. Il mio richiamo alla resistenza è stato impropriamente interpretato, da critici improvvisati, da critici interessati a farlo, come se fosse una sorta di esortazione alla ribellione alle autorità, ribellione al governo in carica. Nulla di tutto questo. Quando io parlo di resistenza intendo un atteggiamento che ciascuno di noi deve interiorizzare ed esteriorizzare, una disposizione d’animo che prescinde da questa o da quella parte politica che sia al governo, un atteggiamento che deve essere di richiamo costante ai valori più profondi dell’umanesimo, ai valori più profondi della convivenza in una collettività armoniosa e proiettata verso il futuro. La procura di Milano e le sue iniziative erano sulle prime pagine dei giornali quotidianamente; forse dalla seconda guerra mondiale non era più accaduto nulla di simile, e lo stesso tema veniva ogni giorno dato in pasto ai lettori; ma quanto è durato questo? Un anno, due anni, non molto di più, gradualmente si è verificato un fenomeno di stanchezza che se da un punto di vista psicologico può essere spiegabile, da un punto di vista politico lo è assai meno; o magari lo è di più, perché, diciamoci francamente, non c’è nessuna forza politica, soprattutto quando arriva al governo, che guardi con simpatia e con gradimento alla possibilità che la magistratura – che oggettivamente è titolare di uno dei poteri fondamentali dello Stato – eserciti la propria funzione di controllo di legalità sull’esecutivo. Legalità non significa soltanto che esiste un corpo di leggi, un corpo di principi, a cui cittadini ed enti possono e devono adeguarsi, legalità significa anche che deve esistere la possibilità effettiva di un controllo sul rispetto della normativa, e questo controllo tocca fondamentalmente alla magistratura. Possiamo ben comprendere che chi detiene il potere, il potere vero, il potere reale, il potere economico ed alcune volte il potere di governo non è facilmente disposto a lasciarsi controllare da altre istituzioni dello Stato. La legalità, questo principio, quest’etica della legalità alla quale anche Giovanni Paolo II ha fatto richiamo nel suo messaggio del ’98 per la giornata della pace, è dunque il rispetto non solo della legge, ma anche dei meccanismi che la Costituzione e la legge ordinaria hanno posto per assicurarne la verifica. Sotto un altro profilo devo osservare che se questi critici, questi denigratori, questi calunniatori, spesso, dell’azione dei magistrati possedevano informazioni notizie o documenti su altri fatti di corruzione che non erano stati adeguatamente posti in luce, perché mai queste informazioni, notizie e documenti non li hanno sottoposti alla magistratura? Non dimentichiamo che in un paese civile la magistratura non ha il potere di setacciare, di propria iniziativa, tutto il Paese alla ricerca di possibili reati. La magistratura si muove su notizie di reato che possono provenire non soltanto dalla polizia, dai carabinieri o dalla guardia di finanza, ma anche da privati cittadini o da enti. Chi era in possesso di notizie realmente significative perché non le ha fornite? Questo io continuo a chiedermelo. Dicevo: questo attacco, quest’insofferenza verso la magistratura, quest’insofferenza verso il principio e verso l’etica della legalità, che è il solo scudo di cui possono disporre i non potenti, perché i potenti non hanno bisogno di scudo alcuno, se lo fanno da sè… Quest’ostilità, dicevo, quest’attacco contro la magistratura, ha trovato purtroppo una qualche rispondenza positiva in una parte dell’opinione pubblica, della gente comune, in un paese come il nostro dove c’è un’atavica, ma non per quest’invincibile, tendenza ad aggiustarsi un po’ le cose, a trovare il modo di uscire dalle difficoltà attraverso una conoscenza, un regalo, una strizzata d’occhio, una promessa di solidarietà in altra reciproca simile occasione. In questo paese, ad un certo punto, quando la magistratura ha mostrato che faceva sul serio e non era solo questione di scremare una classe politica o di sostituire una classe politica con un’altra, ma era questione di fondare questa nuova cultura o questo recupero della cultura della legalità nelle coscienze e nella vita quotidiana dei singoli, in questo paese, si sono manifestati sintomi e segnali di qualche fastidio: «sì, va bene, adesso avete fatto il vostro show, abbiamo cambiato una classe politica, lasciateci lavorare in pace, lasciateci attendere in pace ai nostri piccoli traffici e traffichetti»… Vediamo processi che si trascinano da anni, tra mille e mille eccezioni, quelle mille e mille che, ahimè, i ricchi possono permettersi, loro possono stipendiare avvocati che curano le loro faccende per anni, ma i poveri – e tra i poveri includo le decine, le centinaia di immigrati colti nel piccolo spaccio, nel piccolo furto, nella piccola rapina – quelli non se li possono permettere, e allora vanno in galera dritti diritti. E ancora una volta, noi assistiamo ad una giustizia che, come in tempi lontani, è una giustizia contro e non una giustizia per i cittadini, una giustizia per il potere, una giustizia che funziona soprattutto contro chi il potere non ce l’ha. Ci sono, poi, state delle ordinanze dell’autorità giudiziaria che hanno ricollocato questa legge in un contesto più ampio, l’hanno posta in relazione con altri accordi internazionali, con altri principi vigenti nel nostro ordinamento, così che quei propositi di neutralizzazione e di paralisi che erano all’origine del disegno e dell’approvazione della legge fino a questo momento non sono stati raggiunti. Abbiamo avuto la legge sul rientro dei capitali, si è detto che l’Italia aveva bisogno di rinsanguare le proprie finanze e che i soldi dovessero tornare, ma che possono tornare in Italia capitali sporchi, riciclati, provenienti da traffico di stupefacenti, da traffico di armi, e altre brutture di questo genere e pagare soltanto il 2,50 per cento per essere nazionalizzati, e in questo modo lavati e purificati, queste sono iniziative che gridano vendetta di fronte al mondo! Quando, poi, si è trattato del così detto mandato di cattura europeo, che era soltanto una modalità particolare per facilitare le estradizioni all’interno dell’Unione europea, si sono avanzate mille opposizioni ammantate di nazionalismo, del principio di sovranità, dicendo che l’Italia non può rinunciare ad un pezzo di sovranità. Tutte obiezioni che, per la verità, non solo l’Italia oppone, ci sono anche altri paesi gelosamente legati alla propria nazionalità e alla propria sovranità che ostacolano il realizzarsi di una più ampia unità a livello continentale, unità che è indispensabile, come lo è stata sul piano economico, e che deve diventare vera unità anche sul piano delle istituzioni e sul piano della repressione contro la criminalità, perché senza di questo noi saremo disarmati di fronte alla criminalità che è ormai transnazionale. La grossa criminalità dei traffici è transnazionale e se non si ottiene l’unificazione delle istituzioni, delle normative e la piena collaborazione tra tutte le componenti europee, noi non avremmo mai ragione di questi fenomeni. Questa ricerca concreta non è mai stata fatta, ebbene prima di cambiare l’esistente occorre una ricerca sul campo che ci dia ragioni non astratte e di pura e semplice geometria istituzionale, ma ragioni concrete per modificare la realtà, per mutare una realtà che fino ad oggi ha dato dei frutti positivi, perché, posso attestarlo io e Caponnetto può convalidare, il passaggio dei magistrati dall’accusa al giudizio e viceversa, è sempre servito per arricchire la cultura, l’esperienza e la sensibilità dei magistrati. E’ anche vero che c’è chi fa il pubblico ministero dai 25 anni fino ai 70 e resta un ottimo pm, e così un giudice che fa il giudice dai 25 anni fino ai 70 può essere un ottimo giudice, ma io ho verificato che questo passaggio arricchisce, fa sì che il pm acquisti e coltivi in sé quella che è stata chiamata la cultura della giurisdizione, senza la quale rischia di schiacciarsi su posizioni poliziesche. Sia ben chiaro che dicendo così non intendo assolutamente diminuire la funzione delle polizie nell’ambito delle istituzioni, quella che è la funzione necessaria e indispensabile che le polizie non possono non avere, ma il pubblico ministero deve essere colui che verifica la legittimità delle iniziative della polizia e poi le porta avanti, le coltiva con l’ausilio della polizia e le porta fino al vaglio dibattimentale, quindi è dannoso per il pm essere schiacciato o auto schiacciarsi su posizioni di supina e passiva ricezione di ciò che gli proviene dalle forze di polizia. Dobbiamo anche ricordarci che già ora esistono delle cautele per il passaggio dall’uno all’altro settore della magistratura, già occorre una permanenza di alcuni anni nel posto che si occupa prima di poter chiedere il passaggio, già ora occorre il parere di idoneità al mutamento di funzioni. Allora qual è il legittimo sospetto? E’ che la separazione delle carriere, o quella che viene chiamata, un po’ ipocritamente, la separazione delle funzioni, (come se non esistesse gia la separazione delle funzioni: io non ho mai visto un pubblico ministero scrivere sentenze o un giudice scrivere requisitorie o fare indagini) serva a distaccare il corpo dei pubblici ministeri da quelle rigide, rigorose, garanzie che la Costituzione prevede per i magistrati e, gradualmente, attirarlo nell’orbita e nell’area del potere esecutivo e del potere politico. Si dice che in tanti paesi del mondo è così: può darsi, ma ogni paese ha la propria storia, la propria tradizione e sensibilità e il proprio modo di rapportarsi verso la collettività. Ci sono paesi in cui le cose sono effettivamente in questi termini, ma sono spesso paesi in cui c’è una coesione della popolazione, della collettività nazionale, intorno alle sue istituzioni e una coscienza istituzionale da parte di chi è chiamato a ricoprire incarichi di rilevanza pubblica, che garantiscono contro il rischio di pericolosi scivolamenti. Da noi non c’è dubbio che il disegno sia quello, non per nulla è periodicamente ricorrente la proposta di sottoporre le iniziative dei pubblici ministeri e le indagini sui vari settori della criminalità a delle direttive provenienti dal parlamento. E io non posso non ricordare che questo è stato un tema sul quale Caponnetto ha discusso quando si è trattato di inventare e costruire la Procura nazionale antimafia, che nel disegno originario era previsto proprio che operasse su indicazioni e direttive fornite dal parlamento. Caponnetto mise sull’avviso Giovanni Falcone, che allora era al ministero, e questi aspetti della normativa furono cancellati. Si è parlato, anche, di una scuola per la magistratura. Peccato che questa scuola è, in questa configurazione provvisoria, appoggiata alla Corte di cassazione che certo fa parte della magistratura, ma appoggiare alla Corte di cassazione una scuola (a parte il fatto che la sezione della cassazione dell’Associazione magistrati si è ribellata a questa possibilità) significa verticizzare la magistratura e il verticismo nella magistratura è il contrario di quella soggezione del giudice soltanto alla legge che è fortemente sancita dalla nostra Costituzione. Si è parlato ancora di restituire alle polizie la loro autonomia e di staccare le polizie dai pubblici ministeri, quasi che le polizie non abbiano già ora la loro autonomia, di cui forse per la prosecuzione delle indagini non fanno abbastanza uso, perché purtroppo da quando è entrato in vigore il nuovo codice è invalsa sempre di più l’abitudine di portare la notizia al magistrato e poi di attendere le istruzioni, ma questo non è necessario, non è scritto da nessuna parte, la polizia può continuare le sue investigazioni naturalmente. Ma allontanare le polizie dalla magistratura a che cosa serve? Sopprimere o indebolire le sezioni di polizia giudiziaria a che cosa serve? Le polizie, con tutto il rispetto e con tutto l’apprezzamento affettuoso per il lavoro che svolgono, dipendono organicamente dal potere esecutivo. Se il canale attraverso cui le notizie di reato devono giungere alla magistratura è più strettamente vigilato e controllato dal potere esecutivo, questo significa che l’attività di controllo della magistratura sulla legalità del comportamento anche degli altri poteri, oltre che dei cittadini, viene ostacolata e viene condizionata da quegli stessi enti, da quegli stessi poteri che dovrebbero essere assoggettati al controllo. Resistere alla tentazione antipolitica del delegare, il far sì che altri pensino per noi, e quindi volontà di partecipare, come da Monteveglio ci viene insegnato, di partecipare a tutti i livelli in ogni momento, di portare il nostro apporto alla vita della società. E qui inserisco un’altra parola che appartiene al mio linguaggio corrente: speranza. Ma io dico che la speranza, e io sono laico, un laico che, come il cardinal Martini ci ha insegnato, sa ed è consapevole che c’è un lungo cammino che laici e credenti possono compiere insieme condividendo gli stessi valori e puntando agli stessi obiettivi; ebbene io vi dico allora, e non paia un sacrilegio, che anche noi laici dobbiamo avere fede, speranza e carità. Dobbiamo avere fede, fede nel valore dell’uomo, nel valore dell’uomo che la nostra tradizione umanistica occidentale ci ha consegnato, e noi dobbiamo accogliere nelle nostre mani e trasmettere ai nostri figli. La carità laica è il senso di solidarietà, è il senso di amore del prossimo, partecipi come siamo, tutti, della medesima umanità. Ricordo i versi di quel poeta inglese del ‘600 che diceva: «io partecipo dell’umanità, ogni uomo che muore, muore un pezzo di me, ogni uomo che viene ferito, viene ferita una parte di me, perciò quando suona la campana non chiederti per chi suona la campana, essa suona anche per te». Bene, questo è il senso d’appartenenza all’umanità che dobbiamo avere anche noi laici. E infine la speranza: significa confidare nella possibilità che le nostre azioni abbiano un esito, incidano nella realtà. Significa avere la consapevolezza che ogni nostro gesto incide nella realtà, il gesto cattivo, come il gesto buono, ma soprattutto il gesto costruttivo e se noi abbiamo questa consapevolezza che nulla va perduto di quello che facciamo e diciamo in questo mondo, questo significa aver fiducia in noi stessi e significa avere la speranza in senso laico. Voglio finire con la menzione di una virtù cardinale: la giustizia. Come ho letto la settimana scorsa su di un pannello – affrescato dal De Ferrari – nel palazzo ducale di Genova: Ut iustitia inconcussa vigeat (perché la giustizia non perisca).
Carlo Maria Martini
Leggi tutto
La città patrimonio dell’umano
Mai infatti come in questo tempo stiamo sperimentando, più ancora che la forza, la debolezza delle nostre città. Eventi drammatici che hanno toccato altre metropoli, il riproporsi recente di oscure minacce e più in generale la complessità dei processi in atto nei grandi agglomerati urbani sembrano indurre a un senso di sgomento di fronte alla difficoltà di reggere alle sfide che pone la grande città. Eppure la città è un patrimonio dell’umanità. Essa è stata creata e sussiste per tenere al riparo la pienezza di umanità da due pericoli contrari e dissolutivi: quello del nomadismo, cioè della desituazione che disperde l’uomo, togliendogli un centro di identità; e quello della chiusura nel clan che lo identifica ma lo isterilisce dentro le pareti del noto. La città è invece luogo di una identità che si ricostruisce continuamente a partire dal nuovo, dal diverso, e la sua natura incarna il coordinamento delle due tensioni che arricchiscono e rallegrano la vita dell’uomo: la fatica dell’apertura e la dolcezza del riconoscimento. […]
La città e le differenze
Noi avvertiamo la fatica di costruire la città del nostro tempo come un luogo insieme protettivo e aperto, come una specie di Gerusalemme celeste dalle molte porte. Per queste porte infatti entrano e sono entrate tante differenze disorientanti. E vi sono entrate ancor prima di quelle che noi comunemente definiamo con il prefisso di extra e a cui tendiamo ad attribuire mali che sono più radicalmente epocali e culturali. E’ stata infatti la società complessa a sancire la fine della unità di un costume comune e identificante. E’ stata la frammentazione ad essa congenita che ha polverizzato quella che prima era un’unica identità nei tanti sotto-insiemi della società, i quali aspirano ciascuno a regole particolari e diverse. Sicché l’apertura della città rischia oggi di spersonalizzarla e ogni soggetto che vi entra si sente isolato; e, d’altro canto, l’identità si rifugia, quasi per paura, nei tanti gruppi amicali paralleli che rivendicano proprie regole particolari. Così l’apertura, disarticolandosi, non arricchisce più l’identità e l’identità, parcellizzandosi, non dà senso a tutta la città. Eppure la città conserva un ruolo visibile di manifestazione dell’umano, se è vero che diventa luogo simbolico privilegiato dove si scarica il conflitto; una cassa di sfogo di scontri ideologici e perfino di disagi comuni. Ed essa ne paga forti tributi di insicurezza e perfino di sangue. E così può nascere uno spirito di fuga dalla città, verso zone limitrofe protette, verso zone franche, per avere i vantaggi della città come luogo di scambi fruttuosi e l’eliminazione degli svantaggi di un contatto relazionale ingombrante. E’ allora la città destinata a disperdersi in un nuovo feudalesimo, compensato magari dalle impersonali relazioni mediatiche? E’ destinata a diventare un accostamento posticcio tra una city, identificata dal censo e dagli affari, e molte diversità a cui si concede di accamparsi in luoghi privilegiati o degradati, a seconda dei casi? E però se l’antidoto alla città difficile diventa una piccola città monolitica assediata dalle mille città diverse, la città perde il suo ruolo di identità-apertura e si originerà una faglia di insicurezza che metterà a repentaglio gli insiemi. E’ questa, in realtà, una delle caratteristiche e uno dei limiti d’una oligarchia, non d’una democrazia, stando a Platone: «uno Stato oligarchico è non unico, ma doppio: uno dei poveri e uno dei ricchi, sussistenti entrambi nello stesso territorio, in perenne conflitto tra di loro» (Repubblica, VIII,7. 551d). Si evidenzia perciò, oggi come non mai, la difficoltà della gestione della città e del suo governo politico, e può nascere la tentazione di gestire la città limitandosi a tenere separate le parti che in essa convivono mediante una specie di paratie tecniche. Ma così la città muore e soprattutto muore il suo compito di custode della pienezza dell’umano, per cui essa era nata.
La città a misura di sguardo
Invece, proprio in forza della sua complessità localizzata, la città permette tutta una serie di relazioni condotte sotto lo sguardo e a misura di sguardo, e quindi esposte al ravvicinato controllo etico, e consente all’uomo di affinare tutte le sue capacità. Essa è infatti sempre meno un territorio con caratteristiche peculiari, e sempre più un mini-Stato dove si agitano tutti i problemi dell’umano. E’ perciò palestra di costruzione politica generale ed esaltazione della politica come attività etica architettonica. E in più ha dalla sua il vantaggio di una tradizione di identità propria. Ce l’ha in particolare Milano – e le è comunemente riconosciuta- nel ruolo del lavoro e dell’organizzazione amministrativa e di servizi, di un raccordo tra religione e strutture formative e caritatevoli, che la rendono luogo facilmente riconoscibile da chi vi sopraggiunge. Ma se si perdono le radici culturali di questa identità e si cerca solo di mantenerne vivi i vantaggi tecnici, si finisce e col perdere l’anima della identità e, alla lunga, anche i suoi vantaggi. Milano non può, nel nome dell’identità, perdere la sua vocazione all’apertura, perché proprio questa è iscritta nella sua identità, cioè la capacità di integrare il nuovo e il diverso. […]
La città e l’integrazione del nuovo
La forza di questa città […] sembra quasi che si alimenti alle radici di Ambrogio che, grande uomo di Dio, aveva saputo imporre il suo modello di intervento alla città antica coniugando rigore e misericordia. Il flagello di Ambrogio – che compare anche nel gonfalone del Comune di Milano- sembra presentare un vescovo che punisce i mali della città. E’ così, ma Ambrogio sottolinea espressamente che il flagello non è solo per la punizione, come la verga che è diretta, dura e non si adegua alle singole coscienze, ma è un segno di persuasione. Esso infatti non disarticola né separa le membra come invece fanno la spada e la scure . Il flagello produce sì dolore, ma un dolore che ridesta il corpo, invitandolo alla ripresa. La funzione del potere, religioso ma anche civile, è quindi di persuasione che può essere anche dolorosa, non di separazione. […] Si tratta di contemperare ineluttabili gesti di forza con una concomitante moderazione di potere, che non è uno stratagemma pragmatico, ma habitus di magnanimità che permetta soprattutto al più debole di pacificarsi con dignità e che per il più forte non è segno di cedimento.
La città per i deboli
E’ soprattutto ai deboli che va il nostro pensiero. E’ inutile illudersi: la storia insegna che quasi mai è stato il pane ad andare verso i poveri, ma i poveri ad andare dove c’è il pane. «Scegliersi l’ospite è un avvilire l’ospitalità», diceva Ambrogio. Ma ciò non significa un’accettazione passiva, subìta e dissennata, né l’accoglimento solo di quell’ospite che sia simile a noi: il magnanimo ospitante non teme il diverso perché è forte della propria identità. Il vero problema è che le nostre città, al di là delle accelerazioni indotte da fatti contingenti, non sono più sicure della propria identità e del proprio ruolo umanizzatore, e scambiano questa loro insicurezza di fondo con una insicurezza di importazione. E invece il tarlo è già in esse ed è qui che lo si deve combattere con lucidità, vedendo la città come opportunità e non solo come difficoltà. La città va scelta e costruita con intelligenza e con magnanimità […] .Parrebbe a volte che la città – in particolare nei suoi membri più potenti – abbia paura dei più deboli e che la politica urbana tenda a ricercare la tranquillità mediante la tutela della potenza. Non è la lezione di Ambrogio, per il quale la politica è eminentemente a servizio dei più deboli. Questo non è un invito vagamente moralistico, ma ha efficacia politica. La paura urbana si può vincere con un soprassalto di partecipazione cordiale, non di chiusure paurose; con un ritorno ad occupare attivamente il proprio territorio e ad occuparsi di esso; con un controllo sociale più serrato sugli spazi territoriali e ideali, non con la fuga e la recriminazione. Chi si isola è destinato a fuggire all’infinito, perché troverà sempre un qualche disturbo che gli fa eludere il problema della relazione: commune conversationis officium, dice Ambrogio: «comune è il dovere di intrattenere relazioni».
Reti di relazioni nella città
L’invito a creare legami di solidarietà sempre più diffusi (parentele, amicizie, gruppi sociali, gruppi culturali, gruppi ecclesiali, gruppi politici) non è solo uno sfizio di anime belle né la creazione di oasi incomunicanti. E’ l’unico modo per vincere la paura di una impari difesa isolata. Chi si prende cura del bene di tutti può sembrare, apparentemente, più esposto alle ritorsioni di avversari con cui dialoga e confligge, ma, in realtà, si cinge come di una corazza delle adesioni e delle solidarietà che non lo lasciano inerme. Di qui scende la predilezione congenita della dottrina sociale della Chiesa per i valori sociali più che per quelli individualistico-libertari cioè per i valori che permettono le relazioni, non per quelli che concedono all’individuo una libertà il più possibile estesa, ma senza responsabilità. Cercare assicurazione alle nostre paure attraverso le chiusure individuali e l’accumulo di risorse, sembra la via naturalmente più facile, resa perfino meno odiosa grazie a meccanismi finanziari che occultano le scelte economiche. Eppure non è questa per Ambrogio la ricetta per uscire dalla crisi. Da sempre, nelle epoche di angoscia, le sicurezze non risiedono in manifestazioni di potenza, che innescano catene di reazioni e di invidie; ma sono insite nei gesti di misericordia: «la misericordia non è mai delusa, ma riceve sostegno». Per funzionare, la città abbisogna di gesti di dedizione, non di investimenti in separatezza. In questa dedizione Ambrogio vedeva rivivere al suo tempo il valore della donazione civica che era tipico delle alte cariche dell’antica Roma e delle sue virtù. Agli spiriti forti ricordava l’obbligo di superare lo sterile orgoglio di casta e di ricompattare una società in via di disgregazione attorno a valori di dedizione. Solo se si riuscirà a creare con la generosità una mentalità di solidarietà, si troveranno amici nei momenti critici. All’attenzione verso gli ultimi la nostra società non si sente più oggi forse costretta, interessatamente, come nel passato, dalla paura della rabbia dei poveri, che ormai, ridotti di numero e di potenza, stentano a far sentire la loro stessa voce e a trovare una rappresentanza politica. Ma la nostra chiusura produce un male forse ancor peggiore, perché più sottile, che non la rabbia del povero: l’indebolimento dello spirito di solidarietà. Se è vero che questo indebolimento comincia a manifestarsi prima verso i lontani ed estranei, e sembra vantaggioso per chi li esclude, esso poi si approssima via via sempre più ai vicini e penetra infine, per una ineluttabile dilatazione d’onda, dentro noi stessi, punendoci quando saremo noi in posizione debole. Non ci si può illudere di arrestarlo facilmente al di fuori del nostro cerchio di interesse, tenendocene al riparo. I meccanismi della storia si riproducono inesorabilmente dentro l’uomo.
La città e le sue regole
La ricerca del bene per la città di tutti ha regole proprie di crescita attraverso le quali non si può non passare, pena la perdita della evidenza di tale bene: sono le regole del consenso dei cittadini, stabilite dalle modalità democratiche, e quelle della costruzione del consenso. Non sono pure tecniche o pure metodologie, ma sostanza stessa dell’atto libero di decisione. Esse passano per il convincimento e la pazienza, per la stessa graduazione dei valori, perfino per dure rinunce nel nome di una superiore concordia civile e sempre in vista di un bene più alto. Ambrogio, che non dimentica nella sua funzione episcopale l’uomo politico che fu, sa vedere il valore della disciplina, anche della normatività giuridica e amministrativa, e il valore delle strutture di governo, come luoghi in cui si costruisce l’uomo “dei doveri”. Egli comprende l’importanza della gradualità della legge e dell’esempio di chi più può. In ciò egli accoglie la lettura stoica (ciceroniana) del passaggio dall’ etica dei doveri all’etica della perfetta virtù, che è disposizione acquisita a fare autonomamente, e non più per direzione eteronoma, il bene. Ma anche nella fase di passaggio tra morale e mistica, Ambrogio insinua, fin dentro le regole e gli sforzi dell’etica, le ragioni del fine unitivo: le regole dell’etica, anche e soprattutto pubblica, impongono all’uomo quei comandi che rispondano alla sua natura e alle sue capacità di azione e di realizzazione di sé. La città può sciogliersi dal freddo compito di accogliere il solo principio della standardizzazione delle regole e di una democrazia puramente formale dove vige l’astratto principio che vuole tutti uguali, anche quelli che per ragioni storiche e di umanità sono profondamente diversi: gli edifici della città -dice Ambrogio- “sono i comandamenti alti e i più alti… divideteli bene [Sal. 47,14], distribuendoli secondo le capacità di ciascuno, a seconda delle possibilità che ciascuno ha di comprenderli con le proprie forze” . La possibilità di vedere, nella città, il volto amico del potere dovrebbe contribuire a promuovere una politica custode di quell’amicizia che in sede civile prende il nome di concordia e che si prende cura non solo di realizzare il programma stabilito con i propri amici, ma del terreno comune che sussiste tra questi progetti e quelli dell’altro, del cosiddetto “nemico”. Nessuna nostalgia per un trascorso, deleterio, consociativismo, che era frutto di baratti di potere. Si pensa piuttosto ad una proficua mediazione tra valori, che ha da essere costante se si vuole che non si coltivi nella città il germe della astiosa rivincita e della conflittualità perenne. […]
I cristiani nella città
Ma qui vorrei anche dire, come vescovo, una parola rivolta specificamente ai cristiani nella città. Per essi l’invito alla ricerca comune della concordia si fa più pressante, in particolare per i politici che amano definirsi cristiani, affinché possano, dentro le varie forze, rappresentare il collante d’una società che sta faticosamente cercando una sua stabilizzazione civile, in quanto essi sono portatori dell’ethos storico più congenito al nostro popolo e più identificante. Noi amiamo immaginare che i cristiani si facciano accogliere negli schieramenti di orizzonti valoriali differenziati sia per ciò che rappresentano di storia sia per ciò che garantiscono di sfondamento delle rigidità delle singole forze e di comunanza con tutti. Che venga loro tributato un pieno riconoscimento civile proprio in forza di una loro sensibilità comunionale e della connessa capacità di fungere da elementi che preservano una cittadinanza ancor fragile e conflittuale dalle cadute nell’irrigidimento contrapposto. Il cristiano oggi nella città deve interpretare quindi l’alto compito storico di creare un tessuto comune di valori su cui possa legittimamente trascorrere la trama di differenze non più devastanti. E questo sia in zone proprie di riflessione e di traduzione antropologica dei propri valori di fede sia facendoli sbocciare dentro i luoghi della diverse appartenenze politiche, dimostrando che ci si può occupare a pieno titolo, da cattolici, dei problemi di tutti, non solo con una attenzione confessionale. Non vediamo affinità con la concezione cristiana in una politica che isola i contendenti e li fa confrontare tra di loro solo nel momento elettorale. Amiamo pensare che sia possibile una politica che, pur nel rispetto di ruoli e responsabilità diversi, sia perennemente dialogica, perché vige in essa la regola del consenso che, nemmeno esso, è un dato solo elettorale, ma di cui il potere continuamente ha bisogno per legittimarsi.
La città degli onesti e degli uguali
Sia permesso infine di indicare più in generale quella strada politica efficace che è quella di dare forza e amabilità a una esistenza vissuta nel rispetto delle regole, mostrando che una vita umile e paziente, rispettosa delle leggi ed estranea alle prepotenze, non è atteggiamento imbelle, ma è umana e forte. Ma finché la nostra società stimerà di più i «furbi», che hanno successo, un’acqua limacciosa continuerà ad alimentare il mulino della illegalità e anche, sì, della microcriminalità diffusa. C’è anche un altro effetto, e forse più grave: quello che, togliendo stima sociale all’onestà, si indebolisca il senso civico, in specie dei giovani e dei più esposti alle strumentalizzazioni; e che si coltivi, anche nell’industre Milano, una classe di manovalanza criminosa, attratta dal facile guadagno. Compito culturale urgente allora – che accomuna la città con le sue decisioni politiche e la Chiesa con la sua funzione formativa- è quello di innescare un movimento di restituzione di stima sociale e di prestigio al comportamento onesto e altruistico, anche se austero e povero: «quanto è fortunata quella cittadinanza che ha moltissimi giusti». Rivedendo magari, se del caso, i criteri con i quali la società – e magari anche la Chiesa- concedono favore e attenzione, criteri che troppo spesso premiano i potenti di questo mondo. La città evidenzia le differenze e stimola la politica al suo ruolo principe di promozione dei diversi, in modo particolare dei più umili fino a che possano raggiungere una uguaglianza sostanziale. Se compito della città è la promozione di tutti gli uomini, questo si realizza non con una equidistanza astratta, ma con scelte preferenziali storiche costose. Solo queste costruiscono un costume utile alla promozione della moltitudine, e non si limitano a lasciare a gesti di sensibilità individuale, peraltro sempre meritori, la creazione d’una città amabile. Siamo convinti che la città di Ambrogio, che ha iscritta nel suo codice la consuetudine a tradurre in fatti istituzionali qualsiasi evento nuovo che in essa si produca, potrà trovare le modalità di una traduzione civile partecipata e corretta delle emergenze umane del nostro tempo e anticipare perfino soluzioni più generali e partecipate. E’ con questa fiducia e con questo augurio che esprimo i migliori auguri per il futuro di questa città per la quale assicuro che continuerò a pregare e a interessarmi con affetto e trepidazione anche da luoghi più lontani, magari da quella città di Gerusalemme che riassume in sé le speranze, le sofferenze e gli ideali dell’intera umanità.
Coscienza, legalità e resistenza per la giustizia
Francesco Saverio Borrelli Leggi tutto
Ringrazio di cuore il sindaco di Monteveglio per il privilegio, altissimo, che mi è stato concesso di partecipare a questa cerimonia, in una terra, in una regione, che da anni, da decenni, viene additata a tutta la collettività nazionale, e non soltanto a quella nazionale, come una regione esemplare per quello che riguarda la gestione della «cosa pubblica» e l’amministrazione locale. Una regione che, negli anni gloriosi della Resistenza, e della Resistenza armata, ha pagato un contributo di sangue particolarmente alto.
Ho avuto recentemente occasione di leggere, in un periodico dell’Anpi di Milano, il resoconto di un ufficiale americano, Peter Tompkins, che in quegli anni fu mandato per tenere i contatti tra la quinta e l’ottava armata, da una parte, e le formazioni partigiane dall’altra, e ci sono narrazioni agghiaccianti di episodi di guerra sull’Appennino bolognese che forse non sono sufficientemente conosciuti. In questa terra, in questa comunità, che porta ancora ben marcata l’impronta della sua civiltà millenaria ed anche di quel personaggio straordinario, semplicemente straordinario, che è stato don Giuseppe Dossetti, già professore di diritto canonico che ha combattuto la resistenza sull’Appennino bolognese e dopo è stato costituente, parlamentare nel consiglio direttivo della Dc e infine ha abbandonato la politica attiva per fondare la comunità di Monteveglio; è in questo comune, che porta ancora l’impronta di un personaggio così eccezionale, che io sono chiamato a porgere la cittadinanza onoraria ad Antonino Caponnetto.
L’eredità di un progetto
Vorrei che si percepisse una sorta di tremore, di imbarazzo, che sento nel dover svolgere questo ruolo oggi, perché di fronte a Caponnetto io sono un «fratello minore» e non soltanto per qualche anno che ci separa, ma minore perché di fronte a quella che è stata la sua vicenda, l’eroismo con cui volontariamente Caponnetto si è gettato nella lotta contro la mafia, la mia personale vicenda, quella che mi ha portato ai clamori della cronaca, è qualcosa di casuale e fortuito. Antonino Caponnetto, e non sarà mai sottolineato abbastanza, è stato un volontario della campagna antimafia. Da un posto relativamente tranquillo, dalla procura generale di Firenze, – io vengo da una procura generale e so che le procure generali sono posti di retrovia, relativamente sereni e tranquilli – e senza aspirare ad avanzamenti di carriera, Caponnetto ha chiesto di poter andare a Palermo e lo ha chiesto dopo che un terribile attentato aveva stroncato la vita di Chinnici, consigliere istruttore in quel tribunale.
Antonino Caponnetto in quel periodo, ha resistito a inframmettenze politiche, forse non numerose, perché la personalità che lui dimostrava era tale da non incoraggiare contatti che fossero meno che corretti; tuttavia ha resistito, ha protetto i propri collaboratori ed ha portato avanti questo lavoro titanico che ha dato origine al primo, serio, processo contro la mafia, il primo processo che sia stato fatto dopo la normativa del 1982, che ha creato il reato di associazione mafiosa.
Caponnetto, che durante gli anni della sua presenza a Palermo aveva conservato una discrezione esemplare, una volta andato in pensione, anche sotto la spinta emotiva della terribile stagione di sangue dell’estate 1992, ha deciso di continuare la sua opera in altre sedi e con altri mezzi ed ha iniziato un’attività intensissima, anche questa portata avanti con una fiducia e uno slancio stupefacenti in una persona di oltre 70 anni. Un’attività di diffusione di cultura civica tra i giovani che non ha precedenti, sebbene già il suo predecessore Chinnici avesse talvolta parlato in Sicilia in ambienti studenteschi, per far comprendere cosa fosse la mafia e quale dovessero essere la lotta contro la mafia.
Resistenza delle coscienze
Quest’attività straordinaria di Caponnetto si è saldata nel 1994, qui a Monteveglio, con la nascita dei comitati per la Costituzione promossi da don Giuseppe Dossetti.
Sapete che la parola resistenza mi è particolarmente cara. Con questa parola, e con il ricordo del fondamento della nostra Costituzione repubblicana nella Resistenza, ho iniziato l’ultimo discorso inaugurale alla corte d’appello di Milano. Su questa parola, su questo concetto vorrei ritornare, perché resistenza non è soltanto resistenza armata, resistenza non è soltanto la nuova resistenza giudiziaria e di polizia contro la mafia, la resistenza sotto il profilo della resistenza permanente è un concetto di carattere morale e culturale che deve accompagnare tutti noi, giorno per giorno nella nostra attività quotidiana di lavoro, di lavoro nel pubblico e nel privato, e di contributo alla vita delle istituzioni.
L’esperienza milanese
Pensiamo alla vicenda che ho vissuto per anni in prima persona: che cosa è stata la vicenda di «mani pulite» se non un tentativo di opporre resistenza alla corruzione. Una vicenda che, per la verità, ha avuto un esito paradossale. Ricordiamo tutti come nella fase iniziale (dopo un primissimo momento di sconcerto), ci fu un atteggiamento dell’opinione pubblica, della stampa e poi di una parte del mondo politico, di assoluto sostegno a quest’azione e ciò permise al pool di Milano di andare avanti, e velocemente, visto che sembrava stessero spontaneamente cadendo tutti i baluardi che erano stati posti a difesa di una situazione di corruzione sistemica. Si assisteva, addirittura, ad un fenomeno di collaborazione spontanea anche di coloro che erano stati protagonisti di quella stagione di corruzione. Ma che cosa è successo nel tempo? C’è stato un fenomeno, forse del tutto naturale, di graduale stanchezza, di graduale logoramento dell’attenzione dell’opinione pubblica.
Attacchi alla magistratura
Ed è proprio su questo versante che è iniziato l’attacco contro la magistratura, con il mettere in dubbio la purezza degli intenti che animavano la magistratura stessa, soprattutto quella milanese, nella continuazione delle operazioni di «mani pulite»: si è detto che in realtà non si trattava di un’operazione giudiziaria, ma di un’operazione politica e che i magistrati avevano in animo di distruggere una determinata parte della classe politica salvando l’altra parte. Peccato che questo non corrisponda al vero, giacché nelle nostre indagini di Milano non c’è stata parte, non c’è stato personaggio dello spettro politico che governava l’area milanese, l’area lombarda, che non sia stato investito dalle nostre indagini, e dico questo anche con una certa qual ripugnanza perché non credo che i magistrati debbano dar conto su come si è distribuita nell’area ideologico politica del paese la propria attività, che la loro credibilità passi attraverso un manuale Cencelli alla rovescia.
Per una nuova cultura della legalità
Noi italiani siamo un po’ fatti cosi, scusate se sto parlando in questo modo familiare poco cattedratico, ma dobbiamo pur guardarci in faccia…… Ed è per questo che quando parlo di resistenza, dico che la resistenza deve essere condotta contro tutto e in tutti gli ambienti, ma anche contro noi stessi, contro la tendenza alla pigrizia in noi stessi che in molte situazioni suggerisce una strada d’arrangiamento, forse la più facile, ma non sempre la più corretta. Facciamo attenzione, perché questa ostilità verso la magistratura noi l’abbiamo, in tempi recenti, vista concretarsi in atteggiamenti processuali assunti da imputati eccellenti, atteggiamenti che sono indirizzati a tutto tranne che a consentire che si arrivi all’accertamento della verità quale che essa sia, e potrebbe essere una verità di innocenza, anche se è una verità che mostra un errore da parte della magistratura.
Leggi e giustizia
Sto dicendo cose forti, ma sono cose che sento profondamente. Ma non parliamo soltanto di atteggiamenti di carattere culturale o di atteggiamenti di non collaborazione. Stiamo attraversando una stagione in cui ci sono provvedimenti legislativi, alcuni già varati, altri in gestazione o solo accennati all’orizzonte, che sono uno più sconcertante dell’altro. Ricordate certamente la vicenda della legge sulle rogatorie: grazie a Dio è una legge che è stata fatta male, tecnicamente male, e quindi non ha raggiunto l’obiettivo che probabilmente, anzi con tutta franchezza possiamo dire che chiaramente, si proponevano coloro che l’hanno elaborata. Qui viene anche da chiedersi come mai dopo la firma dell’accordo italo-svizzero del 1998, nella precedente legislatura non ci si sia preoccupati di ratificare quell’accordo e renderlo legge, e si sia offerto così il destro alla nuova maggioranza di approvare una legge che non è soltanto di ratifica di quell’accordo, ma anche di modifica del Codice di procedura penale in tema di rogatorie e che si è proposto, appunto, l’obiettivo di porre degli ostacoli pressoché insuperabili all’utilizzazione di documentazione acquisita (e Dio sa quanto faticosamente!) dalla collaborazione internazionale e in particolare dalla collaborazione con la Svizzera.
C’è anche l’incredibile legge che ha pressoché depenalizzato il falso in bilancio. In un’economia basata sul capitale (e le economie moderne sono basate sul capitale e sulla libera circolazione di capitali), consentire che le società di capitali possano commettere dei falsi, possano ingannare, non soltanto i propri diretti contraenti, ma ingannare il pubblico indifferenziato dei risparmiatori su quella che è la reale consistenza delle loro attività e la reale natura dei loro conti, consentire che possano fare tutto questo senza, o quasi, sanzioni di tipo penale è qualche cosa che pone l’Italia a livello dei paradisi societari, dei paradisi fiscali di cui, per anni, abbiamo deplorato l’esistenza. È poi in gestazione un progetto di legge, non ricordo se di iniziativa parlamentare, sulla bancarotta fraudolenta, che attualmente è punita con una pena fino a 10 anni, anzi fino a 15 con le aggravanti, per la riduzione della pena a un minimo di un anno e un massimo di tre, il che significa che non ci sarà più nessun bancarottiere per distrazione, quelli che prendono i soldi dalla cassa della loro azienda e se li portano in Svizzera, che andrà in prigione, perché con tre anni di condanna si viene affidati ai servizi sociali. Io mi chiedo se questo non sia un modo per rendere l’Italia una sorta, ricordate Salgari, di Tortue, dove si riunivano tutte le filibuste delle Antille!
Separazione delle carriere e futuro della magistratura
Passiamo a considerare altri aspetti che riguardano più da vicino la condizione della magistratura e vediamo un po’ cosa ci si propone di fare: innanzitutto, e questo viene considerato come un must come un obiettivo indeclinabile dalla maggioranza, la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudicanti. Questo è un argomento che mi rendo conto possa essere riguardato con qualche scetticismo, con un ventaglio di diverse opinioni possibili, ma c’è un’osservazione di carattere metodologico che io continuo a porgere, senza avere mai avuto il bene di una risposta seria e razionale: perché si vogliono separare le carriere? Perché il pubblico ministero e i giudicanti sono tra loro troppo vicini? Perché hanno fatto il medesimo concorso? Perché alloggiano negli stessi palazzi di giustizia e magari qualche volta vanno a prendere il caffè insieme? E perché possono passare da una parte all’altra della magistratura? Ma si è mai verificato se, e quante volte, le pronunzie dei giudici si scostino dalle richieste dei pubblici ministeri, si è mai fatto una verifica sul campo di questo? Perché quello che si vuole, da parte di chi vuol separare le carriere, o almeno che si dice volere, che cosa è? Evitare una troppo supina condiscendenza dei giudicanti rispetto alle richieste dei pubblici ministeri. Ma andiamo a vedere se esiste davvero quest’acquiescenza dei giudicanti alle richieste dei pubblici ministeri, e quante volte essa sia addebitabile ad un cedimento da parte del giudicante e quante volte la concordanza sia invece dovuta ad una perfezione di mira del pubblico ministero, quante volte ad altri fattori, o a fatti nuovi che si sono verificati nel corso del dibattimento e che giustificano la motivazione assunta dal giudice.
Verso una verticalizzazione dei poteri?
Su che cosa altro si punta ancora? Si è puntato, perché ormai è gia legge, sulla modifica del sistema d’elezione del Consiglio superiore della magistratura e sulla diminuzione del numero dei consiglieri, così che un Consiglio superiore della magistratura che già affannava a tener dietro a tutti i propri compiti, depauperato di un terzo dei propri componenti, è evidente che affannerà ancora di più, fin tanto che cospicue parti di quelle competenze che gli sono state devolute, o che il Csm si è attribuito interpretando il fondamento delle norme costituzionali, verranno inevitabilmente affidate ad altri organi e quindi sottratte all’organo fondamentale dell’autonomia dei magistrati.
Il dilemma della sicurezza: legalità o armi per tutti?
Non sto poi a parlare di un’altra singolare proposta che, per la verità, è stata soltanto il frutto dell’esternazione di un personaggio e non è stata, ancora, ospitata in nessun concreto disegno: la liberalizzazione o l’ampliamento della possibilità di servirsi di armi o di avere il porto d’armi. Questa è un’americanata! Un’americanata che negli Stati Uniti porta a conseguenze gravi, poiché il numero di omicidi volontari che ci sono lì non è lontanamente paragonabile a quelli che si verificano in Italia. Certamente incrementerebbe i fatti di sangue anche da noi, perché quelle liti che ora finiscono con un cazzottone o un naso rotto, potrebbero finire con una sparatoria, non dimentichiamocelo. Ed anche questo è un modo subdolo per acquisire la benevolenza, la comprensione e la simpatia di determinati strati della popolazione che non si sentono sicuri, e qui passiamo al problema della sicurezza: è vero, esiste un problema di sicurezza, esiste la microcriminalità, non dappertutto nella stessa misura, è vero che esistono le rapine nelle villette, parlo della Lombardia e del nord Italia, è vero che esiste lo spaccio di stupefacenti, è vero che esistono gli scippi alle persone di età avanzata che vanno alla posta a ritirare la pensione, è vero tutto questo, ed è vero certo che occorre una presenza forse più attiva delle forze dell’ordine.
È necessario, però, esporre sempre con sufficiente chiarezza e analiticità tutti i risvolti dei problemi, tutte le ripercussioni che un intervento, piuttosto che un altro, possano avere magari in regioni lontanissime, regioni concettuali intendo, lontanissime da quelle su cui l’intervento è stato spiegato, perché attraverso questa falla possono entrare delle innovazioni, ma delle innovazioni semplicemente pericolose o micidiali per il sistema.
Sirene notturne e speranze laiche
Bene, ho parlato di resistenza e sul resistere vorrei concludere: resistere a che cosa? Resistere a questa deriva cui la collettività nazionale rischia di abbandonarsi un po’ per atavico scetticismo, un po’ per pigrizia, un po’ per le fascinazioni di sirene che cantano nel mare, nel mare della comunicazione di massa, e attirano in quella direzione, conducono alla deriva verso un assetto in cui la questione morale non è più una questione centrale, non viene più addirittura percepita, e la questione della legalità si trasforma nella questione degli interessi, nella questione degli interessi che devono prevalere, negli interessi di qualcuno.
Resistere alla desensibilizzazione delle coscienze, alla desensibilizzazione in ciascuno di noi della coscienza civica intesa come la consapevolezza dell’interdipendenza di tutti i nostri legami verso gli altri individui, verso il prossimo, verso la società, l’interdipendenza di ciascuno da tutti noi.
Resistere alla tentazione della chiusura individualistica, familistica o di clan, e alla stessa tentazione della chiusura nazionalistica o di etnia.
Sono stato, una volta, rimbeccato da un giornalista peraltro laico e mio buon amico, che, avendo io parlato in un’intervista di speranza in un momento in cui sembrava proprio non ci fosse più nulla da sperare e il pessimismo dovesse prevalere, mi ha preso in giro per la menzione di questa virtù teologale.
Articolo 18: una battaglia politica densa di risvolti concreti
Alberto Guariso
Indebitamento delle famiglie e usura
Vittorio Sammarco
Focus: Democrazia in difficoltà?
Chi governa la democrazia?
Giorgio Campanini
Democrazia e peccato originale
Stefano Ceccanti
Partiti e crescita della cittadinanza
Sergio De Carli
Incredibile Sturzo! Teorico dell’obiezione di coscienza.
Giovanni Bianchi
«Valori» in corso
Sergio Slavazza
Libri: Un impero troppo perfetto
Guido Formigoni